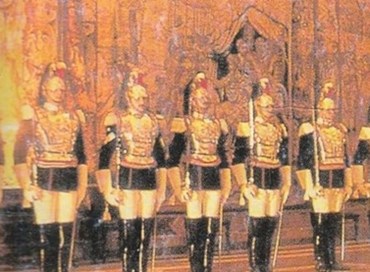
Dai classici del pensiero politico abbiamo appreso che una nazione difficilmente può dirsi tale se essa non è sostenuta da memorie, ricordi e tradizioni comuni territorialmente riconoscibili. A giudicare dal pesante clima politico e civile che caratterizza il dibattito pubblico in Italia (ciò che sta avvenendo nelle ultime settimane è solo l’ultimo capitolo di un’opera costituita da diversi tomi) viene fatto di credere che ciò che Ernest Renan intende per nazione, ossia “una grande solidarietà sostenuta dal sentimento dei sacrifici che si sono fatti e di quelli che si è disposti a fare” sia, per molti versi, ancora da raggiungere nel nostro Paese. In Italia, dall’Unità in avanti, la divisività segna qualsivoglia passaggio politico, sociale e culturale. Altro che solidarietà. Se si prendono le distanze dalle stucchevoli polemiche quotidiane, qualcosa in più sul nostro “vizio nazionale” si può cercare di capire, bussando alla porta della storia. Assumere uno sguardo lungo consente di conoscere meglio le ragioni in forza delle quali l’antagonista, con cui in democrazia ci si confronta – anche in modo aspro – per la conquista e il mantenimento del potere, viene vissuto come nemico da eliminare dalla scena pubblica attraverso una diuturna opera di delegittimazione.
“Tutte e tre le forme di regime che l’Italia ha conosciuto, liberale, fascista e democratico-repubblicana – scrive lo storico Massimo Luigi Salvadori in Storia d’Italia e crisi di regime – devono la loro origine a una guerra civile che ha mescolato in diversa combinazione, la lotta delle armi con quella dei valori, delle ideologie e degli interessi, opponendo in maniera inconciliabile forze aventi concezioni dello Stato e dei rapporti sociali antitetiche. Ogni volta che una delle parti ha assunto nelle proprie mani il controllo dello Stato, la classe dirigente non è mai riuscita ad ottenere il riconoscimento da parte delle forze di opposizione, per cui il rapporto fra di essi ha assunto un carattere di reciproca negazione”. In altri termini, i governanti non hanno mai conferito legittimità all’opposizione riducendola a entità anti-sistema, mentre gli oppositori, dal canto loro, non hanno mai visto nello Stato il luogo delle istituzioni valide per tutti, ma lo hanno sempre considerato proprietà della classe dirigente. Vi è da aggiungere che il nostro Paese è stato attraversato nei primi anni Novanta da un’altra profonda rottura, questa volta per mezzo di armi giudiziarie, che ha ulteriormente accentuato lo spirito divisivo, alimentando non di poco l’onnipresente “guerra civile latente”. La riflessione da fare è se si riuscirà mai a voltare pagina, ovvero riconoscere che l’antagonista politico non è un nemico perennemente da delegittimare, ma un avversario da combattere secondo le regole della democrazia liberale. Il clima di odio delle ultime settimane non induce all’ottimismo. Vale la pena, però, di ricordare che a volte la storia prende strade inedite e non prevedibili, spiazzando tutti.
(*) Storia d’Italia e crisi di regime di Massimo Luigi Salvadori, Il Mulino 1994, 10,26 euro
Aggiornato il 25 settembre 2025 alle ore 12:01


