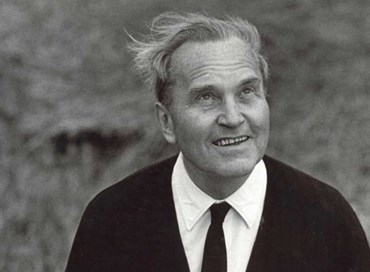
Due elementi contraddistinguono il cammino della civiltà europea. Il polemos, o istinto di belligeranza per affermare la dimensione della soggettività, e la cura dell’anima che nel tempo medievale e cristiano diventa il percorso di salvezza e di ascesi dell’anima che vuole trovare la vita eterna. Il polemos è la lotta del Bios, dell’elemento individuale che, quando non viene avvinto dalle spirali della violenza in sé e per sé, non vuole essere schiacciato dalla forza leviatanica della collettività, ma anche della collettività che non vuole essere defraudata dalla monocrazia di uno o dei pochi. Per questo l’istinto del polemos e la sua logica rimandano a quella della cura dell’anima come sua negazione dialettica. Per i greci la pratica socratico-platonica della cura dell’anima avveniva per raggiungere maggiore consapevolezza, per purificare l’anima e per entrare in un rapporto di solidarietà armonica con l’altro. Si realizzava quando il singolo e l’altro condividevano l’amore per la conoscenza, la filosofia, e si interrogavano vicendevolmente sulla natura dell’essere. Per i cristiani la cura dell’anima si declinó in una nuova forma, non più razionale e dialogica, ma come il tentativo di far riposare l’anima presso la magnificenza e la grazia di Dio, nella gloria della vita eterna.
Per gli uni e per gli altri valeva un ideale di perfezionamento, purificazione e realizzazione dell’energia vitale. Sia il polemos che la cura dell’anima avevano bisogno di un ideale divino, come garante di una vita che non si esaurisce con la morte per il primo, per l’altro come fondamento e causa finale del suo percorso di ascesi. La storia politica e della cultura europea è il racconto di questa salita, di questo erto percorso, di questa dialettica, di questo ricamo paziente che mirava alla cura dell’anima ma aveva come suo contraltare dialettico, nel senso hegeliano, il polemos, l’istinto di affermazione. Questa dialettica storica almeno a oggi ha esaurito la sua tensione costruttiva fino a un indecifrabile futuro di cui non si vedono ancora i podromi. Oggi il polemos è stato annullato e si è trasformato nella dimensione del capitalismo feroce e del mercato, dove prevalgono solo le ragioni di pochi; certo la violenza si è ridotta ma rimane poco della lotta per la soggettività, che rimane sempre più mortificata, mercificata e soggettivata a causa dell’azione di alcuni che cercano di convogliare le risorse per loro stessi.
Invece, il cammino verso la salvezza dell’anima è diventata la preservazione del corpo o della nuda vita, perché il bene metafisico si è annullato a causa della morte di Dio e del trionfo della civiltà apatica della sopravvivenza in cui viviamo. Questo stato di cose costituisce il fondamento della civiltà europea oggi, una civiltà della sopravvivenza e del trascinarsi, del ripetere ciò che vi è già stato e al più mirare la magnificenza del passato, almeno negli scarsi ritagli di tempo che il sistema mercato-centrico ci lascia disporre. Ma l’Europa non è stata sempre rinuncia e mancata volontà per il miglioramento della vita esistente. La storia d’Europa è preziosa perché ha sempre messo al centro la lotta contro il male e contro ciò che offende la vita dell’uomo e la rende più misera. Come scrive Jan Patočka la cura dell’anima è stata sempre un motore della sua storia, presente nel suo spirito.
La volontà della civiltà occidentale di purificare l’anima e renderla più profonda e capace di contenere meglio la vastità del reale, per meglio comprenderlo e soprattutto per realizzare l’immane compito di trasformare la datità in un sistema più adatto alla vita del singolo, questo è il grande retaggio dei nostri avi europei; i nostri diritti civili, la nostra libertà, il nostro benessere lo abbiamo ereditato perché riposiamo sulle spalle di quei giganti. Mai nessuna civiltà è stata così vicina alle esigenze dei singoli individui, anche in mezzo agli assolutismi e al potere degli imperi nessun governante pensò mai che lo stato dovesse vivere per lui soltanto, ma che era piuttosto in quel ruolo per rispondere a un disegno divino volto a recare progresso, benessere e ordine per le collettività che gli erano subordinate. Anche il Re Sole – “Lo stato sono io” – aveva il suo Jean-Baptiste Colbert a cui dette l’incarico di ammodernare Parigi.
Oggi la cura dell’anima rischia di essere dimenticata insieme al polemos, all’istinto di affermazione politica. Non si pensa più al miglioramento dell’esistente perché ci si accontenta di ciò che è stato già messo a disposizione, si pensa di vivere nel migliore dei mondi possibili e così la massa si nega la possibilità di ogni forma di azione politica, credendo che l’esistente sia stato migliorato già fino al suo massimo grado. Per di più ciò che resta del campo intellettuale si presta al compiacimento e alla celebrazione di ciò che è stato raggiunto, in una costante autoaffermazione dei valori di questo sistema. Si nega la possibilità di pensare a ulteriori innovazioni. Ma l’assenza di negazione, come insegna Georg Wilhelm Friedrich Hegel, è la morte dello spirito e il percorso di elevazione dell’anima avrebbe ancora molte cose da dirci. L’uomo europeo ha interrotto il rapporto con questa elevazione e si accontenta dell’esistente, ha rinunciato a pensare come migliorare il mondo in cui dimora, vive nel preomologato, la trasformazione non lo interessa.
L’azione politica per l’uomo che rimane oggi in Europa è un’esperienza che vive nel passato, insieme alle lotte e alle azioni della collettività, una collettività il cui potere è sempre insostituibile quando si tratta di cercare la trasformazione e il miglioramento della situazione data. Occorre pertanto recuperare un percorso di ascolto dell’interiorità, di capacità di far evolvere la propria coscienza, perché paradossalmente il cammino interiore, come insegnavano i greci, è possibilità di migliorare anche gli strumenti volti alla trasformazione politica. L’ascolto dell’anima ci fa dirigere verso una virtuosa strada esteriore. La cura dell’anima e il suo ascolto profondo, il non rinnegare le ragioni dello spirito e la vastità dell’essere, sono il primo contromovimento contro il nichilismo e l’apatia del nostro tempo. Raffinare l’anima vuol dire guardare verso mondi superiori, che essa riesce a comprendere, primo fra tutti il mondo delle idee dove risuonano gli ideali che tengono l’uomo lontano dal freddo abbraccio del nulla. Solo ascoltandosi e recuperando il rapporto con sé stessa, l’anima, la coscienza umana potrà raffinarsi ancora di più ed evolvere, per essere ancora una volta capace di ideare nuovi sistemi sociali e politici al passo con i tempi e capaci di generare sviluppo e miglioramento per tutti. Ma se continuiamo a vivere nell’esteriore difficilmente questo tentativo avrà successo.
Aggiornato il 19 settembre 2025 alle ore 11:39


