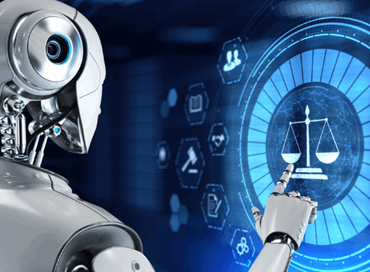
Il disegno di legge di iniziativa governativa sull’Intelligenza artificiale, approvato in seconda lettura con modifiche dalla Camera e ora al vaglio del Senato, dove è in corso l’esame in Commissione, si presenta come una svolta regolatoria. Epperò, nonostante l’apparenza moderna e i richiami alla trasparenza, il testo conferma, in buona sostanza, una vecchia logica: quella che affida allo Stato il compito di incasellare l’ignoto, disciplinare ciò che non conosce, governare persino ciò che dovrebbe emergere spontaneamente.
Il provvedimento prevede infatti la creazione di un Comitato interministeriale, la sorveglianza sugli accordi internazionali e un ampio ventaglio di deleghe al Governo per regolamentare algoritmi e metodi matematici. È l’illusione pianificatrice di sempre: quella secondo cui l’innovazione può, e deve, essere programmata, autorizzata, normata. Si ignora che proprio il disordine creativo, la sperimentazione e l’imprevedibilità hanno sempre prodotto i maggiori avanzamenti.
In particolare, procedendo alla disamina del testo, si rileva che l’articolo 11 stabilisce le condizioni per l’uso dell’Ia nel lavoro: deve migliorare la qualità della vita, tutelare l’integrità psico-fisica, aumentare la produttività senza intaccare la dignità. C’è da chiedersi: chi decide cosa è dignitoso? E perché vincolare l’uso di uno strumento a criteri tanto vaghi quanto arbitrari? In una società libera, sono le persone a stabilire se una tecnologia è utile o meno, non il legislatore.
Lo stesso vale per le professioni intellettuali: l’articolo 13 consente l’uso dell’Ia solo come supporto, imponendo l’obbligo di informare il cliente. Una norma paternalista che trasforma ogni innovazione in un sospetto, ogni automatismo in una colpa da dichiarare. Si dimentica che ciò che conta non è il mezzo, ma il risultato: se la prestazione è efficace, che importanza ha se è stata assistita da un software?
Più che regolare, il legislatore – more solito – sembra voler presidiare. L’articolo 14 consente l’impiego dei sistemi intelligenti nella pubblica amministrazione, ma solo come strumento, senza mai delegare vere decisioni. L’ideale è chiaro: una tecnologia cognitiva obbediente, trasparente, tracciabile, mai autonoma. Non un alleato per semplificare e snellire, bensì un servo sorvegliato e subordinato.
Il medesimo schema si ritrova nella giustizia. Secondo l’articolo 15, l’Intelligenza artificiale non potrà interpretare leggi né valutare prove: dette competenze restano saldamente nelle mani dei magistrati. Nessun automatismo né scorciatoia. Eppure, in un sistema giudiziario afflitto da lentezze e disparità, l’uso razionale e mirato dell’automazione intelligente potrebbe essere una risorsa. Ma l’ideologia del controllo umano prevale sempre.
L’articolo 25 riafferma poi che le opere d’ingegno devono avere origine umana. Anche i contenuti generati dall’Ia sono tutelati, ma solo se frutto del lavoro intellettuale dell’autore. Si difende una concezione corporativa della creatività, legata più al pedigree del creatore che al valore del contenuto. Il diritto d’autore diventa così uno strumento di esclusione, non di promozione della cultura.
Infine, l’articolo 26 introduce nuove fattispecie di reato: dalla diffusione illecita di contenuti di Intelligenza artificiale alla manipolazione del mercato. Ogni uso sospetto della tecnologia diventa aggravante. Come se l’Ia fosse di per sé una minaccia, un moltiplicatore di colpe. Si giudica lo strumento, non l’atto. Un approccio che ricorda la logica proibizionista: punire l’oggetto, non l’abuso.
In tutto il disegno di legge manca ciò che davvero serve: fiducia. Fiducia nella capacità dei cittadini di scegliere, dei professionisti di innovare, delle imprese di rischiare. L’Intelligenza artificiale non ha bisogno di una cornice etica imposta dall’alto, ma di uno spazio aperto in cui svilupparsi. È il mercato, non il Comitato, a selezionare ciò che funziona. È la concorrenza, non la pianificazione, a far emergere il meglio.
A rendere obsoleta questa impostazione non è solo la velocità del progresso, ma la sua natura: l’Ia è un fenomeno orizzontale, distribuito, che si alimenta della pluralità degli approcci e dell’incontro spontaneo tra domanda e offerta. Tentare di imbrigliarlo in categorie rigide significa soffocare ciò che ancora non si conosce. È l’ennesimo esempio di un potere che si illude di governare la complessità vietandola.
Aggiornato il 25 luglio 2025 alle ore 15:40


