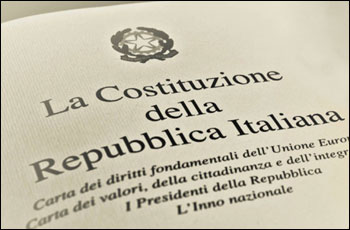
C’è qualcosa di classico nel pamphlet di Federico Cartelli “La Costituzione più brutta del mondo” che fa il verso ad una nota lezione televisiva di Roberto Benigni in cui era affidata ad un comico professionista la difesa della Costituzione; perché, tenuto conto che le costituzioni non sono opere artistiche da giudicare in base a criteri estetici (brutto/bello), ma semmai storici e politici, giustamente mutuando tale bizzarro criterio di giudizio, lo rovescia nel suo contrario: la costituzione più brutta del mondo. E lo argomenta già dal sottotitolo “perché tutti i problemi del Paese derivano dalla Carta”, forse un po’ esagerato – dato che fa credito al diritto di danni maggiori di quanti ne possa arrecare, ed effettivamente arrechi – ma comunque è sicuro che la Carta ne ha creati, e ancor più aggravati – molti. A cominciare da quelli indiretti: ha incentivato il conformismo intellettuale di più generazioni di politici, giuristi, clientes vari. Conformismo che è la versione “culturale” di quella servilità che, all’assemblea costituente, Vittorio Emanuele Orlando attribuiva alla classe politica emergente della Repubblica, e che non sarebbe stata più smentita. Come scrive Cartelli: “Spettacoli televisivi di prima serata, manifestazioni di piazza, ampollose dichiarazioni di giuristi, politici, commentatori che non perdono occasione di ricordare il carattere inviolabile e intoccabile della Costituzione: un’autentica liturgia, volta a indottrinare le menti”.
Ma tale coro di osanna non copre la realtà, aggiungiamo noi, dato che è evidente la disaffezione del popolo italiano dalla Costituzione e dalla classe dirigente che ha contribuito a selezionare e che la sbandiera da un talk show ad un altro. Salvo poi, cosa su cui nel pamphlet Cartelli non si diffonde, a farne un’applicazione selettiva, e così, spesso, peggiorativa. Distacco che è misurato sia dal progressivo crescere dell’astensionismo elettorale, sia dall’esito poco confortante del referendum specifico che anni fa respingeva le modifiche alla Costituzione, e confortato una maggioranza di “no” pari a poco più del 30 per cento del corpo elettorale: se il consenso alla Costituzione è questo, c’è poco da stare allegri per i sacerdoti della medesima. In quattro stringenti capitoli (tra quello introduttivo, la “Bibbia laica” e quello conclusivo), l’autore censura illusioni, contraddizioni, incongruità di punti fondamentali della Costituzione: il lavoro (che non è creato dalle costituzioni, ma dall’operato dei cittadini), la ricchezza (che non è una colpa in se, mentre alcune norme costituzionali la adombrano), la libertà (spesso sacrificata, in molti casi per eccesso di uguaglianza), la sovranità che, anche grazie all’assetto dei poteri pubblici, voluta dal costituente, non appartiene al popolo, ma ai poteri forti, nazionali ed esteri.
Diversi ma tutti connotati dal non essere, ovviamente, né nominati dal corpo elettorale né responsabili verso il medesimo. Nella conclusione “Quale futuro”, Cartelli fa un’analisi realistica e storica della Costituzione repubblicana che è quanto più distante dall’agiografia costituzionalistica corrente; caratterizzata questa dal non essere né realistica, né sensibile alle lezioni della storia. Scrive l’autore “Triste destino, per il nostro Paese: da un lato, i custodi della Costituzione sacra e inviolabile; dall’altro, dilettanti allo sbaraglio che periodicamente impastano commi e articoli come dei fornai, con risultati il più delle volte scadenti… non è certo casuale che alla crisi della costituzione materiale corrisponda la crisi dei partiti e del sistema di rappresentanza. L’interesse generale del dopoguerra era ricostruire un Paese sconfitto, devastato e diviso… Quest’impianto valoriale e programmatico ha il suo compimento e climax col boom economico, quando industria e settore terziario divengono i nuovi perni dell’economia a scapito dell’agricoltura”. Ma quando a seguito della crisi petrolifera degli anni Settanta finirono le vacche grasse avvenne “la crisi del modello politico, sociale ed economico sancito dalla Costituzione.
Ammetterne una prematura sconfitta sarebbe stato impossibile; è così iniziato il circolo vizioso – visto nei capitoli precedenti – fra aumento incontrollato della spesa pubblica, consenso elettorale e debito pubblico, allo scopo di continuare a proporre il medesimo modello di sviluppo del dopoguerra” e su questa strada si è continuato, in peggio, con il collasso del comunismo e le ripercussioni che ha avuto (anche) in Italia (vedi Tangentopoli, tra l’altro). “La caduta del Muro di Berlino ha completamente ridisegnato gli equilibri internazionali nei quali era stata calata la Costituzione postbellica. Usciamo dall’ipocrisia. Smettiamo di fingere che non siano mai passati quasi settant’anni. Una Costituzione armistiziale scritta sotto tutela delle potenze vincitrici non può più reggere il passo con le sfide del mondo globalizzato”. Occorre un cambiamento radicale dello Stato: “senza cambiarne il cuore pulsante” non si va da nessuna parte; non è “sufficiente qualche ritocco per trasformare l’Italia in un Paese moderno… Al pensiero unico che ci sta portando nel baratro, va opposta la forza di un rinnovato mercato delle idee, senza paure o timori reverenziali; va opposta una scelta di libertà”. E, occorre aggiungere, speriamo che, all’epoca di twitter, ci sia ancora una élite con il coraggio di pensare e volere il bene comune.
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 21:47


