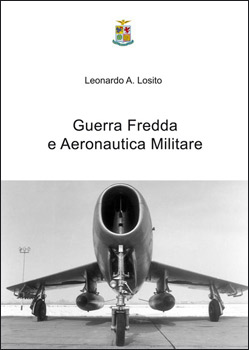
Avrei potuto recensire il libro di Leonardo Losito “Guerra Fredda e Aeronautica Militare” ma, l’autore dell’opera mi capirà, ho preferito la via di mezzo cara a noi “classicisti”. La lettera all’amico, privata ai tempi del venexiano esule in Polonia, pubblica nell’Era del villaggio sociale (permettetemi questo francesismo, odio i “social network”). Premetto che di tutto il libro m’ha emozionato la parentesi politica, che vedeva come attori degli italiani indimenticabili. Gente di Prima Repubblica, che si trovava suo malgrado a gestire una nazione (l’Italia) linea di confine con l’Est. In quella logica, di mondi e uomini contrapposti, fiorivano ideologie e radicalizzazione, e nulla s’annacquava. Confesso non poca nostalgia di quella chiarezza politica, in parte comprendo chi rimpiange la “Guerra Fredda” (nel libro non si palesa questo), con i suoi schemi geopolitici, con l’arguzia dei governanti, con quell’abilità di non lasciar nulla al caso che tanto manca nell’attuale politicame. Poi il ricordo di Amintore Fanfani, che ebbi la fortuna di conoscere tanti anni fa (sono ancora amico di suo figlio Giorgio): non certo per questioni di “Guerra Fredda” ma per un’opera sulla riforma agraria nel Mezzogiorno d’Italia. Confesso di averla buttata in lettera perché l’opera di Losito ha fatto emergere in me una certa “ostalghia”, come direbbero certi slavi (più forte d’una banale nostalgia).
Contribuiscono a far avvertire questo sentimento alcuni passi, come che “Moravia partecipò al congresso degli scrittori dell’Unione Sovietica. Viaggiò spesso in Unione Sovietica e, anche se fu molto critico verso lo Stalinismo, alla fine rischiò di definirlo quasi come un evento naturale, una sorta di deformazione fisiologica alla quale ci si deve abituare”. E l’autore gira il coltello nella piaga pubblicando uno stralcio di “Le quattro mura intorno alla Russia” (pubblicato sul Corriere della Sera il 17 settembre del 1972): “Ma come non verrebbe in mente di separare Machiavelli dal Duca Valentino e da Leone Decimo, Shakespeare dalla Regina Elisabetta e Sofocle da Pericle, così non possiamo separare Puškin, Gogol, Dostoevskij, Tolstoj, Čechov dai decabristi, da Bakunin, da Trotsky, da Lenin e, purtroppo, dallo stesso Stalin. La stessa tensione spirituale, la stessa schizofrenica creatività accomunano artisti e uomini politici. La società russa durante l’Ottocento fu, insomma, un vulcano in stato di parossistica attività. L’ultima e più violenta esplosione fu la rivoluzione. Poi, per continuare la metafora, la cenere e i lapilli dello stalinismo ricoprirono e soffocarono ogni cosa”.
In queste parole la profonda verità, cioè l’Occidente, s’era investito della missione (tanto radicale negli Usa, soprattutto in California) di evitare che le componenti culturali, letterarie, che avevano favorito la rivoluzione d’Ottobre potessero pervadere il sistema capitalista. Ecco che l’Italia veniva aiutata a sfornare quella “sana gestione democristiana della cosa pubblica” (parafrasando l’entrata in politica di Rocco Buttiglione, figlio del generale Buttiglione che visse quei momenti). L’argine culturale democristiano avversava il comunismo e tentava anche di pervaderlo con metodiche cattoliche, pensando così di sconfiggerlo. “La zona grigia si tinse infatti di rosso durante il Sessantotto - riflette Losito sugli intellettuali - che era fondamentalmente antimilitarista: i movimenti di lotta studentesca e operaia che non riuscivano ad essere rappresentati dal Partito Comunista Italiano tentarono di costruire un pericoloso percorso alternativo alle Istituzioni. Lo stesso scrittore che individuò quella zona grigia, Elio Vittorini, già citato con il suo volume “Uomini e no”, sviluppò un discorso critico sul Pci del dopoguerra e sanzionò la figura dell’intellettuale organico, dimostrandone l’inattualità e l’intima pericolosità. Fino al punto di accendere le polveri della famosa polemica con Togliatti. Vittorini - ricorda Losito - promosse un laboratorio interessante fuori dal Partito Comunista con la rivista ‘Il Politecnico’ e gettò le basi per un movimento di intellettuali indipendenti di sinistra. Il suo encomiabile lavoro non fu valorizzato abbastanza. Purtroppo, dopo il maggio parigino, i giovani italiani, che si ponevano contro le Istituzioni, lessero molto Jean-Paul Sartre e le sue teorie deliranti ma molto poco Elio Vittorini”.
Veniamo alla tua abilità, caro Leonardo, che hai saputo condensare in un unico volume la storia italiana politica e culturale, ma anche quella della nostra industria aeronautica, bellica. E riconosco che affascinare il lettore con la “logica dei trattati”, le basi missilistiche, la “Mutual defense assistance act” è arduo se non si condisce il tutto con la follia degli intellettuali che in quel sistema di “Guerra Fredda” diedero il meglio di sé: anche perché all’epoca nei giornali si veniva pagati, e chi padroneggiava la penna serviva ad entrambe le cause. E per questo, caro Leonardo, confesso che “dopo il Muro” forse non c’è stato ancora nulla di letterariamente coinvolgente. Nulla che possa alimentare una bella narrazione. Siamo figli del secondo Novecento, della “Guerra Fredda”, e da scrittore ammetto che è l’ultimo periodo che può alimentare le nostre narrazioni.
Aggiornato il 06 aprile 2017 alle ore 16:54


