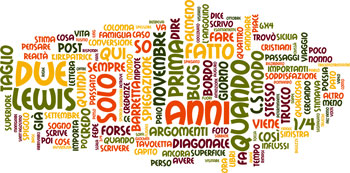
“Silenzio! La seduta è aperta. Chi è l’imputato?” “Lei, Vostro Onore”. “Cancelliere, come si permette?”. “Volevo dire…”. “Eccomi, Vostro Onore: io sono Lei”. “Bene. Declini le sue generalità”. “Io sono figlia di Vostra Signoria”. “Andiamo, andiamo, non dica sciocchezze, cosa c’entro io?” “Non mi riferivo a Lei, Vostro Onore, bensì a un’astrazione, con la quale anticamente si designava non la persona ma la categoria a cui la persona apparteneva. Signoria è un insieme di signori, cioè di persone ragguardevoli. E’ quella la mia matrice, io vengo da lì, da quella gran dama della Signoria”. “E la sua città?” “Non ne ho una particolare, perché a quell’epoca di Signorie ce n’erano tante: la Signoria degli Scaligeri a Verona, la Signoria dei Visconti a Milano, dei Medici a Firenze…”.
“Sappiamo, sappiamo. Basta così. La parola a Voi”. “Grazie, Vostro Onore. Io ho citato in giudizio Lei perché quando parla con me mi dà del lei, e ‘lei’ è una tipologia ambigua, equivoca, non si sa se sia maschio o femmina, o meglio è maschio e femmina insieme: un ermafrodito!”. “Anche ‘voi’ è maschio e femmina, quindi anche lei è ermafrodito”. “Io sono neutra: c’è una bella differenza!” “Vi prego di misurare le parole!” “Vostro onore, io, oltre ad essere più anziana di Lei (vengo infatti dall’epoca dei comuni), ho una certa notorietà, dunque pretendo che mi si dia del voi, quale appunto io personalmente sono. Del resto anche i francesi si danno del voi, senz’alcuna distinzione di ceto”. “Affari loro, quella è un’altra lingua! Per me ‘voi’ è plurale, non singolare: dire voi a una sola persona è uno strafalcione”. “La parola alla Pubblica Accusa!” “Grazie, Vostro Onore.
Voi, la mia cliente, ha ragione. Quando ci rivolgiamo a una persona autorevole noi diciamo ‘Vostra Eccellenza’, ‘Vostra Maestà’, ‘Vostro Onore’. E dovremmo darle del voi, non del lei. E invece diciamo: ‘Vostra Eccellenza ha ragione’, quando dovremmo dire ‘Vostra Eccellenza avete ragione’. “A me ‘Vostro Onore avete ragione’ non l’ha mai detto nessuno. Tutti, parlando con me, mi hanno sempre detto ‘Vostro Onore ha ragione’. Comunque, vada avanti”. “Se ho ben capito l’imputata è figlia di un’astrazione, la Signoria.
Ma Lei ci deve dire come e perché da Signoria è venuta fuori Lei. I personaggi importanti furono sempre trattati col ‘voi’, come fece Dante con Farinata, ma anche con Beatrice e col trisavolo Cacciaguida, a proposito del quale nel canto XVI del Paradiso il divino poeta osserva che l’uso di tale pronome onorifico risale addirittura al tempo dell’antica Roma, quando il popolo, ammirato ma anche impaurito per le tante vittorie di Giulio Cesare, si rivolse a lui col ‘voi’: ‘Dal voi che prima Roma sofferìe / in che la sua famiglia men persevra, / ricominciaron le parole mie’.
Ora, se ho ben capito, le cose andarono così: la femmina, incorporatasi nel maschio, nel signore, lo infemminì, e ne nacque la Signoria, che a sua volta generò Lei, quale facente funzione della Signoria. Del resto la Genesi dice che Dio creò Adamo maschio e femmina, a sua immagine e somiglianza, il che vuol dire che pure Dio è maschio e femmina insieme. “Non trascendiamo, non trascendiamo!”. “Ora, il ‘lei’, generato dalla Signoria, si è appiccicato anche alle astrazioni femminili più solenni, come ‘Maestà’, ‘San¬tità’, ‘Eminenza’, ‘Ec¬cellenza’, personaggi a cui ci si rivolge appunto non col ‘voi’ ma col ‘lei’. E qui sta l’errore, il pasticcio. Già se ne avvidero i Puristi, i quali non dicevano ‘Sua Maestà il Re’, ‘Sua Santità il Papa’, ma ‘la Maestà del Re’, ‘la Santità del Papa’ e così via”.
“Vorrei ricordare al collega, che quelle astrazioni femminili della persona - che a quanto pare sono state il primo passo nel processo di emancipazione della donna per la parità dei diritti con l’uomo - appaiono per la prima volta nel Decamerone del Boccaccio, in cui si legge di uno che dice alla sua donna: ‘Anima mia, io intesi che vostro marito non c’era, sicché io mi son venuto a stare alquanto con esso lei’. Che poi alcuni corressero in esso voi, visto che prima il Poeta aveva detto ‘vostro marito’”. “Vostro Onore, chiedo la parola”. “Dica, Voi. Anzi, dite, dite”.
“Io, oltre che una giornalista, anche se non all’altezza di Lilli Gruber, sono pure un’esperta di lingua, non come Tullio De Mauro, per carità, ma diciamo che me la cavo. Ebbene, noi non ce ne accorgiamo ma quando ci diamo del lei ci rivolgiamo alla ‘signoria’ di colui o di colei con cui parliamo, e conversiamo con la signoria di lui, o di lei, il che è quanto di più barocco e di più balordo si possa immaginare. Giustamente l’Ariosto si lamentava che il titolo di Signoria si desse persino alle prostitute. Rivolgendosi allo staffiere di un Monsignore il Poeta si doleva di doverlo chiamare signore invece di fratello, ‘poiché la vile adulazion spagnuola / mise la signoria fin nel bordello!’. E lo staffiere gli rispondeva in spagnolo dandogli del ‘voi’, traduzione italiana di ‘usted’, che corrisponde al nostro ‘vossignoria’, una forma di cortesia così diffusa che la pretendevano persino i facchini”. “Vostro Onore!...”. “Dica, Lei”. “Mi permetto di fare osservare che oggi ‘vossignoria’, come ‘vossìa’, che ne è la forma sincopata, si usa quasi esclusivamente in Sicilia, e io, oltre che una repulsione istintiva, ho persino paura a pronunciarla quella parola”.
“E perché?” “Perché odora di mafia. Non si potrebbe bandirla dal vocabolario? Quasi quasi la denuncio”. “Silenzio! Il pubblico è pregato di non battere le mani: qui non siamo a teatro. Sentiamo l’arringa dell’Accusa”. “Grazie, Vostro Onore. Riassumendo, dirò che Lei è un impaccio sintattico…” “Un impaccio sintattico a me?! Ma, dico, siamo impazziti?” “Vostro Onore, mi riferivo all’imputata, Lei, per l’appunto. Un impaccio, sì, un impaccio, dicevo, per il quale ‘lei’ fa tra chi parla la parte del terzo incomodo. E lo dimostra l’ambiguità in cui trascina i costrutti, dato che ‘lei’ può riferirsi tanto alla persona a cui parliamo quanto ad un’altra della quale si parli. E la stessa ambiguità è dimostrata dallo scambio di genere della particella pronominale femminile ‘le’, quando passa a ‘gli’ maschile, come fa il Verga quando dice: ‘Le belle ragazze di qui a quelle di Napoli non sono degne di portargli le scarpe’.
Non parliamo dell'incertezza sessuale a cui sono condannati i participi, quando si tratta di uomini: ‘Lei è invitata’, o ‘invitato’? ‘Stimata’ o ‘stimato’? Se parlo ad un uomo dirò ‘la signoria vostra si è illusa o si è illuso’? Lo stesso vale per l’espressione ‘caro lei’. Se io mi rivolgo a lei, caro collega, devo dire ‘caro lei’ o cara lei’? Insomma, prevale la femmina o il maschio? Perché se la persona è un maschio l’aggettivo si deve mettere al femminile? Quando la femmina, per sua natura, dev’essere ‘succuba’ dell’uomo, come diceva San Bernardino da Siena, cioè stare sotto, non sopra. Oggi si dà troppa importanza alla donna. Si comincia con la signoria e non si sa dove si va a finire”.
“Basta così. Dò lettura della sentenza. Ascoltate le ragioni delle due parti, udite le arringhe dell’Accusa e della Difesa (che sono anch’esse due astrazioni femminili, ancorché rappresentate da uomini), ritengo, cioè riteniamo di dover giudicare Lei, l’imputata, solo in quanto si è rifiutata di dare del voi a Voi, che ha il legittimo diritto di pretenderlo quale persona di spicco, di valore. Da parte sua Voi non può pretendere che Lei venga condannata tout court. Pertanto esorto, cioè esortiamo, sia Lei che Voi ad avere un po’ di pazienza perché il problema sarà presto risolto con l’uso generalizzato del ‘tu’, già largamente diffuso nella Rete attraverso mail, facebook, twitter e altre simili diavolerie. Del resto persino a Dio diamo del tu: ‘Dacci oggi il nostro pane quotidiano’. E con questo la seduta è tolta. Buon pranzo a tutti!
Aggiornato il 06 aprile 2017 alle ore 15:25


