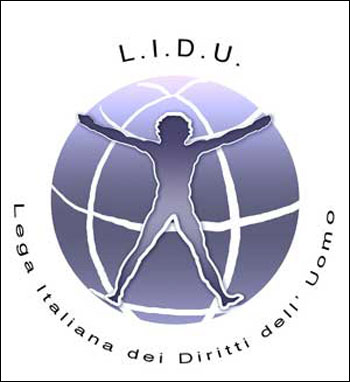
Nuovi contributi e contenuti in virtù dell’accordo realizzato con la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo che prevede uno spazio settimanale sul nostro giornale dedicato alle attività e approfondimenti a cura della Lidu.
Cittadini contribuenti in libertà vigilata
di Riccardo Scarpa
Il ministro dell’economia, Fabrizio Saccomanni, mena vanto in quanto, a suo dire, dall’inizio di questo mese, l’Italia sarebbe la Nazione all’avanguardia nel mondo nel controllo dei movimenti economici dei proprî cittadini. Ogni nostro movimento bancario e pagamento, anche in osteria o dal barbiere, entra in una grande banca dati, interconnessa ed incrociata, che fotografa le nostre tasche, al centesimo. Naturalmente questo Stato di polizia tributaria viene esaltato in nome della lotta all’evasione fiscale, ma la scusa per ogni autoritarismo è quella di evitare che qualcuno possa avere troppa libertà per mal agire. Anche la Santa Inquisizione torturava e mandava al rogo per impedire agli eretici di compromettere l’ortodossia dei fedeli e dannarli alle fiamme dell’inferno, che sono eterne e non temporanee come quelle della pira in Campo de’Fiori. Uno Stato libero deve perseguire il crimine, a tutela della legge e dell’ordine, garanzie della civile convivenza, e l’evasione fiscale è un grave reato, in quanto si sottraggono le risorse per garantire la difesa della Nazione, la pubblica istruzione, la cura dei malati, la conservazione di musei, monumenti e biblioteche e quant’altro. In uno Stato libero, però, s’indaga sugli indiziati d’un reato, non su tutti i pacifici cittadini. Insomma, lo Stato di polizia tributaria ritiene gravemente indiziati tutti i suoi cittadini; tanto vale che metta a tutti il braccialetto elettronico! A fine anni settanta il Prof. Giuseppe Sperduti riferì, in una conferenza alla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, che la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva fatto svolgere un’indagine sul commercio di elenchi d’indirizzi che alcune organizzazioni fornivano alle imprese per inviare, in modo mirato, materiale pubblicitario. Saltò fuori che una di queste dette poteva fornire indirizzi di persone omosessuali residenti in tutta Europa. Quando coloro che svolsero l’indagine chiesero come si era potuto venire in possesso d’un dato personale così riservato, la risposta fu che l’orientamento sessuale era stato agevolmente dedotto incrociando i dati sugli acquisti che i soggetti erano soliti fare. Questo è abbastanza indicativo di quanto del nostro vissuto sia oggi, per vanto di Fabrizio Saccomanni, sotto l’occhio vigile dello Stato di polizia tributaria. Da un lato, così, l’ordinamento ha statuito tutta una serie di norme a tutela del diritto alla riservatezza nella vita privata, dall’altro lo Stato si è dotato dello strumento per spiarci fin sotto coperte e lenzuola. Per questo la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo ha deciso una vigilanza attenta su questa realtà.
“Finanza globale e diritti umani” . Quali diritti in tempo di crisi?
di Tiziana Primozitch
“L’economia globalizzata è diventata un mostro cieco perché in balia dei meccanismi della finanza e non più frutto di scelte politiche che mettono al primo posto i diritti dell’uomo”, così Roberto Vismara in apertura dell’incontro dibattito che si è tenuto nella sede della Lidu onlus, venerdì scorso alle 18. L’appuntamento, il primo di un ciclo di incontri promossi dal Comitato Roma Lega italiana diritti dell’Uomo, offre lo spunto per analizzare i meccanismi che hanno prodotto la crisi economica attuale, con una chiave di lettura che da priorità ai diritti umani, base fondante di ogni democrazia sostenibile. La relazione proposta al pubblico presente in sala da Virgilio Ballerini, docente di Matematica Attuariale e Tecnica Bancaria alla Sapienza, ha ripercorso le tappe che hanno trasformato il mondo della finanza nel peggior tiranno che il mondo globalizzato potesse meritare. “È con lo sviluppo del mercato globale che la finanza si è sviluppata rapidamente – sostiene Ballerini – in particolare con la concessione di mutui subprime che nel settembre del 2008 portarono al fallimento improvviso della banca d’affari americana Lehman Brothers. In poco tempo altre 24 banche d’affari seguirono il destino della Lehman in Usa e furono declassate per limitare il danno. Ma ormai si era innescato il meccanismo di crisi”. Ma perché la finanza ha decisamente determinato una crisi economica così virale per l’intero pianeta? “Bisogna anzitutto intenderci sul significato della parola finanza – spiega Virgilio Ballerini – Esistono tre tipi di finanza : quella pubblica che si occupa della ricerca ed impiego di risorse finanziarie a favore della PA, la finanza aziendale intesa come ottimizzazione degli impegni finanziari per la produttività che ha comportato gli errori della finanziarizzazione negli anni 80-90 consistenti, dati gli alti rendimenti in titoli, di investire le risorse derivanti dagli utili conseguiti nella costituzione di portafogli invece che nelle attività aziendali. Infine la Finanza propriamente detta che nella comune accezione si definisce come le modalità di allocazione del denaro tra usi alternativi, al fine di massimizzare la propria soddisfazione”. La crisi in atto origina dunque dai mutui e carte di credito subprime. Si tratta di prestiti concessi ad un soggetto che, non avendo merito creditizio per la mancanza di un lavoro stabile o avendo avuto problemi pregressi di inadempienze nella sua storia di debitore (pignoramenti fallimenti e ritardi), non può accedere ai tassi di interesse correnti di mercato, ma subisce una penalizzazione in funzione del maggior rischio corso dalla banca. “L’origine della crisi è lontana, si era nella metà degli anni ’90 e le banche americane, spinte dalla revisione del Community Reinvestment Act che portava a valutare le strutture bancarie in funzione del numero di prestiti offerti a cittadini a basso reddito per una migliore integrazione degli strati più poveri della popolazione (ispanici, afroamericani ed immigrati in generale) – riferisce il professore Ballerini – La successiva insolvenza di massa di questi mutuatari, per lo più senza un lavoro fisso e aggravata dalla crescita dei tassi di interesse, ha innescato il processo che oggi domina i mercati finanziari e di conseguenza l’economia ormai globalizzata”. In questo senso grandi sono le responsabilità delle banche che, forti dei crediti in portafoglio, hanno sui mutui emesso titoli che a loro volta ne hanno generati ulteriori, di genere diverso ma sempre sulla stessa base (i mutui sottoscritti), attraverso la cartolarizzazione; la finanza creativa ha contribuito a peggiorare le cose producendo ancora una ulteriore massa di titoli derivati, ma sempre gravanti sulla stessa base: il credito vantato sui mutui concessi senza garanzie. “Quando il mercato ha iniziato ad innalzare i tassi di interesse – continua la relazione di Ballerini – coloro che avevano ottenuto un mutuo sull’abitazione si sono trovati nell’impossibilità di corrispondere la nuova rata rivalutata e quindi hanno subito la perdita dell’immobile. L’eccesso di immobili tornati in possesso delle banche ha sgonfiato la bolla immobiliare del costo delle abitazioni che, per eccesso di offerta, hanno ridotto sensibilmente il loro prezzo facendo venir meno alle banche il valore della base sulla quale avevano emesso i titoli di cui sopra. Grazie alla interconnessione dei mercati finanziari globali il rischio di credito associato ai mutui subprime è stato trasferito ai mercati finanziari globali e quindi anche agli investitori europei”. Così nasce la crisi finanziaria che dal 2006 ha prodotto i suoi effetti nefasti sia sull’economia degli Stati Uniti che sull’intera economia mondiale ed in modo maggiore sui paesi maggiormente sviluppati. “L’effetto domino sui titoli emessi su altri titoli, ormai a valori azzerati, gravanti sulla stessa base (sempre i crediti ormai svalutati nei confronti di coloro che avevano avuto accesso ai citati finanziamenti, compresa l’emissione di carte di credito subprime) ha fatto cadere come un castello di carte ad una folata di vento il sistema di finanza creativa messo in atto con l’effetto di traghettare la crisi finanziaria oggi in corso sull’economia reale”. Tra le vittime più illustri dal settembre 2008, mese in cui si sono verificati gli effetti peggiori, si annoverano la Leheman Brothers, che fallisce, e Goldman Sachs e Morgan Stanley che da banche d’affari divengono banche ordinarie grazie al massiccio intervento del Governo Usa che veniva costretto ad intervenire per far dimenticare l’assoluta mancanza dei necessari e indispensabili controlli omessi sino a quel momento. Palliativo anche la multa da 13 miliardi di dollari inflitta a JP Morgan. Gli effetti del caos generato nell’intero sistema sono sotto gli occhi di tutti, il crollo dell’economia reale, peraltro non ancora ai minimi, le aziende in crisi, i conseguenti licenziamenti stanno costruendo giorno per giorno uno scenario sempre più fosco. E in Italia? “La finanza pubblica deve far fronte ad un costo annuo della macchina burocratica nazionale per 15 miliardi di euro l’anno. Municipalizzate, consigli di amministrazione, poltrone e poltroncine gravano da sempre sulle casse dell’erario e sulle tasche degli italiani – continua Ballerini – l’ultimo censimento registra 7800 società pubbliche: un numero già cresciuto dell’8% rispetto allo scorso anno e destinato a crescere. Solo i consiglieri di amministrazione sono 19 mila, gli addetti in generale 300mila. Un terzo delle società è in rosso. Quanto al tanto nominato spread, ossia la differenza tra il rendimento dei Bund tedeschi a 10 anni e i nostri titoli di Stato relativi allo stesso periodo, vale la pena di ricordare che quando nel novembre del 2011 il nostro spread raggiunse i 575 punti base, con tassi vicino all’8% per finanziare i nostri titoli, in mancanza di una drastica inversione di rotta (che fortunatamente c’è stata con le misure varate dal successivo governo), saremmo stati costretti a ricorrere agli aiuti internazionali. È stato stimato che un calo permanente di 100 punti base delle curve dei rendimenti corrisponde un impatto sul costo del debito di 0,19 punti di Prodotto Interno Lordo (Pil) nel primo anno, di 0,36 punti nel secondo anno e di 0,44 nel terzo. Significa in poche parole che con un debito pubblico di circa 1992 miliardi dopo solo tre anni - a parità di altre condizioni - noi italiani avremo risparmiato 19 miliardi di spese per interessi. In teoria, ma solo in teoria, potrebbero sarebbero potuti calare i mutui con beneficio per le famiglie nel 2013 rispetto al 2012 con un risparmio di circa 280 milioni sugli interessi. L’aumento del tasso di interesse non solo si riflette direttamente sul deficit pubblico, e quindi sull’entità del debito pubblico, ma anche indirettamente sul Pil a causa per esempio della minor spesa pubblica (necessaria a contenere il deficit) e della minor spesa per consumi e investimenti a causa del maggior costo dell’indebitamento per il settore privato (prestiti per le imprese e mutui per le famiglie)”. In questo clima diminuisce la propensione dei singoli cittadini alla spesa e mentre il consumatore non procede agli acquisti, il negoziante, non vendendo, si trova con il magazzino pieno e quindi non ordinerà agli agenti che a loro volta, passando dai grossisti, non acquisteranno dalle aziende le quali, non avendo più lavoro, una volta riempiti i magazzini, procederanno al licenziamento delle maestranze che vanno a decrementare ulteriormente il fenomeno. “Voglio ricordare – conclude Virgilio Ballerini – che la finanza rappresenta il trionfo dell’egoismo e nella sua più larga accezione è il risultato di un insieme di comportamenti finalizzati unicamente, o in maniera molto spiccata, al conseguimento dell’interesse del soggetto che ne è autore, il quale persegue i suoi fini anche a costo di danneggiare, o comunque limitare, gli interessi del prossimo e quindi dei suoi diritti”.
I diritti dei cittadini, fra redditi presunti e incertezza del diritto
di Simone Covino
Sono diverse le criticità che, in questa difficile fase, emergono nel rapporto tra fisco e cittadino, talvolta con ingiustificabili compressioni dei diritti di quest’ultimo:
1. il redditometro: è uno strumento presuntivo ventennale, recentemente rinnovato dall’Amministrazione Finanziaria. Esso consente di presumere un reddito sulla base di una lunga serie di spese sostenute dal contribuente, identificate grazie a banche dati e richieste “mirate” del Fisco. Va rilevato che tra le decine di voci di spesa figurano costi assolutamente non voluttuari, come gli assegni di mantenimento al coniuge o le spese veterinarie. Se il reddito dichiarato è maggiore di un quinto rispetto al dichiarato, il contribuente è “attenzionato” dal Fisco e sarà convocato per fornire spiegazioni.
2. le indagini finanziarie: con le nuove norme si delinea per l’Agenzia delle Entrate la possibilità di utilizzare i dati dei rapporti e operazioni finanziarie di tutti i contribuenti, anche al di là di una specifica attività accertativa. Lo scopo è elaborare statistiche informatiche di massa, sulla cui base formare liste selettive di soggetti “a maggior rischio di evasione” da cui potere quindi estrarre dei nominativi da sottoporre a verifica fiscale. Anche la paventata diminuzione del limite per i pagamenti in contante (soglia attualmente fissata in € 1.000) va nella direzione di una schedatura a tutto campo, di un setaccio preliminare indiscriminato di tutti i risparmi, le operazioni ed i rapporti finanziari di ogni cittadino. È poi essenziale rimarcare che tutti i versamenti e i prelevamenti non spiegati dal contribuente, si considerano ex lege come ricavi o compensi evasi, lasciando che il contribuente si tragga d’impaccio in sede giurisdizionale, cosa molto difficile vista la sbrigatività del processo tributario.
3. l’abuso del diritto: si tratta di un principio di derivazione comunitaria, ritenuto immanente anche nel nostro ordinamento. Non essendone stati definiti i termini nelle norme nazionali – malgrado le autorevoli istanze in tal senso da due anni a questa parte – si sono aperti spazi per contestazioni di natura interpretativa soprattutto a carico di grandi società. I rilievi del Fisco che si richiamano all’abuso del diritto sono costruiti spesso in modo generico, sostenendo che il contribuente avrebbe scelto una strada fiscalmente meno onerosa di un’altra per ottenere un certo risultato economico imprenditoriale: viene dunque applicata ex officio la via che fa pagare più tasse, anche se magari incongrua, indiretta ed inusitata rispetto alla prassi imprenditoriale. Al di là dei tecnicismi, siamo di fronte ad un ulteriore vulnus alla certezza del diritto, che genera costi anche in termini di occupazione, scoraggiando investimenti stranieri in Italia ed incentivando l’esodo oltreconfine delle nostre imprese.
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:46


