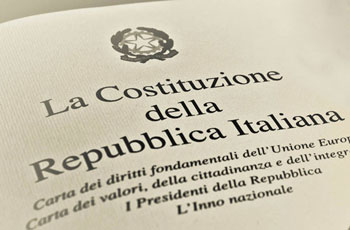
Rodotà, l’uomo divenuto simbolo anticasta, denuncia che la seconda parte della Costituzione è ormai da riformare. Ernesto Galli della Loggia, che si stracciò le vesti quando la Carta fondamentale venne riformata, oggi considera necessario cambiarne la prima parte istituzionale. Considerando che la prima voce viene riconosciuta rappresentante dell’antagonismo giacobino, coltivato ad arte per decenni da accademia ed istituzioni, e che la seconda parla in nome di un campo, progressista e razionale, moderato, oggi diviso senza molto senso, tra destra e sinistra, in nome di antichi steccati, si può affermare che per la quasi totalità degli italiani la Costituzione è da cambiare.
Da anni della Loggia si batte contro la morsa di partitocrazia e di giacobinismo intollerante, due facce della stessa medaglia. La partitocrazia è l’espressione diretta dell’alleanza tra le centomila caste, corporazioni, circoli e gruppi di potere, famigli inclusi, del paese. Tutte queste caste non esprimono una politica precisa, ma difendono contemporaneamente diritti ed interessi, inclusi quelli giacobini, tra di loro contraddittori; per cui non possono che gestire una politica inflazionistica di sprechi, pagati soprattutto dai ceti medi e bassi. La Costituzione è appunto l’esempio di alta letteratura della coabitazione di ideali e propositi tra loro opposti. L’eterna lamentela sulla sua non applicazione si deve proprio all’impossibilità pratica di attuare cose fra loro opposte, così come è impossibile ridurre un cerchio ad un quadrato per poi volerlo ancora chiamarlo cerchio. Della Loggia da tempo è un feroce critico del partito dei fautori della Costituzione. Memorabile il suo scontro nel ‘09 con Corradini che aveva predisposto le linee guida dell’insegnamento della Magna Charta nostrana agli studenti medi: una pratica didattica da stato autoritario secondo l’editorialista de La Stampa e del Corrierone. Le sue argomentazioni proseguono quelle che furono di De Felice, che criticò alla radice mentalità e valori del tempo in cui venne redatta la Costituzione, periodo dominato dalla perdita del senso di identità nazionale degli italiani.
La fine della nazione, per lo storico, si era consumata l’8 settembre 1943, con la dissoluzione dello Stato dopo l’invasione straniera. Prove della mancanza di senso della nazione furono il conseguente attendismo della maggioranza degli italiani, il coinvolgimento di una minoranza nella guerra civile, l’invenzione della lotta di popolo e la retorica sulla Resistenza che aveva avuto invece scarso ruolo negli eventi e l’avvento di due partiti nuovi, figli della Russia di Stalin e del Vaticano di Pio XII. Queste tesi, della Loggia le ha riprese in "Morte della patria" (1996) ed in "La morte della patria: la crisi dell’idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica" (2003), sorta di risposta ai numerosi attacchi ricevuti per il primo volume. L’intellettuale è tornato ultimamente sull’argomento, allargando la sua tesi dall’Italia all’intera Europa continentale, il cui «il dopoguerra - specie quello dell'Europa occidentale continentale, composta (Penisola iberica e Svizzera escluse) di nove Paesi tutti quanti tra il '39 e il '45 sconfitti e occupati dallo straniero - appare anch'esso tutto dominato dall'eclisse dello Stato-nazione». Non a caso della Loggia era stato a suo tempo contrario alla Costituzione europea. La confusione politica, economica ed istituzionale in cui si dibatte l’Europa di Bruxelles sta dunque nella soppravvivenza nonsense dei suoi stati nazionali, attaccati alla vecchia zattera inerziale di valori, espressioni e demagogie, a loro stessi contrari, del dopoguerra, nel nuovo oceano aperto della globalizzazione e della competizione mondiali. della Loggia sembra quindi suggerire una riconquista dell’idea stessa di nazione sia all’Italia che all’Europa, il che significa ripensare interessi e ruoli di popoli e territori, con coraggioso realismo, nel bene e nel male, in ciò che può piacere ma anche dispiacere.
È pacifico che il Risorgimento creò l’idea di patria, senza conquistare ad essa parte dell’opinione nazionale. È pacifico che ci volle una dittatura per far divenire popolare lo Stato. È pacifico che l’esaltazione accademica per il clima del dopoguerra della stesura della Costituzione, oggi fatta in nome della patria, ieri in nome dei soviet, sia ricorda della Loggia, un ’”uso manipolatorio del passato (che) è uno dei nostri vecchi vizi nazionali”. Tutto questo realismo professato da della Loggia, che si dice sostenitore del presidenzialismo e dell’elezione diretta del Presidente, non ha retto però alla prova dei fatti. Infatti nel luglio di 8 anni fa parlò, in occasione della riforma berlusconiana della Carta, di rischi gravissimi per la tenuta dell’unità nazionale. Eppure le riforme, allora definite di "devolution", con la riduzione del numero degli eletti e la precisa distinzione tra poteri statali e locali, sono proprio quelle, da tempo richieste da ogni parte. L’editorialista non a torto parla del nonsense italiano, avviatosi nel dopoguerra quando venne redatta la Costituzione; indica la necessità di ritrovare i fondamenti di unità di patria; per poi ritirarsi timoroso al momento di passare ai fatti. Galli della Loggia presiede dal 2006, la Fondazione SUM a a Firenze, Palazzo Strozzi ed a Napoli, Palazzo Cavalcanti. Si tratta di un ente nato per iniziativa dell'Istituto Italiano di Scienze Umane con scopi esclusivamente dedicati all’alta formazione. Cosa c’entra con la Costituzione, la patria perduta, la partitocrazia? Nel CdA con della Loggia siedono nomi notissimi: Calabrò, Galateri di Genola Geronzi, Mieli, Moratti, Morbidelli, Rossi e Tronchetti Provera. Un manuale Cencelli della lottizzazione non partitica che spiega bene l’impossibilità di passare a vie di fatto anche per gli animi migliori.
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:51


