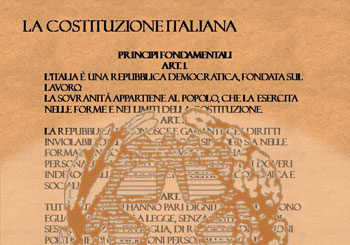
In questi giorni è evidente la preoccupazione per lo sfasamento istituzionale in corso. Il calendario fa convergere la scadenza del mandato del Presidente e rielezione di uno nuovo con l’incapacità delle prime tre forze partitiche di accordarsi per formare un governo, mentre è sempre in corso un negoziato permanente in Europa sui conti finanziari nazionali . Parallelamente le inchieste dei media e giudiziarie seppelliscono di fango le classi dirigenti partitiche, sociali e territoriali, mentre crescono assieme l’allarme sociale per le violenze private ed il ricorso all’illegalità economica nel clima di crisi. Lo status di un Parlamento senza maggioranza né opposizione, di un Governo dimissionario ma in effetti in carica e di un Presidente che non conferisce incarico di Governo disegna una situazione di illegimità costituzionale, non denunciata da alcuno. Per altri versi induce a riguardare bene la Costituzione ed i suoi punti deboli; quindi a chiedersi quanto sia criticabile, senza faziosità o estremismi. Da lungo tempo è presente il dibattito sulle riforme considerate necessarie per modernizzare le istituzioni. In tempi diversi sono prevalsi diversi obiettivi di fondo: governabilità, effettività di poteri, rappresentatività, legalità, democrazia diretta.
Obiettivi scatenati dalla debolezza delle maggioranze politiche e delle istituzioni del potere esecutivo; dall’indebolirsi del rapporto tra corpo elettore, partiti organizzati ed eletti; dal conflitto crescente tra potere legislativo-esecutivo e quello giudiziario come tra senso della morale generale e quello del ceto politico e dalla sfida portata alla democrazia delegata dalle tecnologie abilitanti la diretta espressione legislativa generale. Si tratta di un dibattito che coinvolge l’architettura delle istituzioni e la sua capacità di realizzare compiutamente l’aspirazione della società democratica; e che coinvolge la Costituzione medesima, oggetto negli ultimi anni di profonde modifiche e di ampi tentativi di riscrittura sia di parte che di quasi tutto lo schieramento politico. Questo dibattito di critica implicita alla Costituzione ha diversi ed anche opposti intendimenti. Da un lato sono presenti critiche tese alla valorizzazione della Costituzione. Per esempio, la forte rivendicazione dell’inattuazione del dettato Costituzionale è una critica, avviata da Calamandrei, nata quasi contemporaneamente con il varo costituzionale. Dello stesso tipo la critica che riguarda le modifiche costituzionali apportate nel nuovo millenio che avrebbero sbilanciato la Carta. Un secondo gruppo di critiche lamenta le eccessive verbosità, lunghezza ed estensione normativa della Carta che arriva a fissare la data di particolari eventi addirittura nel giorno della settimana e nel mese.
Oppure sottolinea il carattere datato dal contesto storico della Carta, dominata dai due timori di un ritorno a regimi a partito unico o della preponderanza di una delle due parti politiche dominanti sull’altra. Un terzo gruppo di critiche, a carattere liberalconservatore prende spunto dalle critiche del secondo gruppo per denunciare la strutturale debolezza dell’esecutivo e quindi dello Stato di fronte alle parti sociali. Critica anche il carattere troppo sociale della Carta, la cui sistematica prevalenza degli interessi collettivi su quelli individuali la rende negativa verso l’impresa privata e la libertà individuale. La quarta critica è quella che si è fatto largo negli ultimi decenni, in diretta contrapposizione a quella parte della società che ha reclamato sempre più fortemente l’intangibilità della Costituzione. Proprio l’eccessiva retorica formatasi attorno ad essa, ha rafforzato la critica ai difetti istituzionali, politici e partitocratici, considerati insiti nella Carta medesima. Si tratta di una critica che però non ha chiaro un modello alternativo d’approdo, se non un generico presidenzialismo.Una quinta critica, di segno laico e radicale è rivolta alla “costituzionalizzazione” dei Patti Lateranensi ed all’astrattezza ultraterrena di certe norme.
Pur riconoscendo agli estensori della Costituzione, di essere ingegni «quali forse l’Italia non ritrovò più in seguito», Indro Montanelli, anni fa, parlò per il secondo gruppo, di una Costituzione fondata su un modello sociale anacronistico; la descrisse verbosa, retorica, incapace di concretezza, animata da spirito di rinvio, vaga, interpretabile. Per il terzo gruppo, lo scrittore toscano denunciò il eccessivo potere della minoranza sconfitta nel doppio parlamento ed il debole esecutivo, senza i correttivi di altre costituzioni europee. Criticò i principi generali, non riconoscendoli compromesso di liberalismo, democrazia, socialismo e cristianesimo, ma di ideologie antirisorgimentali, ostili all’unità nazionale. Per il quarto gruppo, accusò la preminenza del parlamento come causa prima di lottizzazione e partitocrazia, una tesi critica condivisa anche dal quinto gruppo. Montanelli poi andò anche oltre quando diede voce alla gran parte dei conservatori italiani, a torto o a ragione confusi con i seguaci della dittatura ed emarginati dalla Carta e dal risultato del referendum istituzionale.
L’Indro criticava della Carta il contesto ideale e storico, cioè l’antifascismo, prevedendo che una Costituzione “invecchiata male”, avrebbe avuto l’effetto duraturo di cristallizzare la divisione vissuta nel Paese negli ultimi anni di guerra; e quindi la sfiducia sia tra le parti che scrissero il testo costituzionale, sia tra esse e quelle che non parteciparono alla stesura. Il Montanelli della critica alla Costituzione venne identificato nei ’70, oltre le sue intenzioni, come la voce del centrodestra. Un ruolo poi dimenticato quando il fondatore de Il Giornale entrò in rotta di collisione con il nuovo proprietario, divenuto leader di quello stesso centrodx. Moltissimi danno alla legge elettorale la colpa dell’attuale sfasi istituzionale. Le colpe, invece, stanno nell’inderminatezza, nella lottizazione tracimata nel mondo privato, nella sfiducia criminalizzante che impedisce sia la grosse koalition italiana, che un dibattito universitario della fazione avversa. Stanno nella Costituzione, che senza paletti esterni internazionali, non regge alle pulsioni giudiziarie, territoriali, generazionali ed economiche. Ora che gli stessi eredi di chi la scrisse la trattano come carta straccia, la si può gettare assieme all’antifascismo. E di fronte alla crisi economica ed esistenziale ritrovare l’unità perduta, quella Risorgimentale.
Aggiornato il 05 aprile 2017 alle ore 10:42


