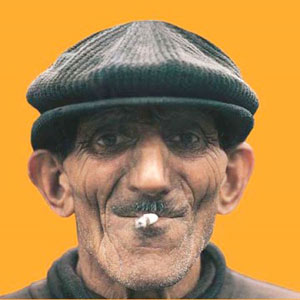
Nell’Isola, e da più di mezzo secolo, qualcuno lavorava alla trasformazione di Salvatore Giuliano nell’Highlander siciliano, nell’immortale patriota. Dopo anni di riunioni segrete, “esoteriche”, nelle campagne del catanese una setta (per certi un “noto servizio”) l’avrebbe spuntata. Riuscendo ad avvolgere le spoglie mortali di Giuliano in un brodo misterioso, lo stesso che aveva già inviluppato nei secoli passati Federico II di Svevia (il suo feretro palermitano conteneva due scheletri di donna ed alcuni amuleti) e Giuseppe Balsamo (il palermitano Conte Cagliostro, il cui corpo scomparve nel nulla dopo la reclusione nei bastioni marchigiani di San Leo).
Dietro le dicerie del tipo “Giuliano non è mai morto” o le affermazioni “non diciamo corbellerie, le sue spoglie sono state riconosciute e l’autopsia ha valore scientifico e legale” si sarebbero annidati sempre gli stessi pupari. Quel “noto servizio”, da certi appellato “Anello”, che secondo i beninformati avrebbe funto fino alla fine della Prima Repubblica come collegamento tra servizi segreti italiani e Cosa Nostra. In pratica il “noto servizio” è una struttura segreta con un piede nello Stato e l’altro nella mafia. Un’organizzazione segreta sia parallela che convergente nelle istituzioni, composta da personale civile e militare, soprattutto fondata verso la fine della Seconda Guerra Mondiale proprio in Sicilia. La struttura permetteva alla mafia d’intrattenere rapporti buoni, saldi, non solo con i servizi italiani ma anche con gli equivalenti spagnoli e sudamericani. A costituire il “noto servizio” e su esplicita richiesta dell’Oss americano (Office of Strategic Services, oggi Cia) fu nel 1945 il generale Mario Roatta. Licio Gelli dichiarava in un’intervista rilasciata il 15 febbraio 2011 al settimanale Oggi che a capo di questa struttura ci sarebbe stato Giulio Andreotti: «io avevo la P2 - diceva Gelli - Cossiga la Gladio e Andreotti l’Anello».
Ma veniamo alle origini del patto servizi-mafia. Il 5 febbraio 1943 Roatta era in Sicilia, dove incontrava persone che avrebbero segnato il nuovo corso politico dell’Isola. Con l’insediamento del governo Badoglio, Roatta conservava la carica di capo di stato maggiore dell’esercito: infatti, durante il difficile periodo dei 45 giorni, represse tutte le manifestazioni politiche. La “circolare Roatta” dava ordine a forze armate e forze dell’ordine di intervenire con la forza nella repressione di ogni manifestazione. Il 16 novembre 1944 Roatta veniva arrestato, e a seguito delle indagini della “Commissione d’inchiesta per la mancata difesa di Roma”, poi nel 1945 veniva chiamato in giudizio dall’“Alto commissariato per la punizione dei delitti fascisti” per l’omicidio dei fratelli Rosselli.
Ma il 4 marzo del 1945, alla vigilia delle conclusioni della commissione d’inchiesta, Roatta evadeva dall’ospedale militare provvisorio presso il romano Liceo Virgilio. Evasione organizzata da Oss e servizio segreto britannico. Roatta sapeva troppo ed era ancora utile: soprattutto aveva visto che accordi erano stati stretti tra Lucky Luciano e l’Oss. Roatta raggiungeva prima il Vaticano e poi, con la moglie, si dirigeva in Spagna, dove il governo di Francisco Franco aveva giurato protezione ai vertici dell’Oss. Giuseppe Saragat (socialdemocratico poi Presidente della Repubblica italiana) scrisse di Roatta «il suo silenzio era d’oro per molte persone». Alludendo a ex gerarchi fascisti, ad agenti segreti passati dall’Ovra al Sim e poi ai servizi della Repubblica Italiana, ma anche ai siciliani che avevano giurato alla presenza di Luciano, come a quelli dell’Anello (il “noto servizio”) che sapevano del rinnovato “patto Stato-mafia”.
Un capitolo a mezzo tra cronaca, letteratura e storia patria? Certamente gli eredi dei Beati Paoli potrebbero brindare, perché in certe procure hanno anche rotto la monotonia isolana, e riesumando Salvatore Giuliano. Una pista che avrebbe potuto narrare agli inquirenti palermitani il “patto Stato-mafia” già due anni prima dell’inchiesta sulla “trattativa Stato-mafia”.
Ad essere sinceri, sulla morte di Giuliano esistono almeno cinque differenti versioni, e poi in molti si chiedono da anni perché sussista il segreto di Stato fino al 2016: un segreto figlio del “patto stato-mafia”? Alcuni addirittura sostengono che il Giuliano morto in Sicilia fosse in realtà un suo fratello naturale, e che il vero Salvatore divenne latitante e, forse, ucciso alcuni anni più tardi in un bar di Napoli (un caffè avvelenato dagli stessi che avevano ucciso Pisciotta?). Secondo un’ipotesi nata nei primi anni ‘50, al posto del bandito venne ucciso (forse intenzionalmente) un sosia, poi tumulato al suo posto. Due storici siciliani (Giuseppe Casarrubea e Mario J. Cereghino) ci hanno ricamato sopra. E ben sappiamo come certe storie, supportate anche da tanti “forse” e “si dice”, riescano a far breccia nei cuori dei magistrati più di tante verità oggettive. Tanto è stato. Dalla Procura di Palermo hanno chiesto di riaprire la bara di Salvatore Giuliano, tumulata nella cappella della famiglia Giuliano a Montelepre (Palermo), e per accertarne l’identità. Così giovedì 28 ottobre 2010 si consumava la riesumazione... pardon: resurrezione. Cosa sapesse Giuliano del “patto Stato-mafia” dovrebbe rivelarcelo in seduta spiritica. Dove forse sarebbe possibile un confronto, un incidente probatorio esoterico, con tanto di spiriti di Luciano e Roatta, Calogero Vizzini e altri ancora.
Ma oggi, dopo tanti anni, non ha granché senso sapere se il 5 luglio del 1950 a Castelvetrano fosse per davvero morto Salvatore Giuliano o un suo sosia. Avrebbe più senso rammentare che i baroni e gli agrari, nonché le antiche conventicole reazionarie, erano turbate dalle vicende politico-sindacali che si stavano avvicendando nell’Italia del dopoguerra. Al punto che i baroni, in nome di quel patto siglato cinque anni prima, preferirono interporre tra loro e certi referenti romani un antico e robusto intermediario siciliano, la mafia. Così l’aristocrazia palermitana e catanese, forte d’aver affrancato la mafia dal limbo in cui l’aveva rinchiusa il ventennio fascista, iniziava un’azione d’infiltrazione nella vita pubblica. Così i latifondisti isolani operavano su due fronti, finanziando da un lato i separatisti e d’altro le intrusioni mafiose nel salotto politico romano e governativo.
Gli assalti nel 1945 alle caserme dei Carabinieri nel palermitano erano messaggi che la banda Giuliano mandava al nuovo governo per conto del “patto Stato-mafia”. L’assalto alla caserma dei Carabinieri di Bellolampo, alle porte di Palermo, fu un chiaro segnale ad un potere costituito che intendeva stracciare gli accordi stretti in Sicilia. Messaggi ad una giovane Italia democratica in cui vivevano politici ignari del “patto Stato-mafia” o sicuri che non potesse incidere su Roma. Per farla breve, erano state fatte delle promesse alla fine del Fascismo, ma il nuovo regime democratico appariva tiepido sul mantenerle. Da qui la sfida affidata dall’antica baronia isolana a Salvatore Giuliano, trasformando il latitante nel colonnello artefice delle imprese militari dei separatisti del Mis (Movimento indipendentista siciliano). Qui forse s’innesta un probabile supporto anticomunista della Cia che, secondo il professor Nicola Tranfaglia, avrebbe finanziato l’Evis (Esercito Volontario per l’Indipendenza Siciliana). Ma nell’immediato dopoguerra l’esercito italiano combatteva in Sicilia contro la banda Giuliano o contro un esercito indipendentista anticomunista finanziato dagli Usa? Le carte ufficiali dicono che ci furono scontri tra briganti e Carabinieri, le fonti di Tranfaglia e compagni affermano che l’esercito fronteggiava gruppi paramilitari armati dalla Cia.
E se la riesumazione della salma nella cappella di Montelepre si fosse basata sulle intuizioni di Tranfaglia? L’emerito professore di storia si rese già autore nel 1970 d’una pubblicazione fantasmagorica che, per la delizia dei complottisti di sinistra, tracciava i collegamenti siculi del Principe Nero (al secolo Junio Valerio Borghese). Secondo Tranfaglia nella Sicilia post bellica gli uomini del principe Nero, i famosi reduci della Decima Mas, avrebbero addestrato la banda Giuliano. Poi lo stesso Borghese, tramite i suoi addentellati con Cia ed internazionale nera, avrebbe garantito un salvacondotto per Giuliano. Lo stesso tipo di salvacondotto ha certamente salvato la vita al generale Roatta. Nessun magistrato credette alla fantasiosa ricostruzione, tra l’altro nota negli ambienti giornalistici e giudiziari già prima della notte di Tora Tora (il golpe Borghese del ‘70). Anche lo scomparso Mauro De Mauro ebbe a raccontare come il golpe fosse stato finanziato da Cia e mafia: soprattutto, entrambe le organizzazioni contavano sul tesoro della banca Rasini, istituto nato in nome del patto stato-mafia, per ripagare la Sicilia di non essere assurta a 51esima stella, di non aver potuto stampare dollari.
Aggiornato il 04 aprile 2017 alle ore 16:10


