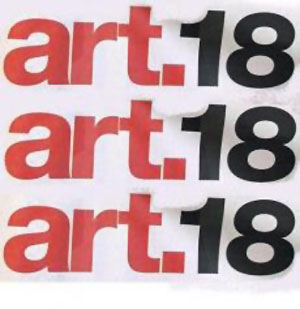
Sono reduce da un convegno in cui il fior fiore degli avvocati/professori di diritto del lavoro si è confrontato anche con giudici di ogni ordine e grado sulla riforma Fornero. Se prima avevo seri dubbi che la modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori avrebbe reso più flessibile il mercato del lavoro, ora ho la certezza che non sarà così.
Continuiamo a subire le presunte riforme di questo governo perché, a loro dire, quasi imposte dall’Unione Europea ed indispensabili ad uscire dalla crisi ed a diventare più produttivi, poi, quando si tratta di seguire il suggerimento esplicito, non solo della UE, ma di qualsiasi economista degno di questo nome, di riformare una procedura di licenziamento anacronistica e figlia dell’immobilismo sindacale, il risultato è solo confusione spacciata per soluzione. È risaputo che gli stranieri si tengano alla larga dall’Italia perché sanno che qualsiasi piano di investimento è un’incognita continua. Come se non bastassero la burocrazia folle, la conseguente corruzione, l’abnormità legislativa che rende ogni giudice di provincia arbitro dei destini industriali del Paese, ora abbiamo aggiunto la totale incertezza sulla disciplina del licenziamento. Almeno, per assurdo, prima sapevano che licenziare era impossibile e se ne facevano una ragione.
Sui licenziamenti nulli perché discriminatori, in caso di matrimonio o maternità o per motivo illecito, non cambia nulla, giustamente, e resta l’obbligo di reintegrazione con pagamento di tutte le retribuzioni maturate fino alla sentenza, anche se arriva dopo anni, come capita fin troppo spesso. Proprio questa spada di Damocle, peraltro, è ciò che rendeva pericoloso qualsiasi altro licenziamento per ogni impresa che si fosse azzardata a superare la fatidica soglia dei 15 dipendenti. Questa distinzione, che ci costringe da decenni al nanismo industriale, non è stata eliminata, con conseguenze che però a volte hanno del paradossale, per non dire incostituzionale, perché ora si rischia di penalizzare di più le piccole aziende in caso di semplici errori nella sempre più complessa procedura di licenziamento. Per chi supera, invece, la soglia della c.d. tutela reale, in qualche modo ora si è cercato di rimediare, obbligando sì a reintegrare il lavoratore in azienda, ma almeno limitando a 12 mensilità il rimborso dovuto per alcuni casi di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo. Negli altri casi, ora il giudice può/deve (la discussione è ancora aperta) condannare il datore di lavoro a pagare un risarcimento tra le 12 e le 24 mensilità, ma non è più costretto a riprendersi il lavoratore.
Semplice, sulla carta, ma il dramma arriva quando bisogna capire quali siano questi casi. Sul licenziamento disciplinare ancora ancora ci si barcamena, perché il reintegro è previsto solo quando il fatto contestato non sussiste oppure il lavoratore non lo ha commesso. Gli illustri relatori si lamentavano che si utilizzi un linguaggio da diritto penale, ma non sarà poi così difficile un ripassino. Già la faccenda si complica quando, per il fatto commesso, sono previste dai contratti collettivi delle sanzioni disciplinari meno gravi, perché si richiede ai sindacati una capacità di legiferare su tutti i casi possibili, che dubito abbiano né peraltro dovrebbero avere, per cui aumenta l’incertezza. Che succede, infatti, se un fatto non previsto è meno grave di uno punito, per esempio, con un richiamo scritto? I giudici sono certo già pronti a imporre il reintegro, ma in realtà la legge, a cui dovrebbero essere soggetti, non glielo permetterebbe, prevedendo solo il risarcimento. Per il disciplinare, per di più, il giudice non dovrebbe avere neppure il margine di scelta tra i due rimedi che, incredibilmente, gli è stato lasciato per il motivo oggettivo.
Quando, infatti, il datore di lavoro ha intenzione di licenziare, non per colpe del lavoratore, ma per sue esigenze organizzative, produttive, perché magari è in crisi, intende modificare le sue strategie aziendali, vorrebbe insomma fare l’imprenditore senza che nessun estraneo, che lo ignori, venga a dirgli come si fa, qui davvero la nuova disciplina ha dell’incredibile. In teoria, e presumo fosse questo l’intento iniziale, se il motivo addotto non è considerato giustificato, il lavoratore avrebbe diritto solo al risarcimento. Se però, e questo presumo sia frutto del classico cerchiobottismo politico che non dovrebbe albergare in un nobile animo tecnico, il giudice “accerti la manifesta insussistenza” del motivo, allora “può” condannare alla reintegrazione.
E qui si sono scatenati tutti i relatori, non ce n’era uno d’accordo con l’altro. Tra chi avanzava teorie su cosa sia manifesto e cosa no, chi si chiedeva per chi dovesse essere manifesto, se per gli estranei o per l’imprenditore, chi diceva che il fatto o sussiste o non sussiste per cui non ha senso la norma, chi ironizzava sulle competenze giuridiche degli estensori, chi sosteneva che il giudice dovesse sindacare dove ricollocare il lavoratore in azienda, chi che debba essere il lavoratore a dimostrare la manifesta insussistenza, come se la prova negativa fosse possibile, chi che, comunque, anche se è manifestamente insussistente il motivo, il giudice “può”, ha facoltà, non è obbligato a decidere per il reintegro, scatenando altre ipotesi di quando, come e perché esercitare questa facoltà. A suggello di tutto, un giudice ha candidamente ammesso che per lui “può” significa “deve” e tanti saluti alla lingua italiana. Il tutto sotto gli occhi attoniti di avvocati relatori stranieri, venuti spiegarci la loro disciplina ed a cercare, invano, di comprendere la nostra.
Su un punto, invece, tutti i relatori, senza distinzione tra giudici e avvocati, si sono trovati unanimemente d’accordo: il nuovo processo introdotto per impugnare il licenziamento è un obbrobrio sia logico che giuridico. I commenti più gentili oscillavano tra: inutile, farraginoso, illogico, incomprensibile, lacunoso, meglio abrogarlo, chi l’ha scritto non conosce neppure la differenza tra un appello e un reclamo, rischia di essere più lungo di quello attuale perché, come riconosciuto proprio dai giudici, tanto i termini per loro sono “canzonatori” per cui non li rispetteranno di certo, impone una assurda moltiplicazione dei processi, con buona pace dell’esigenza di ridurre il carico pendente, e via di questo tenore.
Ora, se certo c’era bisogno di uscire da un sistema asfittico che ingessa la nostra economia, cominciare ad introdurre un po’ di merito in azienda, lasciare agli imprenditori un minimo di spazio di manovra; se comprendo che la materia sia scottante ed è già incredibile essere riusciti a scalfirla, davvero mi chiedo quanto questa riforma possa rendere più flessibile il mercato del lavoro per farci uscire dalla crisi, al di là delle roboanti intenzioni. Arriverà mai il giorno in cui i legislatori capiranno che più leggi astruse fanno, più margini di discrezionalità e di incertezza lasciano, più il potere di decidere come governare il Paese, le industrie, i cittadini finirà in mano a chi la legge dovrebbe limitarsi ad applicarla? D’altronde, se un giudice, in bilico tra un può e un deve, arriva ad affermare che “se gli investitori stranieri vogliono venire in Italia per licenziare più facilmente, è meglio che restino dove sono”, allora c’è poco da aggiungere.
Aggiornato il 04 aprile 2017 alle ore 16:10


