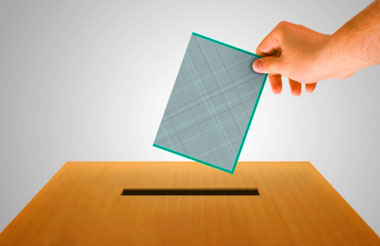
Appare sempre più come un sogno, una fantasia da ingenuo, l'idea
che l'uomo di strada possa col proprio voto mutare il corso della
politica italiana. Meno di 20 anni fa, nella primavera del 1993,
accorremmo tutti ad appoggiare i quesiti referendari promossi da
Marco Pannella ed Emma Bonino. L'Italia chiese, attraverso lo
strumento referendario, la riforma elettorale anglosassone
(maggioritaria, uninominale, a un turno), l'abrogazione del
finanziamento pubblico dei partiti, l'abolizione delle norme che
prevedevano sanzioni penali per l'uso personale delle sostanze
illecite, l'abrogazione delle norme per le nomine ai vertici delle
banche pubbliche (comprese le amministrazioni delle Casse di
Risparmio e dei Monti di Pietà), l'affidamento alle Usl dei
controlli ambientali, l'abolizione dei ministeri delle
Partecipazioni Statali, dell'Agricoltura e del Turismo.
Il 18 e 19 aprile 1993, l'afflusso alle urne superava il 77%. Il
successo schiacciante dei quesiti lasciava pensare alla svolta.
Veniva rovesciato definitivamente il principio proporzionalistico
su cui s'era retta la prima Repubblica. Il Partito Radicale ci
disse che il finanziamento pubblico ai partiti era sconfitto. Con
esso il carattere oligarchico, burocratico, parastatale,
consociativo dei soggetti politici. Nonostante le buone intenzioni,
e la volontà del 90% dei partecipanti al referendum, nel 1996
veniva approvata una legge che reintroduceva il meccanismo del
finanziamento pubblico dei partiti, e attraverso la possibilità per
i contribuenti di devolvere il "quattro per mille" dell'Irpef: il
cittadino non finanziava il suo partito, ma l'intero sistema
partitocratico. E la politica stabiliva che il parere favorevole
del 15% dei contribuenti sarebbe stato sufficiente per assegnare ai
partiti il tetto massimo di finanziamento stabilito dalla legge.
Cos'è rimasto di quei referendum, vinti dal popolo e persi dalla
partitocrazia?
La risposta è nei fatti. I partiti stanno reintroducendo un nuovo
proporzionale: strumento che reggeva i governi di coalizione della
prima repubblica, tanto rimpianto dagli ex Diccì di Pdl, Pd e Terzo
Polo. Ma il buongiorno già si vide dal mattino, e con la legge
elettorale approvata dal Parlamento pochi mesi dopo il voto
referendario del '93: quel Mattarellum (aspramente criticato da
Pannella) che, mantenendo il 25% di quota proporzionale, grazie al
meccanismo dello scorporo, obbligava ciascun candidato a collegarsi
alle liste di partito. Le leggi seguenti le conosciamo tutti: i
partiti riempiono le schede elettorali, gli elettori votano i
simboli, e le persone ce le mettono i leader. Lo scopo del
referendum è stato vanificato dai partiti.
Il ministero delle Politiche Agricole ha soppiantato quello
dell'Agricoltura e Foreste: e i partiti hanno fatto attenzione che
mutasse solo il nome, la sostanza è rimasta la stessa. Il dicastero
del Turismo è stato reintrodotto: oggi c'è Gnudi e ieri c'era la
Brambilla. Le Partecipazioni statali ci sono e si vedono. I
controlli ambientali delle Usl non ci sono, giocoforza la gente
chiama i Nas dei Carabinieri. I vertici delle banche vengono
nominati dalla politica, e viceversa. Il finanziamento dei partiti
è ancora al centro di scandali e scontri.
Aggiornato il 04 aprile 2017 alle ore 16:16


