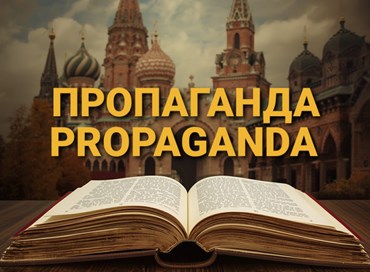
Dal 1° settembre, nelle scuole dell’infanzia russe è stato introdotto il corso “Conversazioni su ciò che è importante”, i cui manuali dedicano ampio spazio alla guerra e ai temi militari. La propaganda è penetrata così fino ai più piccoli, mentre in passato le operazioni ideologiche erano rivolte quasi esclusivamente agli studenti delle scuole superiori e agli universitari. Da quando è iniziato il conflitto con l’Ucraina, le raccomandazioni ufficiali per l’attività ideologica con i giovani sono aumentate vertiginosamente: decine di guide metodologiche vengono inviate agli insegnanti ogni mese, molte delle quali non provengono nemmeno dal Ministero dell’Istruzione, ma da enti paralleli come agenzie giovanili, dipartimenti sociali o piattaforme educative online. In molte scuole russe alcuni elementi propagandistici sono stati sperimentati inizialmente a livello locale, per poi essere estesi in tutto il Paese. Nei manuali destinati agli insegnanti si suggerisce di monitorare non solo ciò che gli alunni dicono, ma anche il loro aspetto, i profili sui social network e le relazioni che intrattengono. Se qualcosa appare “sospetto”, deve essere segnalato ai servizi di sicurezza.
Ai docenti viene richiesto di svolgere una funzione di prevenzione politica: da un lato presentare la guerra, o meglio la “operazione militare speciale”, come qualcosa di giusto e inevitabile; dall’altro trasmettere l’idea che la dissidenza sia pericolosa, che le critiche al potere rappresentino una forma di radicalismo o di estremismo e che ogni deviazione debba essere controllata. In un filmato propagandistico proposto nelle scuole, uno studente “politicamente attivo” invita i compagni a partecipare a una manifestazione non autorizzata promettendo premi e vantaggi; il messaggio finale del video è che la scelta giusta è denunciarlo alla polizia. I manuali dedicati al lavoro ideologico con i giovani non vengono redatti soltanto a livello centrale, ma anche da istituzioni regionali e organizzazioni affiliate. Tuttavia, tutti seguono gli stessi schemi narrativi che discendono dal Cremlino e si adattano alle priorità del momento politico.
Nel tempo, la definizione di “estremismo” e di “ideologia pericolosa” si è progressivamente allargata, includendo non solo il terrorismo, ma anche il “nazionalismo ucraino”, il “radicalismo giovanile”, i movimenti sociali indipendenti, le critiche alla guerra, le culture alternative e persino certi stili di abbigliamento o comportamenti considerati “devianti”. Nelle aree dell’Ucraina occupate, la stessa metodologia viene applicata con una retorica su misura: si sostiene che la popolazione locale sia stata “ingannata” dal proprio governo e che occorra “riempire i vuoti” cognitivi con i valori e le narrazioni che il regime russo impone. Quando si elencano i “gruppi a rischio”, vengono inclusi non solo i sospetti estremisti, ma anche i critici della guerra, gli oppositori politici, i giovani “influenzati dalla propaganda antirussa” o coloro che hanno perso familiari al fronte. Agli insegnanti viene chiesto di controllare simboli, linguaggi e codici criptici nei profili online degli studenti, di osservare l’uso dei social come TikTok, VK o Likee e di segnalare qualsiasi comportamento “anomalo”, dalla scelta di un certo simbolo al linguaggio ironico o critico verso il potere.
Ogni scuola deve compilare delle “carte di osservazione pedagogiche”, dove annotare la “dinamica delle opinioni” di ciascun alunno, il suo atteggiamento verso “l’operazione speciale”, il grado di adesione ai cosiddetti “valori tradizionali”. Anche quando uno studente non dà motivo di preoccupazione, i suoi dati vengono comunque inseriti nei registri per un confronto futuro. Se invece un ragazzo esprime idee dissenzienti, il manuale prescrive di annotare tutto – nome, data, circostanze, contenuto delle parole – e trasmettere la segnalazione alle autorità scolastiche o direttamente alla polizia. Nel caso di lutti familiari legati alla guerra, gli insegnanti devono valutare l’impatto emotivo e ideologico sullo studente e, trascorso un anno, organizzare un atto commemorativo conforme alle direttive statali. Anche nelle università si impongono attività analoghe: giochi di ruolo, dibattiti controllati, processi simulati nei quali una squadra difende tesi considerate “radicali” e un’altra le confuta. L’obiettivo è individuare chi potrebbe nutrire idee “pericolose” e correggerlo in anticipo. In un caso, un’università ha portato gli studenti in un vero tribunale per una simulazione di processo politico, con tanto di condanna simbolica a cinque anni di reclusione come lezione di “cittadinanza responsabile”.
Il controllo però non si ferma agli studenti: anche gli insegnanti sono sottoposti a verifiche. Quando una scuola riceve l’ordine di organizzare un evento patriottico, deve eseguirlo, documentarlo con fotografie e pubblicarlo online. Il rifiuto può comportare sanzioni amministrative o perfino la chiusura dell’istituto. Esistono casi documentati di docenti perseguiti penalmente per aver espresso opinioni contro la guerra, o di scuole private costrette a sospendere le attività per non aver svolto le lezioni di “Conversazioni su ciò che è importante”. Molti insegnanti adempiono alle direttive solo formalmente, compilando i moduli in modo superficiale, ma altri lo fanno per pura necessità: chi non obbedisce rischia richiami, controlli o licenziamenti. Tuttavia, all’interno delle scuole, la libertà effettiva di insegnamento dipende molto dal contesto locale, dalla sensibilità del dirigente e dal sostegno dei genitori. Diversi esperti del settore educativo temono che questa ondata di propaganda possa produrre l’effetto opposto: il controllo totale, la criminalizzazione del dissenso e la chiusura di ogni spazio legale per il confronto rischiano di alimentare la frustrazione e la radicalizzazione dei giovani. In realtà, spiegano, la logica segreta di tutto questo sistema non è la sicurezza dei cittadini, ma quella del regime. Eliminando ogni margine di critica pacifica, si finisce per creare le condizioni di una ribellione silenziosa e inevitabile. Così la scuola, invece di essere un luogo di crescita e libertà, diventa lo strumento attraverso il quale lo Stato semina la propria ideologia e coltiva l’obbedienza, rinunciando del tutto alla sua missione più alta: educare menti capaci di pensare, non solo di ripetere.
(*) Docente universitario di Diritto internazionale e normative per la sicurezza
Aggiornato il 16 ottobre 2025 alle ore 10:39


