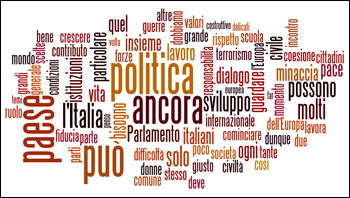
Sul “Corriere della Sera” di martedì primo novembre, Angelo Panebianco pone (o ripropone) il problema del rapporto tra la “politica” e l’“antipolitica”, limitandosi ad analizzare - credo - la situazione dell’Italia.
Secondo Panebianco, “i tentativi della politica di rintuzzare la sfida dell’antipolitica sono fiacchi, controproducenti, spesso corrivi, culturalmente subalterni al nemico...”. Il politologo prende spunto, necessariamente, dalla questione della riforma costituzionale (su cui saremo chiamati presto a pronunciarci per via referendaria), della quale la politica si limita ad elogiare la capacità di ridurre il numero dei parlamentari e dei “costi”, mentre dovrebbe valorizzarne i veri obiettivi, vale a dire la “fine del bicameralismo paritario”, l’“indebolimento dei (oggi fortissimi) poteri di veto”, la “maggiore stabilità e maggiore capacità decisionale dei governi”.
Successivamente, Panebianco prende di mira il tentativo dell’antipolitica, peraltro ben riuscito, di delegittimare agli occhi dell’opinione pubblica non questo o quel provvedimento in sé, ma l’intero ceto politico, interpretato globalmente come una casta inutile e costosa, che presume di essere la sola capace di attività - di governo, ecc. - che invece potrebbero essere benissimo svolte - sostiene l’antipolitica - anche da un cittadino qualunque.
Non si può non essere d’accordo sul ragionamento di Panebianco. C’è però da notare che il politologo si limita ad analizzare il problema sul versante italiano. Lo si può capire, il referendum è alle porte e occorre tentar di guidare l’opinione pubblica del Paese a votare per la soluzione migliore, o ritenuta tale. Ma non si può non osservare, in proposito, che lo scontro tra la “politica” e l’“antipolitica” non è problema solo italiano. Ne riscopriamo tutti i lineamenti fondamentali, per esempio, nella campagna elettorale americana, nella quale la Clinton viene raffigurata (e forse lo è davvero) come la rappresentante specifica di un ceto politico incistito arrogantemente sulle sue prerogative, lontano e chiuso al dialogo con la gente e i suoi problemi, mentre Trump viaggia sulla comoda e larghissima autostrada dell’“antipolitica” più smaccata, non solo rinfacciando alla Clinton i suoi errori attribuiti all’arroganza di un potere che si sente illimitato e intoccabile, ma rovesciando sulle teste della gente tutti i più banali e tipici argomenti dell’“antipolitica”, che in America è, sottopelle, molto forte e diffusa.
E che dire del voto inglese sulla “Brexit”, che ha fatto inciampare Cameron sulla buccia di banana della presunzione di saper sentire il “polso” di una opinione pubblica che invece voltava le spalle a lui e alle sue idee politically correct per buttarsi in una avventura i cui rischi sono - ma lo erano da tempo - dinanzi agli occhi di tutti. La Francia ha la sua Le Pen, e credo che in generale tutta l’Europa sia in mezzo a un guado pericoloso, pieno di tranelli gettati sul cammino del semplice buon senso e della logica storica: i nazionalismi di ritorno la fanno da padroni ovunque, la rivolta delle “plebi” minaccia governi, Paesi, ecc.. Non so di quel che accada fuori d’Europa e degli Usa, e mi spiace non poter ampliare l’orizzonte della mia analisi. Ma, dentro questi limiti, ce n’è abbastanza per porsi interrogativi assai inquietanti, che travalicano di molto i confini delle Alpi. A ben vedere, infatti, la crisi investe pienamente (e indiscriminatamente) i Paesi fortemente sviluppati, quelli in cima alla piramide del progresso civile, tecnologico, culturale e politico.
Quanto sta accadendo, nei limiti del panorama che ho indicato, è qualcosa di inedito. Molti accusano di questo dramma culturale e politico il web, il cyberspazio, che dà modo di diventare determinanti valutazioni, giudizi, pensieri non filtrati, non elaborati, ma schiumegganti qua e là senza freno o sponde. Può darsi che sia così, anche se dall’altra parte ci sono molti che ritengono positivo questo dilagare di linguaggi nuovi e inesplorati, in un dialogo senza regole e obiettivi noti e certi. Se sia, tutto questo, un evento positivo o negativo certo non sarò io a chiarirlo. Ma ovviamente nessuno può pensare di poter tornare indietro, di liquidare questi sviluppi estremi (e forse ancora non definitivi) delle tencologie della comunicazione. Il mondo, la gente, ne è avida, e una ragione ve ne sarà, se - con Hegel - ritengono che tutto ciò che è reale in fondo è razionale, o può divenirlo, attraverso esperienze forse anche dolorose.
Dunque, cerchiamo di prendere le misure, di capire e di gestire gli avvenimenti italiani. Ma è possibile persino arrivare a temere che, tra poche ore, con le elezioni presidenziali americane, l’intero panorama politico-economico-sociale del mondo venga scosso da un terremoto devastante come quelli che affliggono l’Italia in questi giorni. O forse anche di più.
Aggiornato il 09 aprile 2017 alle ore 19:42


