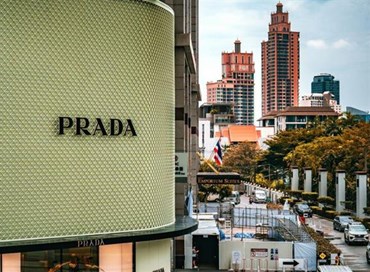
Quotazioni in calo e utili compressi: il mercato corregge gli eccessi e premia solo chi crea valore autentico.
I titoli dei principali gruppi internazionali del lusso, che per un decennio avevano incarnato il mito della crescita inarrestabile, oggi viaggiano ai minimi degli ultimi quindici anni. Il rapporto tra prezzi di Borsa e utili è sceso a livelli che non indicano solo un calo momentaneo, ma anche la fine di una fase di crescita gonfiata da aspettative poco realistiche. I colossi come Lvmh, Hermès, Kering, Prada e Ferragamo hanno perso terreno in Borsa, e nemmeno marchi solidi come Moncler e Brunello Cucinelli sono riusciti a evitare il rallentamento. La domanda è inevitabile: si tratta solo di una pausa momentanea o di un cambiamento più profondo? La risposta non è nei grafici degli analisti, ma nella logica semplice del mercato: nessuna crescita può durare all’infinito se dipende più dalla spinta della finanza che dagli acquisti reali dei consumatori.
Per anni il settore ha beneficiato di una spinta straordinaria: il credito facile, le politiche monetarie espansive e la crescita impetuosa delle economie emergenti. Tutti fattori che hanno ampliato la platea di clienti disposti a pagare cifre astronomiche per un marchio, spesso indipendentemente dalla qualità intrinseca del bene. Senonché, quando la liquidità si ritira e i cicli economici rallentano, ciò che resta a fare la differenza è la capacità di soddisfare bisogni autentici e di creare valore riconosciuto dal mercato, non imposto dall’alto né drogato da artifici.
In verità, come appare intuitivo, il segmento dei beni di lusso non è immune alle leggi dell’economia: la relazione tra fatturato, margini e multipli segue un percorso limpido. Se le vendite crescono, i margini si allargano e le valutazioni si espandono; se i ricavi rallentano, la redditività scende e i multipli si contraggono. Siffatto legame, che alcuni analisti hanno ricordato negli ultimi mesi, non è un accidente ma l’espressione della logica competitiva, che è per sua natura sceglie chi sa far meglio. Nessun marchio, per quanto celebrato, può sottrarsi a tale regola.
Il caso di Prada è significativo: le vendite sono salite del 23 per cento nel primo semestre, ma i guadagni reali sono aumentati solo di poco, perché gran parte delle risorse è stata spesa in pubblicità e iniziative d’immagine. In un mercato aperto nessuno garantisce che dette strategie portino vantaggi agli azionisti. Infatti, la Borsa ha reagito con scetticismo e il titolo oggi vale molto meno rispetto alla sua media storica. Non è un torto, al contrario, è il normale meccanismo del mercato: premiare chi crea valore concreto e penalizzare chi lo disperde. È la regola che ha sempre distinto un’economia concorrenziale, dove il merito conta più del nome.
Eppure, nonostante il calo generale, ci sono marchi che tengono meglio di altri. Hermès e Brunello Cucinelli, ad esempio, continuano a vendere bene perché offrono un prodotto davvero unico, fatto di qualità artigianale e di uno stile riconoscibile. I loro conti restano solidi e la Borsa li premia. Questo dimostra che, se un’azienda propone qualcosa che i clienti considerano irrinunciabile, non ha bisogno di aiuti esterni: la sua forza nasce dalla libera scelta di chi decide di comprare.
Non bisogna dimenticare che ciò che oggi sembra privilegio, domani diventa normalità. Lo ha già ricordato Ludwig von Mises, evidenziando che: “Appena due o tre generazioni or sono nella stessa Inghilterra avere un bagno in casa era ritenuto un lusso; oggi ce n’è uno in ogni casa di un operaio di un certo livello”. Il che prospetta come il lusso, lungi dall’essere una spesa sterile, diventi spesso la prima forma di diffusione di nuove tecnologie, che da innovazioni per pochi si trasformano in beni accessibili a molti. Un concetto similare è stato pure espresso dal sociologo francese Gabriel Tarde, secondo il quale: “Il lusso di oggi è la necessità di domani”, ciò che nasce come consumo d’élite apre la strada al progresso e diventa, col tempo, parte integrante della vita quotidiana.
Il dibattito odierno non può quindi ridursi a una contrapposizione tra congiunturale e strutturale. Il vero nodo è la capacità delle imprese di adattarsi senza attendere salvataggi o protezioni pubbliche. Non sono le norme, i sussidi o i dazi a garantire la prosperità di un settore: al contrario, l’esperienza mostra che colpire il lusso con tasse e divieti non ha mai prodotto progresso. In questo senso, i multipli depressi non sono una condanna ma una possibilità. Quando le valutazioni scendono, chi investe sceglie di scommettere su chi sa reinventarsi e rinnovare il rapporto con i consumatori. La lezione del passato dimostra che, dopo fasi di crollo, i titoli del comparto hanno spesso sovraperformato il mercato generale: segno che la selezione naturale degli operatori, non la protezione politica, genera nuova vitalità.
Il settore rimane così un laboratorio perfetto per osservare le virtù e i rischi dell’economia libera. Quando vi è autentica creazione di valore, la crisi è solo un passaggio temporaneo; se invece prevalgono artifici finanziari e posizioni di rendita, il declino è inevitabile. Nessun nome, per quanto prestigioso, può sottrarsi al giudizio sovrano della domanda individuale.
In ultima analisi, la crisi di cui si discute è un ritorno salutare alla realtà: il futuro dipenderà dalle scelte libere dei consumatori, non dai sussidi pubblici.
Aggiornato il 01 settembre 2025 alle ore 10:31


