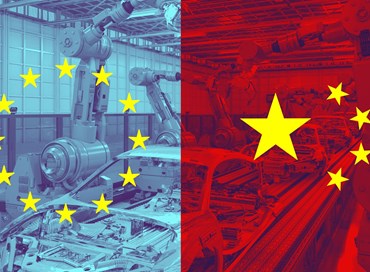
In uno scenario geopolitico quanto mai instabile e complesso, l’Occidente appare realmente compatto soltanto su una manciata di questioni: su tutte, la determinazione a inasprire la guerra commerciale in atto con la Cina, a cui sono in pochi a opporsi e che si palesa nel crescendo, in questo inizio d’autunno, di provvedimenti volti a introdurre o rafforzare rilevanti dazi all’importazione di veicoli elettrici e altri beni da Pechino, in un maldestro tentativo di porre in particolar modo l’automotive europeo al riparo dall’insidiosa concorrenza dei nuovi grandi attori cinesi.
La pressoché totale unanimità di consensi a un’ulteriore virata protezionistica è certificata dagli Stati Uniti, chiamati al voto tra due settimane, in cui l’imposizione di ingenti balzelli alle auto elettriche cinesi è, con ogni probabilità, l’unico punto di contatto tra i due contendenti alla presidenza e l’unica policy su cui vi sia continuità tra l’amministrazione Trump e la presidenza Biden, il quale, solo poche settimane fa, ha approvato gli aumenti ai dazi introdotti dal suo predecessore, che interessano non solo i veicoli elettrici prodotti nella Repubblica Popolare (la cui aliquota sale al 100 per cento), ma anche le celle solari (50 per cento), le batterie per automobili (25 per cento), l’acciaio, l’alluminio e diversi minerali critici.
Lo scorso 4 ottobre è stata la volta di Bruxelles, con la Commissione europea che ha ricevuto il disco verde alla proposta di introdurre nuovi dazi cosiddetti “compensativi” e compresi tra il 7,8 e il 35 per cento – tra un astensionismo dilagante e l’opposizione di soli cinque Stati membri, capitanati dalla Germania, la cui contrarietà è facilmente spiegata dal tentativo di tutelare gli interessi di gruppi tedeschi quali Volkswagen e Mercedes, che già producono alcune vetture in Cina, tra cui quelle a marchio Smart e Cupra. Sommandosi ai dazi al 10 per cento già in essere, le gabelle sulle e-car cinesi, che variano a seconda della casa automobilistica di produzione, arriveranno dunque a un massimo del 45 per cento.
Parimenti, il governo di Trudeau ha approvato tariffe doganali affini: al 100 per cento per i veicoli elettrici e al 25 per cento per l’acciaio importati in Canada da Pechino. Sebbene l’economia canadese, a differenza di quelle europea e americana, non disponga di grandi produttori nazionali di automobili in grado di influenzare l’agenda dell’esecutivo, la decisione di Ottawa è volta a rimanere nelle grazie di Washington in vista del rinnovo dell’accordo di libero scambio Usa-Canada-Messico, fissato per il 2026 e di imprescindibile importanza per il Paese nordamericano. Si tratta, fanno notare gli analisti, di dazi fortemente contrari ai principi del sistema commerciale canadese in quanto unilaterali, ma che non rimarranno tali a lungo.
La prevedibile (e preventivata) replica cinese, infatti, non si è fatta attendere, con il governo di Pechino che, dalle mere rimostranze, è passato al contrattacco, ripagando le potenze occidentali con la stessa moneta e adducendo la medesima motivazione all’introduzione delle misure, che svolgerebbero una funzione anti-dumping, ossia volta a compensare meccanismi distorsivi causati da pratiche commerciali scorrette quali la vendita nei mercati esteri di beni sottocosto. Con lo stesso principio, infatti, Pechino si appresta a introdurre dazi sulla colza canadese, di cui la Cina importa ogni anno una quantità pari alla metà dell’intera produzione del Paese nordamericano. Già in essere dallo scorso 7 ottobre, invece, i dazi sull’importazione di una vasta rosa di prodotti europei, tra cui brandy, cognac, prodotti latteo-caseari, carne di maiale e automobili di grande cilindrata a motori diesel e benzina. Per giunta, in una partita che rischia di minare gli accordi in essere tra Ankara e Bruxelles, sempre più produttori cinesi ricorrono all’escamotage dell’ingresso dei propri veicoli in Europa dagli stabilimenti produttivi in Turchia per aggirare i balzelli – pratica destinata ad aumentare al crescere dei dazi.
Le implicazioni di siffatto scenario, che presenta tutte le condizioni per l’escalation di un conflitto di natura tanto commerciale quanto diplomatica, trascendono l’inevitabile contraccolpo subito dai singoli settori interessati, in un waltzer in cui il tentativo di proteggere dei gruppi di interesse ben organizzati (in questo caso, su tutti, automotive e metallurgia) finisce a sicuro discapito di altre categorie. Un’analisi più pragmatica e di più ampio respiro, semmai, dovrebbe interrogarsi sulla capacità concreta di Europa e Nord America di affrancarsi realmente dall’interdipendenza con la Cina, a prescindere da come la si pensi sulle pratiche commerciali del colosso asiatico, interrogandosi seriamente sulle probabilità di riuscita dei cosiddetti piani pubblici di de-risking messi in atto dalle potenze occidentali – che, allo stato attuale, hanno prodotto risultati a dir poco trascurabili in ogni campo, dalla sicurezza energetica all’approvvigionamento di materie critiche quali il litio per le batterie, il silicio per i microchip, le terre rare e persino i principi attivi per allestire i farmaci. È il caso, ad esempio, dei Fondi Ipcei (Importanti progetti di comune interesse europeo), la cui capacità di favorire l’indipendenza europea dalla supply chain asiatica risulta di scarso rilievo.
Indicativo è il caso della svedese Northvolt, azienda produttrice di batterie al litio per veicoli elettrici, comprensibilmente considerata strategica dalle istituzioni europee ma sull’orlo della bancarotta, con la corsa, proprio in queste ore, per il salvataggio tramite l’intervento di gruppi quali Goldman Sachs e Volkswagen, che ne sono anche i due azionisti di maggioranza. La principale ragione della crisi della startup svedese sarebbe il crollo della domanda di batterie, dovuta alla contrazione nella domanda di auto elettriche, che l’agosto scorso ha registrato un drastico calo del 36 per cento.
Se l’elettrico piange, l’endotermico di certo non ride, con tutti i principali gruppi che hanno registrato battute d’arresto significative nel numero di immatricolazioni ad agosto 2024 – su tutti Stellantis, che tocca quasi il -30 per cento. Si potrebbero biasimare la congiuntura economica sfavorevole e il costo del denaro ancora particolarmente elevato, ma gli stessi player del settore – dalle associazioni di categoria come Unrae ai vertici delle case automobilistiche come il Ceo di Renault Luca De Meo – puntano il dito contro l’incertezza normativa e l’ostacolo rappresentato da obiettivi utopistici in termini di emissioni di CO2 delle vetture posti dal legislatore europeo, il cui improbabile raggiungimento richiede ingenti investimenti in ricerca e sviluppo che si riflettono sul prezzo di vendita dei veicoli.
È in queste pieghe che si scorge il circolo vizioso del protezionismo come pura e semplice espressione di un’attività lobbistica – volta a favorire, come sosteneva Mancur Olson, “profitti privati e perdite pubbliche”. È guardando, tra i tanti, agli aiuti di Stato ricevuti da Fiat-Stellantis dal 1990 al 2019 – pari, secondo il Corriere della Sera, a circa 4 miliardi di euro – che si evince quanto strumentale e paradossale risulti l’argomentazione a favore dei dazi doganali come strumento anti-dumping per tutelare i produttori europei dalla concorrenza sleale dei nuovi grandi player sussidiati dal governo di Pechino. In definitiva, è come giocare una partita a poker in cui molti degli astanti hanno in mano carte truccate.
Realisticamente, in questa partita falsata, i balzelli alle e-car cinesi rappresentano un “risarcimento” accordato dai decision maker di Bruxelles alle case automobilistiche occidentali per aver ceduto alle pressioni di un ambientalismo cieco e oltranzista, che intende imporre un’elettrificazione forzata e prematura per l’attuale stato dell’arte – come ammoniva già nel 2022 l’allora presidente di Toyota Akio Toyoda.
Come da regola, dunque, dietro gli intenti in apparenza nobili di un legislatore si celano uno squallido cerchiobottismo e un cinico calcolo del consenso, con buona pace dei migliori proposti per la transizione energetica e la mobilità a zero emissioni. D’altronde, l’intervento pubblico in economia, in quanto distorsivo del mercato, si risolve spesso in un gioco a somma negativa, dove a rimetterci sono principalmente i consumatori. Quando, per giunta, in ballo vi sono precari equilibri geopolitici, occorre ricordare, come sosteneva l’economista francese Frédéric Bastiat, che “dove non passano le merci, passano gli eserciti”.
Aggiornato il 23 ottobre 2024 alle ore 09:37


