
Nell’introduzione a questo libro molto bello e profondo, che raccoglie alcuni suoi saggi di enorme valore intellettuale sulla storica antica e moderna, edito dalla Rizzoli con il titolo Il prezzo della pace. Quando finisce una guerra, Paolo Mieli osserva che quando si conclude una guerra rimangono irrisolti molti problemi, per diverse ragioni. La fine della Guerra fredda, durata dal 1945 al 1989, si concluse con la capitolazione del modello comunista e il trionfo di quello occidentale e liberale. In seguito si ebbe la nascita di un nuovo equilibrio mondiale basato sulla egemonia degli Usa. Gli Stati Uniti, d’improvviso scoprirono di avere una conoscenza approssimativa del mondo musulmano e rimasero sorpresi per l’attacco alle Torri gemelle, e impigliati, per anni, nella guerra successiva in Afghanistan e in Iraq. L’inizio di un’era di pace è possibile, e per evitare di andare alla ricerca di soluzioni facili, è necessario che si usi la storia, moderna e antica, per capire cosa sia andato storto nel recente passato. Alla fine del V secolo avanti Cristo si concluse la Guerra del Peloponneso, in seguito alla quale si ebbe la dissoluzione dell’impero marittimo durato dal 431 al 404 avanti Cristo. La Commissione dei trenta decretò la fine delle istituzioni democratiche, che vennero annientate con l’appoggio degli spartani.
Trasibulo, ricorda Mieli nel suo libro, nel 403 riuscì a conquistare il controllo del porto del Pireo, in seguito al quale si ebbe la riconciliazione. Trasibulo ottenne il suo successo perché la dittatura dei trenta venne abbandonata da Sparta. Pirro a capo di un piccolo regno dell’Epiro riuscì, senza avere un progetto politico, a sconfiggere nel Terzo secolo avanti Cristo i romani a Eraclea e a Benevento, secondo il racconto che ne fa Plutarco nel suo libro Pirro e Mario. Pirro è il primo sovrano nemico che proveniva dall’oriente, con cui Roma non si era mai dovuta confrontare in passato, visto che Alessandro il macedone era morto prima di rivolgere le sue attenzioni verso l’Occidente. Bello il saggio dove si sostiene che fu Paolo di Tarso, e non Gesù di Nazareth, a fondare il Cristianesimo. Per il teologo Jacob Taubes Paolo di Tarso ha consentito una intensificazione del Giudaismo. Per Paolo di Tarso ogni emanazione della autorità civile trae origine dalla dimensione del divino. L’universalismo dell’Impero romano, che mirava a integrare i popoli conquistati, si combina con l’apertura alla intera umanità del Cristianesimo. Difficilmente il lettore dimenticherà il saggio dedicato agli ultimi anni di vita di Lenin. La lettera testamento di Lenin aveva una postilla nella quale vi erano giudizi denigratori verso i suoi probabili successori alla guida del Partito comunista dell’Urss. In particolare, Lev Trockij, l’avversario di Iosif Stalin, veniva definito un quasi bolscevico, per avere aderito alla causa solo nel luglio del 1917. In realtà, è verosimile che questa postilla sei stata aggiunta da un avversario di Trockij.
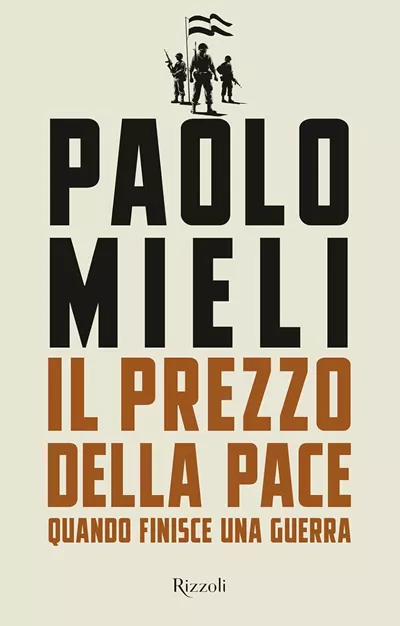
Per Curzio Malaparte, Stalin, secondo quanto sostenuto da questo scrittore nel libro tecnica del colpo di stato, è l’unico rivoluzionario che abbia saputo approfittare dalla lezione dell’ottobre del 1917. Uno dei saggi più coinvolgenti ed emozionanti ricostruisce i fatti accaduti alle Malghe di Porzûs. Un gruppo di militanti comunisti uccise diciotto partigiani azionisti e cattolici. Tra questi vi era Guido Pasolini, il fratello del noto scrittore. Gli uccisori accusarono gli uccisi di collusioni con i nazi-fascisti, accusa che risulterà infondata. Secondo gli storici a Porzûs si sovrapposero le fratture e i conflitti che hanno tragicamente segnato quegli anni, quella tra fascisti e antifascisti, che vedeva gli sloveni e i garibaldini schierati contro l’occupante tedesco e i repubblichini di Salò. La seconda frattura, quella tra sloveni e italiani. La terza forma di conflitto, quella tra comunisti e anticomunisti. Si parla di come Palmiro Togliatti, in un saggio bellissimo, dopo la fine del fascismo, da ministro di grazia e giustizia del governo di unità nazionale guidato da Alcide De Gasperi, volle la amnistia come gesto di riconciliazione dei vincitori verso i vinti, i cui effetti giuridici vennero estesi ai partigiani e ai sostenitori della Repubblica di Salò. Dopo l’attentato che nel luglio del 1948 subì Palmiro Togliatti, i militanti comunisti, in molte provincie italiane commisero reati gravi. I membri della volante rossa, un gruppo armato comunista, nel 1947 uccisero il direttore di un giornale fascista, Franco De Agazio. Per sfuggire ai processi penali, molti di questi militanti comunisti si rifugiarono nei Paesi della Europa dell’est, da cui volevano rientrare in Italia nel 1972.
Per questo motivo, i militanti comunisti, sfuggiti ai processi per i reati commessi nel secondo dopo guerra, si rivolgevano al neo eletto segretario del Pci Enrico Berlinguer, per rientrare in Italia. Il saggio più commovente è quello che ricorda la deportazione dei Tatari della Crimea, avvenuta nel 1944. Per gli storici, le dimensioni dello sterminio dei Tatari sono impressionanti e giustificano il fatto che questo episodio, che provocò la morte di molte persone, venga annoverato tra i casi che rientrano nella categoria del genocidio. Ricorda Paolo Mili che il termine civiltà venne adoperato per la prima volta intorno nel 1750 per designare la evoluzione e il progresso della società umana in ogni campo della vita sociale e culturale. Secondo lo storico François Guizot è l’idea della libertà che ha formato la civiltà occidentale. Le radici dell’Occidente vanno ricercate tenendo presente la civiltà greca e romana. Tuttavia, per lo storico Jack Goody le idee e le tecnologie dei greci e dei romani erano adattamenti di invenzioni provenienti da altre civiltà, ad esempio i codici delle leggi e la letteratura dalla Mesopotamia, la scultura dall’Egitto, i sistemi di irrigazioni dall’Assiria. Il concetto d’Occidente contrapposto a quello di oriente, nell’ottocento venne per la prima volta teorizzato ed elaborato, con la conseguenza che l’oriente comprendeva diverse civiltà e popoli in lotta tra loro. Il saggio di questo libro che il lettore leggerà con maggiore coinvolgimento è quello in cui è raccontata l’eresia di Ario. Ario era mosso dalla preoccupazione di salvaguardare la unità della trascendenza. Vi fu il concilio di Nicea, in cui fu discussa sul piano teologico la natura di Cristo rispetto al Padre.
La natura di Cristo venne definita consustanziale a quella del Padre. Fu con il Concilio di Costantinopoli del 381 che si pose fine alla controversia, provocata dalla eresia di Ario, e venne definita in modo teologico la natura della santa trinità. Il saggio che ricorda il genocidio del popolo armeno, avvenuto tra il 1915 e il 1921, mentre durante la prima guerra mondiale crollavano i grandi imperi, è degno di nota. Il silenzio e la negazione dello sterminio degli armeni, durati per lunghi anni, sono dovuti, secondo gli storici, ricorda Paolo Mieli, alla decisione di Mustafa Kemal Atatürk di definire il canone a cui la storiografia nazionale turca doveva attenersi, per evitare che si parlasse dello sterminio di cui gli armeni furono vittime. Nel suo ultimo scritto, posto in epigrafe a questo libro colto e raffinato, Paolo Mieli rende un omaggio al suo maestro, lo storico Renzo De Felice, studioso del fascismo, che gli ha instillato un metodo di analisi secondo in quale non bisogna mai accettare la versione ufficiale degli eventi storici offerta dalla storiografia e ricercare, in nome del revisionismo, la verità dei fatti accaduti nel passato.
(*) Il prezzo della pace. Quando finisce una guerra di Paolo Mieli, Rizzoli 2025, 304 pagine, 18,50 euro
Aggiornato il 03 ottobre 2025 alle ore 13:03


