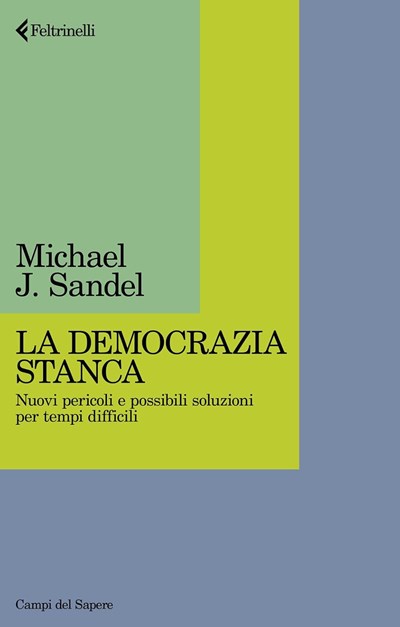 Nel suo libro, intitolato La democrazia stanca. Nuovi pericoli e possibili soluzioni per tempi difficili, edito dalla Feltrinelli, che racchiude un’ampia descrizione della storia degli Stati Uniti e della nascita del pensiero liberale, Michael J. Sandel, docente ad Harvard, si pone la domanda su quale sia il valore della giustizia e della natura della vita buona, nell’epoca della rivolta populista delle masse verso le élite e le classi dirigenti. Ricorda l’autore del libro che dal punto di vista storico il liberalismo, come dottrina politica, indica una transizione del pensiero che pone l’accento sulla tolleranza e sul rispetto dei diritti individuali, che va dalle concezioni filosofiche di John Locke, Immanuel Kant, a quelle di John Stuart Mill e di John Rawls. Fin dalla nascita della Repubblica americana, dopo la Guerra d’indipendenza vinta contro gli inglesi, vi era la consapevolezza che la virtù, il patriottismo, l’amore per la patria e il sentimento di appartenenza alla comunità, non avrebbero messo radici nell’animo dei cittadini, se non vi fosse stato un mutamento della natura umana. Ecco perché la tradizione repubblicana negli Usa fin dagli albori ha mirato a elevare i cittadini moralmente per consentire la nascita e la formazione di un assetto economico che rendesse possibile l’autogoverno. Sia Alexander Hamilton sia Thomas Jefferson, i padri fondatori della Repubblica americana, attribuirono un ruolo formativo all’azione del Governo.
Nel suo libro, intitolato La democrazia stanca. Nuovi pericoli e possibili soluzioni per tempi difficili, edito dalla Feltrinelli, che racchiude un’ampia descrizione della storia degli Stati Uniti e della nascita del pensiero liberale, Michael J. Sandel, docente ad Harvard, si pone la domanda su quale sia il valore della giustizia e della natura della vita buona, nell’epoca della rivolta populista delle masse verso le élite e le classi dirigenti. Ricorda l’autore del libro che dal punto di vista storico il liberalismo, come dottrina politica, indica una transizione del pensiero che pone l’accento sulla tolleranza e sul rispetto dei diritti individuali, che va dalle concezioni filosofiche di John Locke, Immanuel Kant, a quelle di John Stuart Mill e di John Rawls. Fin dalla nascita della Repubblica americana, dopo la Guerra d’indipendenza vinta contro gli inglesi, vi era la consapevolezza che la virtù, il patriottismo, l’amore per la patria e il sentimento di appartenenza alla comunità, non avrebbero messo radici nell’animo dei cittadini, se non vi fosse stato un mutamento della natura umana. Ecco perché la tradizione repubblicana negli Usa fin dagli albori ha mirato a elevare i cittadini moralmente per consentire la nascita e la formazione di un assetto economico che rendesse possibile l’autogoverno. Sia Alexander Hamilton sia Thomas Jefferson, i padri fondatori della Repubblica americana, attribuirono un ruolo formativo all’azione del Governo.
Le passioni individuali e gli interessi personali dovevano, grazie all’azione del Governo repubblicano, essere ricondotti nell’ambito del bene pubblico. Nel libro viene mostrato il cambiamento della struttura economica negli Usa che inizia nel Diciannovesimo secolo, quando dalle piccole aziende agricole e dai laboratori artigianali si ha, in seguito alla Rivoluzione industriale, la nascita delle grandi aggregazioni economiche e produttive. In quegli anni si forma la concezione della economia politica che mira a rendere possibile la cittadinanza, con i cittadini che partecipano alla vita pubblica attraverso l’autogoverno assicurato dalle istituzioni rappresentative. Il dibattito sul lavoro libero trae origine dal movimento abolizionista del sistema della schiavitù esistente nel sud degli Stati Uniti. Un pensatore come William West equiparò le condizioni di lavoro nella industria, dove vi erano forme di degrado lesive della dignità umana, al sistema della schiavitù esistente nel sud del Paese. La Guerra civile che fu causata dal sistema della schiavitù, superato da Abraham Lincoln, dimostrò che il movimento abolizionista, che affondava le proprie radici nel protestantesimo evangelico, era riuscito a infrangere la cospirazione del silenzio che circondava la questione della schiavitù. Lincoln aveva condotto la guerra in nome del lavoro libero. Tuttavia la Guerra civile finì con il favorire l’espansione della grande impresa capitalistica. Vi era tra i progressisti liberali la consapevolezza che il sistema del lavoro salariato minava la virtù civica, così come la concentrazione del potere economico in mani di pochi soggetti, i famosi monopoli, minacciava la democrazia e i valori della repubblica. Per un pensatore come Richard Ely, la libertà di contratto esige la regolamentazione collettiva del governo delle condizioni sotto cui si stipulano i contratti, per garantire i legittimi interessi delle parti contraenti.
Vi era stata la concezione civica della libertà ai tempi dello sviluppo agricolo, poi quella volontaristica che in nome dello sviluppo industriale riconosceva il valore della libera iniziativa privata, adesso si configurava, con la nascita della società dei consumi, la libertà di consumo. Vi furono riformatori che avversarono l’ideologia del Laissez faire promossa dagli industriali e imposta dai tribunali durante l’epoca Lochurn. Nel 1890 venne discusso lo Sherman Act con cui si pose sia un argine al sistema dei prezzi determinato dai monopoli sia si tentò di garantire le piccole attività imprenditoriali. Fu durante gli anni del New Deal che, su sollecitazione di Franklin Delano Roosevelt, venne attuata una normativa antitrust per arginare e contenere la concentrazione del potere economico dei monopoli, che rappresentava una minaccia per la democrazia americana. Il New Deal, con cui prese forma il Welfare State, si articolò in due momenti fondamentali: prima con la pianificazione, Roosevelt tentò di modificare e riformare la struttura economica del Paese; in seguito, con il ricorso alla spesa pubblica in disavanzo, pose le basi per la ripresa che condusse e guidò il Paese, dopo il 1936, verso una nuova fase della sua storia politica ed economica. La politica di Roosevelt venne definita riformatrice perché fedele alla impostazione fiscale prediletta da John Maynard Keynes. Con il New Deal di Roosevelt si ebbe la nascita di una nuova economia politica della cittadinanza con cui prese forma il liberalismo moderno.
La politica keynesiana abbandonava il proposito di inculcare inclinazioni morali nel cittadino e affermava il valore della persona umana come un sé libero, consapevole e indipendente. Lo stato repubblicano non aveva più il compito formativo, visto l’ampiezza e la vastità degli agglomerati urbani e industriali, ma si limitava a fissare una cornici di diritti, rimanendo neutrale rispetto alle visioni della vita buona, sicché i cittadini potessero scegliere i loro fini e valori. La critica al Welfare State di un economista come Milton Friedman derivava dalla concezione volontaristica prediletta dai sostenitori del liberismo classico e del Laissez faire. John Rawls è il teorico della società giusta, secondo la quale in una visione moderna del liberalismo l’idea di giustizia sia destinata a prevalere sulla idea di bene, inteso in senso filosofico. Per Jean-Jacques Rousseau i cittadini erano tenuti a conformarsi alla volontà generale, sicché la comunità politica era concepita come un tutto indifferenziato. Alexis de Tocqueville sottolineava l’importanza dei corpi politici e sociali intermedi tra lo Stato e l’individuo, come le municipalità, le associazioni, le congregazione religiose.
Con la caduta del muro di Berlino, che avvenne nel 1989, ebbe inizio la globalizzazione, questo movimento incessante di merci, servizi, capitali e idee attraverso un mondo privo di confini. Bill Clinton, con il Nafta, avviò la deregolamentazione commerciale e finanziaria. Con la globalizzazione delle relazioni commerciali con la Cina, che entrò a far parte del Wto nel 2001, cominciò una nuova era della politica americana. Barack Obama, dopo la crisi finanziaria provocata dai subprime, approntò un piano di salvataggio di Wall Street con fondi pubblici, proteggendo i banchieri con i soldi dei contribuenti. Le riforme della Presidenza Obama, secondo Sandel, non hanno ridotto la concentrazione del potere delle banche né modificato il rapporto tra economia e finanza. In seguito, le delocalizzazioni, la stagnazione dei salari, la perdita dei posti di lavoro, e la percezione che il sistema politico difendeva i privilegiati e le crescenti disuguaglianze economiche, hanno posto le condizioni perché vi fosse la reazione populista. Un libro di notevole valore intellettuale e culturale.
(*) La democrazia stanca. Nuovi pericoli e possibili soluzioni per tempi difficili di Michael J. Sandel, Feltrinelli, Collana: Campi del sapere, 336 pagine, 28,50 euro
Aggiornato il 01 aprile 2025 alle ore 12:20


