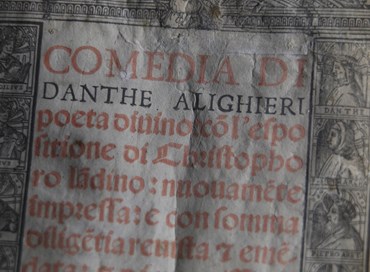
L’Italia ha sempre costituito un abbeveratoio di cultura per i letterati e gli artisti stranieri. Già nel 1300 Geoffrey Chaucer – che per primo elevò a dignità di lingua uno dei tanti dialetti anglosassoni – testimonia il suo debito nei confronti della nostra cultura. Grande ammiratore della poesia italiana, ne trasferì argomenti e immagini nella lingua inglese. I suoi modelli furono la Divina Commedia, il Canzoniere e il Decameron: La casa della fama si ispira al poema di Dante Alighieri e ai Trionfi di Francesco Petrarca, Il racconto del monaco è una parafrasi dell’episodio del conte Ugolino, il piano generale dei famosi Racconti di Canterbury è dovuto ancora alla Divina Commedia, da cui l’autore trasse numerosi spunti, mentre la cornice e i contenuti derivano in gran parte dal Decameron. Nel Cinquecento Michel de Montaigne, nel suo Viaggio in Italia, descrive il fascino che su di lui esercitò il nostro Paese, soprattutto Firenze. Non sappiamo in quale misura William Shakespeare sia stato influenzato dalla cultura classica: il suo amico Ben Jonson sosteneva che egli sapeva “ben poco di latino e meno di greco”, e secondo altri la sua dimestichezza col mondo classico sarebbe derivata unicamente dalla lettura di una traduzione delle Vite parallele di Plutarco.
Sta di fatto che la sua opera è intrisa del nostro Rinascimento e che quelle commedie che non appartengono al ciclo classico sono tratte quasi tutte dalla novellistica italiana. Quanto a John Milton, anche escludendo che il suo Paradiso perduto sia un plagio del poema filosofico Le sette giornate del mondo creato di Torquato Tasso o dell’Adamo di Giovan Battista Andreini (come vorrebbe Voltaire), è certo che non avrebbe potuto scriverlo se non avesse soggiornato in Italia. Nel Settecento furono nel nostro Paese il marchese Donatien-Alphonse-François de Sade e Charles de Montesquieu, entrambi autori di un viaggio in Italia, e negli ultimi anni vi giunse Johann Wolfgang von Goethe, che annotava nel suo diario: “II giorno in cui sono giunto a Roma è il giorno della mia rinascita. In Roma ho ritrovato me stesso. Ho conosciuto le più alte gioie dell’esistenza”. Autore del famoso viaggio in Italia, nelle Elegie romane cantava: “Come lieto, ispirato io qui mi sento, / qui sul classico suolo!”. In Italia soggiornò anche Stendhal, che vi trovò ispirazione per Roma, Napoli, Firenze e per Storie romane, e che nella Vie de Henry Brulard descrive il suo rapimento nel vedere come il bello trovi nel nostro Paese la sua migliore realizzazione (“Terre de grace et de clarté, / un enfant t’est venu de France / qui te demandait la scienze: / tu lui révélas la beauté!”). Ma il suo cuore batte soprattutto per Milano, alla cui vista – annota nel suo diario: “Spuntò l’aurora della mia vita”. Stendhal nutriva una grande ammirazione per i milanesi (“mai incontrata gente più adatta a me”), di cui lodava soprattutto la saggezza, la bontà, la naturalezza, la semplicità e la stringatezza nel linguaggio.
“Quando sono fra i milanesi e parlo milanese”, scriveva, “dimentico la cattiveria degli uomini e tutta la parte malvagia dell’animo mio si addormenta all’istante”. E a maggior gloria di Milano aggiungeva: “Molti francesi della grande epoca sono venuti qui a prendere catene che hanno conservato sino alla tomba”. Ma sugli italiani c’è un suo passo significativo che ha del profetico: “Tremo per i giorni futuri d’Italia. Questo Paese avrà filosofi come Beccaria, poeti come Alfieri, soldati come Santa Rosa; ma questi uomini illustri sono a troppo grande distanza dalla massa popolare. È necessario un Napoleone. Ma dove lo si va a prendere?”. Molti e frequenti furono i contatti fra la cultura inglese e quella italiana nel periodo romantico: i poeti inglesi venivano nel nostro Paese, vi soggiornavano a lungo, si commuovevano, s’inginocchiavano di fronte alle testimonianze della sua grandezza passata, cospiravano anch’essi e s’infiammavano per il nostro riscatto. George Byron, mentre cavalca nella pineta di Ravenna o cammina lungo l’Arno, studia l’arte italiana attraverso il Luigi Pulci, di cui nel Don Giovanni imita anche l’ironia, che molto contribuirà all’affermarsi del tipico humour inglese. E Percy Shelley? Non trovò forse in Italia la sua più alta ispirazione? Venuto a Roma nel 1818, rimase subito colpito dal “divino fascino della città eterna”, che come una “molle sovrana, tiene la sua pallida corte in mezzo alla magnificenza e alla dissoluzione”.
Cento città italiane recano lapidi col suo nome, e a Viareggio una piazza ricorda che lì fu portato dalle onde il suo corpo senza vita dopo il naufragio della sua imbarcazione. E le sue ceneri, come quelle del figlio William, morto per un attacco di gastrite, furono sepolte nel cimitero protestante di Testaccio, a Roma, definito da Shelley “il più bello e solenne cimitero”. Sulla sua tomba sono incisi i celebri versi della Tempesta di Shakespeare: “Nulla di lui perisce, ma tutto è trasformato dal mare in qualche cosa di ricco e di straordinario”. Dietro consiglio di Shelley, perché malato di etisia, venne a Roma anche John Keats, celebre per le sue odi (fra cui A Psiche, A un usignolo e Su un’urna greca), e lì, tre mesi dopo, chiuse per sempre i suoi occhi, che si erano nutriti del nostro limpido cielo, ai piedi della Scalinata di Piazza di Spagna, dal lato della Barcaccia, in un palazzina che porta il suo nome. Sulla sua tomba (anch’essa nel cimitero protestante di Roma) è incisa questa epigrafe: “Qui giace uno il cui nome fu scritto sull’acqua”. Franz Liszt si sentiva “inebriato d’arte e d’ogni gaudio terrestre” e al Teatro alla Scala si abbandonava a strabilianti improvvisazioni su temi suggeriti dagli ascoltatori, Alfred de Musset lasciò tracce del suo soggiorno in Italia nella Confession d’un enfant du siècle (in cui narra il suo amore infelice per George Sand, di cui ebbe a soffrire a Venezia). Subirono il fascino della cultura italiana anche Hippolyte Taine, autore, pure lui, di un Viaggio in Italia, Charles Dickens, Marcel Proust (Alla ricerca del tempo perduto), Richard Wagner (che a Venezia, come scrive egli stesso, dovette lottare per procurarsi il necessario per vivere, violentando la sua vera natura “per apparire tutt’altro a coloro da cui attendo un appoggio”).
E, ancora, Théophile Gautier, anch’egli autore di un Viaggio in Italia, Laurence Sterne, autore del Viaggio sentimentale in Francia e in Italia, Alexandre Dumas padre, Honoré de Balzac, Oscar Wilde, Ferdinand Gregorovius, che venuto in Italia per scrivere la sua Storia di Roma nel Medioevo annota nei Diari romani: “Roma è il demonio col quale lotto. Se potrò uscire vittorioso dalla lotta, cioè se riuscirò a dominare questo essere potente e universale e farne oggetto dell’osservazione indagatrice e del senso artistico, sarò anch’io un trionfatore”. Accanto a lui Theodor Mommsen, autore della Storia di Roma, Henrik Ibsen, Friedrich Nietzsche, Johann Joachim Winckelmann, il grande studioso di antichità classica. E ai giorni nostri Ernest Hemingway (che durante la Prima guerra mondiale combatté come volontario sul fronte italiano), Igor’ Stravinskij, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre. Quanti scambi, di cultura, di amore, di ardore patriottico fra cittadini di nazioni diverse, che già sentivano l’Europa come una patria comune e più grande!
Aggiornato il 05 febbraio 2025 alle ore 12:55


