
Dopo aver trascorso più della metà della sua vita in missioni all’estero – prima in Africa, poi soprattutto in America Latina – negli ultimi anni della sua vita Don Arturo Paoli fece ritorno a casa. Nella chiesetta di San Martino in Vignale, sulle colline lucchesi, le sue celebrazioni erano gremite di persone di ogni età ed estrazione sociale, e ciò nonostante che il tipo di Cristianesimo che traspariva dalle sue letture del Vangelo non fosse dei più concilianti. Questa circostanza dipendeva probabilmente dal fatto che la sua reale esperienza del deserto e del “nulla” conferiva ai suoi discorsi un alone spirituale tale da renderli fonti di riflessione e ispirazione sia per i fedeli più fervidi sia per quelli più dubbiosi e incerti.
Forse, se volessimo riassumere in un motto soltanto il significato dell’intento spirituale del suo ultimo libro (La pazienza del nulla, Chiarelettere editore, Milano, 2012), potremmo riprendere con lui quanto gli ripeteva spesso Carlo de Foucauld, suo maestro spirituale: jamais avoir peur, non avere mai paura; oppure l’esortazione, che lo stesso Paoli cita da un’opera di Bernhard Welte (La luce del nulla, Queriniana, Brescia, 1983): “non temete”. Il fatto che queste esortazioni possano aver ispirato anche il cuore pulsante e segnato l’eredità più significativa del pontificato di Giovanni Paolo II non costituisce probabilmente una casualità, dato che la paura sembra costituire, nel contesto della civiltà contemporanea, il sentimento che la caratterizza in maniera più essenziale e rilevante.
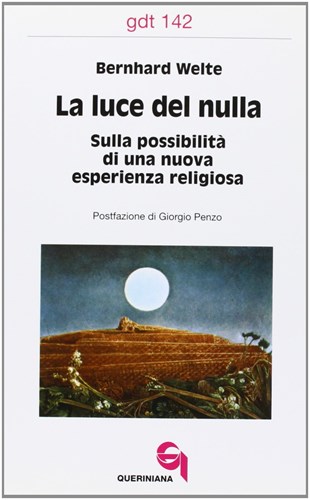
La paura del nulla è infatti, per Arturo Paoli, una espressione diretta dell’attuale società dei consumi, che dal nulla è portata a difendersi in maniera aggressiva e affannosa. Una simile autodifesa tanto allarmata, non avrebbe tuttavia ragion d’essere se imparassimo a considerare il nulla in questione un nostro alleato e amico, ovvero quella dimensione che può aiutarci a ritrovare una nostra specifica e individuale autenticità. Nell’esperienza del nulla, infatti “il soggetto sparisce del tutto, è spogliato proprio dell’essere soggetto”, ma questa circostanza, se può rivelarsi anche pericolosa e spaesante, costituisce tuttavia una condizione necessaria a qualsiasi rinascita non episodica, e ciò perché, come spiega bene Welte, “chi fa esperienza del nulla fa veramente un’esperienza, incontra cioè qualcosa che lo colpisce, lo sconvolge e lo trasforma”, qualcosa che è in grado di liberarlo da quanto la società, con le sue chiacchiere e le sue illusioni falsamente rassicuranti, gli hanno calato addosso.
Si può addirittura ritenere che una persona non possa considerarsi autenticamente religiosa senza aver attraversato il deserto di questa esperienza. Come comprese bene Nelly – una donna conosciuta da Don Arturo in Argentina, protagonista di una vicenda tragica e dolorosa, ma anche capace di suscitare in lei una decisiva rinascita spirituale – “un religioso, per essere testimone del Tutto, deve essere testimone del nulla”, deve cioè avvertire quel bisogno di comunione e compassione cui solo la dimensione del nulla consente pienamente l’accesso e che ha nella Kénosis di Cristo l’esempio iniziatico.
“Chi perderà la propria vita, la troverà” – si legge nel Vangelo di Matteo (16, 24), e Nelly fu capace di trovare la propria vita proprio dopo averla persa, quando divenne capace di vivere le relazioni affettive senza voler possedere, “cioè senza cercare di trattenere oltre il suo limite la gioia che ogni forma d’amore genera, e senza rifiutare la tristezza che nasce quando l’amore ha superato il limite della gioia”. Il voler camminare in prossimità dell’Altro, senza voler per forza condizionare il suo percorso, ma essendo contenti di accompagnarlo per un tratto, è proprio di coloro che hanno attraversato l’esperienza del nulla. Per accedere a una simile esperienza non risulta essere decisiva la lettura e la decodifica di faticose opere filosofiche – nemmeno di quelle, per altri versi preziose e illuminanti (come L’essere e il nulla di Jean-Paul Sartre), che ne fanno un ragguardevole perno tematico.
Ciò che bisogna specialmente sentire per percepire il nulla fino agli sviluppi del suo rivolgimento dialettico è che nella stanza buia in cui ci è capitato di entrare, e in cui non si odono né voci né rumori, come ci ricorda Teresa d’Avila, “si sente la presenza di una persona amata, si ha la sensazione che qualcuno sia lì”, che questa persona celata sia capace di riconoscerci ed amarci per ciò che siamo, ben oltre il nostro ostinato voler apparire e credere di dover essere, e che sappia farlo in modo talora discreto, facendoci appena percepire il suo respiro, tal altra in maniera aperta, luminosa e sonora.
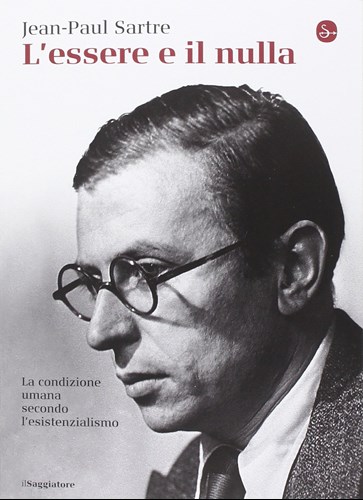
Forse, proprio una simile segreta impressione dell’anima, questa naturale confidenza nella presenza di una persona amata nella stanza a volte buia della vita, potrebbe essere quella che caratterizza i poveri di spirito, che per Don Arturo sono contraddistinti proprio dalla capacità “di ricevere e di godere le tre ricchezze che vengono dal nulla. L’incapacità di giudicare, di possedere, e la capacità di essere solidali”. Solo chi ha percorso l’esperienza del nulla può infatti ritenere di aver vissuto un’esperienza simile alla kénosis di Gesù, sostituendo “al giudizio la misericordia, al possesso la carità, al potere la solidarietà”.
“L’anima è pazienza” – scrive James Hillman – e l’esperienza del nulla, la pazienza che essa sa trasmetterci appare in grado, nella prospettiva di Arturo Paoli, di fornire un contributo decisivo a ciò che lo stesso Hillman definisce “fare anima”. In una città appena più piccola di Lucca, Le Creusot, nel cuore della Borgogna, un altro scrittore d’ispirazione cristiana, Christian Bobin, aveva già dedicato un piccolo libro a L’elogio del nulla (Servitium editrice, Priorato di S. Egidio, Bergamo, 2002), libro nel quale si manifesta un’ispirazione di fondo non molto diversa da quella che potrebbe aver suggerito le pagine di Don Arturo, perché fornisce una descrizione di quella che sembra proprio essere un’esperienza del nulla, o che almeno pare costituire una sua integrazione pertinente e illuminante: “all’inizio – scrive Bobin – si guarda quello cui si passa accanto, poi lo si diventa. Non si è più che una traversata luminosa del paesaggio. Si è soltanto, se stessi, una farfalla morta, polverizzata nel vento. Non si lotta più con l’aria, con il vuoto nell’aria, con gli angeli nel vuoto”. Quando la vita si affaccia sul nulla si fa leggera e limpida, perché si trasfigura nell’amore che ogni cosa lega nell’uno e l’amore, come la solitudine, “non oscura ciò che ama. Non l’oscura perché non cerca di prenderlo. Lo lascia andare e venire. Lo guarda allontanarsi con un passo così felpato che non lo si sente spegnersi: elogio del poco, lode del debole”, fino al punto in cui “non c’è più niente da afferrare, se non l’inafferrabile”.
Aggiornato il 20 novembre 2019 alle ore 13:37


