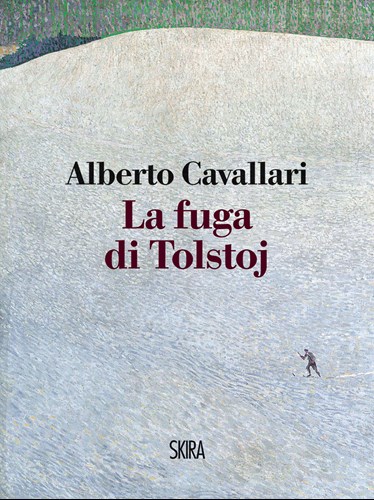
“La vecchiaia si può fuggire in mille modi, magari scrivendo un libro”. Così si legge nel retro di copertina di La fuga di Tolstoj, di Alberto Cavallari. La prima impressione che si ricava dalla lettura di questo lungo racconto, che ha il sapore e la fisionomia di una cronaca, è che l’autore – già direttore del Corriere della sera e successivamente opinionista di Repubblica – sia in qualche modo riuscito, forse anche per la grande umiltà letteraria con cui ha affrontato un tema così impegnativo, a trasformare lo stesso Tolstoj in un personaggio degno di comparire in un racconto del grande scrittore russo.
La vicenda inizia la notte tra il 27 e il 28 ottobre 1910, quando l’ormai ottantaduenne Lev Nikolàevič decise di lasciare la famiglia e la sua casa di Iasnaja Poljana, dov’era nato e cresciuto e dove aveva a lungo abitato negli ultimi anni della sua vita, per una destinazione a lui stesso ignota. Il motivo erano le ormai reiterate incomprensioni e i litigi con la moglie Sof’ia, preoccupata per l’intenzione del marito di lasciare allo Stato i diritti d’autore di tutte le sue opere. Ma a queste motivazioni faceva da sfondo una ragione più vasta e profonda, che si può ricavare da un passo di una lettera scritta proprio alla moglie nel tentativo di fornirle una spiegazione della sua scelta subito dopo la sua fuga: “La vita non è uno scherzo, e non abbiamo il diritto di abbandonarla così. È anche irragionevole misurarla secondo la durata del tempo, forse i mesi che ci rimangono da vivere sono più importanti di tutti gli anni vissuti: bisogna viverli bene”.
Questa convinzione, che imponeva di cercare di continuare a vivere una vita degna fino all’ultimo istante, per quanto potesse essere breve il tempo che gli rimaneva, lo indusse a continuare il viaggio appena intrapreso cercando di far perdere le sue tracce a Sof’ia e a quanti potessero cercare d’indurlo a ritornare a casa. Così, per quanto possibile in incognito, viaggiando su treni a volte assai scomodi, Tostoj decise di dirigersi prima verso Optino e Samordino e poi, dopo aver soggiornato per un po’ nei pressi del convento dove si trovava la sorella Màrija, verso il Don.
Lo stato d’animo che doveva anche in quell’occasione accompagnarlo in un ultimo sussulto vitale è probabilmente riconducibile a quanto Radiščev attribuiva, già nel diciottesimo secolo, a se stesso, e di cui per Georg Steiner il romanzo russo del secolo successivo costituisce una glossa, ovvero il sentirsi sopraffatti “dal peso della sofferenza umana”. La risposta di Tolstoj a tale sentimento di sopraffazione trae slancio, almeno negli ultimi decenni della sua vita, dalla propria visione del Cristianesimo, per la quale “solo Dio esiste veramente. L’uomo è la sua manifestazione nella materia, nel tempo, nello spazio. Più la manifestazione di Dio nell’uomo (la vita) si unisce alle manifestazioni (le vite) degli altri esseri, più l’uomo esiste”.
Questa convinzione impone a ciascuno d’imparare a nuotare con la propria pietra al collo, riconoscendosi nel dolore degli altri non meno che nel proprio, perché proprio quella pietra con cui ciascuno deve continuare a nuotare costituisce l’unica garanzia di un senso della vita che non sia un effetto secondario e posticcio di false credenze egotiche, di una falsa coscienza che può solo condurre a una prigionia dell’anima e precludere ogni possibilità di rinascita spirituale.
Come osserva il narratore, i treni non erano mai piaciuti molto a Tolstoj, che li aveva sempre percepiti come “simboli lugubri”, e questa sua diffidenza conteneva probabilmente l’agnizione di un destino. Che dovesse intraprendere il suo ultimo viaggio proprio da una stazione ferroviaria lo si poteva tuttavia prevedere: era in parte già annunciato nei suoi romanzi, e non solo nei suoi, ma anche in quelli di altri scrittori russi che stimava e che continuò a leggere fino agli ultimi mesi della sua vita. Le ferrovie costituivano in effetti quasi un topos letterario che condivideva con altri scrittori russi, e in particolare con Dostoevskij: basti pensare all’inizio e alla fine di Anna Karenina, o all’inizio dell’Idiota, al ruolo anche simbolico che i treni e le stazioni hanno nell’intreccio dei due romanzi.
Durante il suo viaggio verso est, quando si trovava nei pressi della stazione di Astàpovo, le condizioni di salute di Tolstoj si aggravarono rapidamente, la febbre salì fino a quaranta gradi e Dusàn Makovickij, il suo medico personale, che lo accompagnava nel viaggio insieme alla figlia Aleksandra (Saša) e a Varvara Michàilovna Feokrìtova, la sua copista, decisero che era meglio interrompere il viaggio. Così, “alle sei e trentacinque il treno si fermò qualche minuto a una piccola stazione. Sotto la pensilina una lampada rischiarava una scritta: Astàpovo. Makoviackij aprì lo sportello, scese nel nevischio, sparì. Il treno fu trattenuto, Makovickij tornò col capostazione, Tolstoj fu fatto alzare, sorretto da Makovickij e dal capostazione scese dalla vettura. Saša e Varvara buttarono giù i bagagli. Tolstoj, sempre sorretto, venne portato nella sala d’aspetto più vicina, quella per le signore. Mentre vi entrava, il treno ripartì nel nevischio. Continuò la sua corsa verso il Don, e loro rimasero ad Astàpovo”.
L’accoglienza del capostazione, che lo riconobbe subito, fu commossa, così come quella della folla che si radunò sul posto poco dopo: gli uomini si scoprivano il capo al suo passaggio e lui rispondeva ai loro inchini “portando un dito al berretto”. Gli venne assegnata una stanza, “povera, coi mattoni rossi, lucidi, qualche stampa alle pareti, un calendario”. Una volta che fu disteso sul letto, “le luci vennero attenuate”.
Nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute nei giorni successivi, volle scrivere ancora qualche riga sul suo diario, descrivendo la sua giornata. La sua agonia durò sei giorni. Sof’ia, sopraggiunta con un treno speciale, su consiglio dei medici e poi per decisione della famiglia, non poté vederlo, e rimase chiusa dentro il suo treno fermo alla stazione. Lui seppe che c’era, ma non la fece chiamare.
Le ultime sue frasi, dopo sette giorni di delirio, ribadivano il suo fermo desiderio di proseguire, di andare in qualche posto, di scappare, e questo desiderio gli sopravvisse, in effetti, attraverso le storie e i personaggi delle sue opere, nella loro accettazione complessiva della vita e nella ricerca incessante di un suo significato, nel desiderio di non fermarsi a contemplare il proprio passato, ma di continuare a vivere la propria vita, come un tutto indissolubile, insieme a quella degli altri, di tutti coloro che gli era stato concesso di amare o di comprendere, di sentire come parti di una stessa sofferenza, riscattata e redenta da un’unica possibile grazia, perché riflessi infiniti di un’unica fraterna esistenza spirituale.
Si tratta, a ben vedere, di quello stesso tipo d’esistenza evocato dal desiderio che Lev Nikolàevič e suo fratello maggiore Nikolaj avevano espresso insieme, ancora bambini, incidendolo poi su un bastoncino verde: che gli esseri umani si amassero gli uni con gli altri. Questo era il segreto per rendere felici tutti gli uomini. Quel bastoncino venne poi da loro seppellito esattamente in quel luogo, in un bosco a poche centinaia di metri dalla casa dov’erano cresciuti, ed esattamente in quel luogo, sotto un rilievo erboso, fu sepolto Tolstoj, nel pieno rispetto delle sue volontà, dopo il suo ritorno da Astàpovo.
Alberto Cavallari, La fuga di Tolstoj, Skira editore, Ginevra-Milano, 2010.
Aggiornato il 25 ottobre 2019 alle ore 13:19


