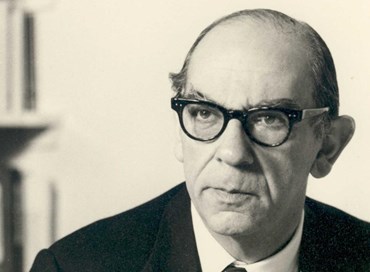
Gli intrecci e la struttura polifonica dei romanzi del diciannovesimo secolo o dell’inizio del ventesimo sono sempre più rari e chi adotta ancora oggi tali approcci narrativi riesce a farlo solo al prezzo di riferirsi a contesti familiari o sociali decisamente più angusti rispetto a quelli di allora. Soprattutto, difficilmente si azzarda a sfiorare le problematiche di largo respiro che permeavano invece le vite di quei personaggi ancora un secolo fa. Ma a cosa è dovuta questa scarsa attitudine dei personaggi letterari che abitano le opere narrative degli ultimi decenni a cimentarsi quelle problematiche filosofiche su cui invece amavano riflettere molti grandi personaggi dell’Ottocento e del primo Novecento?
In effetti, oltre alla difficoltà da parte dell’Io novecentesco – già preannunciata da Friedrich Nietzsche – di lasciarsi alle spalle la propria dimensione frammentaria e di misurarsi con ricostruzioni chiare e oggettive, la letteratura contemporanea pare infatti anche restia a cimentarsi con temi e problemi di carattere spirituale o filosofico. Dopo gli Ivan Karamazov, i Kirillov, i Bazarov o, avvicinandoci a noi, il Settembrini della Montagna incantata oppure l’Ulrich di Musil, i protagonisti di pur buoni romanzi del nostro secolo sembrano muoversi in orizzonti più limitati, concedono poco spazio alla riflessione, sembra che ne abbiano perso il gusto, e si trovano per lo più alle prese con problemi quotidiani, siano essi di origine psicologica o sociale.
Allo stesso modo il narratore, anche quando non si lasci prendere nel vortice delle azioni e dei pensieri dei suoi personaggi e cerchi di raccontare come un discreto testimone immaginario le loro vicende, a volte sembra che non osi affrontare certi temi, quasi li avesse preliminarmente espunti dai risvolti della loro vita interiore. Forse ha paura di dare corpo a quei “busti del pantheon” di cui parlava Claudio Magris in suo articolo apparso sul Corriere della Sera di qualche anno fa, e tale paura non risulta infondata, in quanto oggi rischia di suonare falso il tono di qualsiasi narratore che supponga di sapere cosa passi davvero per la testa dei suoi personaggi e si arroghi il diritto di commentare, o addirittura valutare, le loro scelte morali e culturali.
Ma se certe soluzioni – come quella di un narratore assoluto omnisciente – si rivelano sempre più incerte e insidiose, bisogna forse dedurne che quelle problematiche morali – che costituivano parte integrante della vita di molti grandi personaggi del secolo scorso – siano ormai intrattabili e ingestibili?
Ne Il riccio e la volpe, Isaiah Berlin (nella foto) ricorda come a tutti gli scrittori Lev Tolstoj chiedesse sostanzialmente tre cose: una dose sufficiente di talento; che il tema fosse moralmente importante; e infine che amassero ciò che era degno di amore e odiassero ciò che era degno di odio mentre erano intenti al loro lavoro, ovvero che “s’impegnassero” a conservare la nitida visione diretta dell’infanzia e non distorcessero la loro natura proponendosi di praticare un’imparzialità che era necessariamente illusoria.
Se riguardo al primo punto nulla pare cambiato, essendo il “talento” un termine con il quale siamo soliti designare quanto in campo artistico non è desumibile da altre qualità (e ciò, nonostante l’uso molto parziale e soggettivo che possiamo farne, se è vero che sempre Tolstoj, per esempio, trovava Fëdor Dostoevskij privo di talento, in quanto prolisso e ripetitivo) il secondo ed il terzo aspetto oggi sono considerati trascurabili e poco pertinenti. Dopo gli ultimi grandi romanzi di Robert Musil e Thomas Mann – dove, sebbene in modi diversi, certe tematiche svolgono comunque ruoli essenziali (si può non sottolineare che l’ultimo requisito non poteva già più ritenersi, nelle loro opere, pienamente soddisfatto) – gli elementi cui fa riferimento Tolstoj costituiscono canoni piuttosto improbabili, che solo dando prova di un certo coraggio si possono riproporre quali riferimenti credibili per i romanzi futuri.
A parziale conforto di questa impressione apparve, su un altro numero del Corriere della sera, sempre di qualche anno fa, un articolo sulla narrativa del novecento nel quale Raffaele La Capria metteva in guardia dal culto delle forme talentuose e dalla proliferazione gratuita degli esercizi stilistici, evidenziando anche lui, indirettamente, come il primo requisito richiesto da Tolstoj sia ormai l’unico ancora riconosciuto, ma nel contempo rimarcando come esso, se disgiunto dagli altri due, perda gran parte del suo valore e della sua efficacia.
Su questa linea si pone anche Ivan Turgenev, il quale, nelle sue Memorie letterarie, pur considerando il talento un requisito necessario in ogni produzione letteraria degna di menzione, dice che da solo non basta, perché occorre anche “il contatto costante con l’ambiente che si vuol riprodurre; occorre verità, inesorabile verità verso le proprie emozioni; occorre libertà, piena libertà di idee e di concetti, e, finalmente, occorre della cultura, occorrono delle cognizioni!”.
Ora, sebbene non sembri realistico riproporre oggi il tipo di rapporto che Ulrich o Settembrini avevano con i rispettivi orizzonti culturali – e ciò per il rischio di riprodurre pezzi di un “pantheon” di cui allo stesso narratore ormai sfuggirebbe l’architettura complessiva – a volte si può avere l’impressione che, sviluppando proprio certe soluzioni narrative già adottate da Thomas Mann, Proust, Beckett o Musil (tanto per fare solo alcuni esempi), ovvero riscoprendo le tracce che la riflessione su certi temi può lasciare nella vita dei personaggi, sarebbe possibile rivalutarne la funzione letteraria.
Purtroppo però, ad ogni tentativo si sentono ogni volta riaffiorare le ombre di quei “busti”, così che, dopo l’ennesimo attento esame, si è portati a spiegare la loro ingombrante presenza con la constatazione che il mondo è cambiato e che la società non è più la stessa di allora. Nella nostra le idee vengono coltivate in ambienti sterili e protetti per evitarne eventuali contaminazioni con altre che viaggiano ad altezze e temperature diverse; la comunicazione reale è ridotta ai minimi termini e le regole del gusto sembrano dettate da cenacoli ristretti di intellettuali che hanno in sommo disprezzo il secondo e il terzo dei criteri proposti da Tolstoj. Probabilmente il desiderio d’evitare il “pantheon” risuona nelle orecchie degli autori contemporanei già prima della pagina bianca. Del resto non c’è da stupirsi, se è vero che oggi il discutere spontaneamente e pubblicamente le proprie opinioni è spesso avvertito come inopportuno e che pochissimi hanno il coraggio di sottoporle al rischio di un confronto che vada oltre le felpate alchimie del gergo dei salotti.
Nonostante una simile analisi, non si può tuttavia non ricordare che di un fenomeno del genere si lamentavano già nell’Ottocento Herzen, Belinskij e alcuni loro amici, inducendoci a sospettare che l’attribuirgli oggi tanta importanza potrebbe essere solo l’effetto di un errore di prospettiva da parte dell’osservatore. Per niente rassegnati al cospetto di un simile contraccolpo della memoria, dovremmo però tener fede all’impressione iniziale, considerando l’aspetto quantitativo e statistico del fenomeno in corso, che può prospettare un’autentica mutazione di ordine antropologico e culturale. Nell’ultimo mezzo secolo esso ha infatti subito un’accelerazione così repentina da rendere completamente innaturali, anche in letteratura, ogni riflessione o dialogo culturalmente significativi.
Viene a questo punto del resto in nostro soccorso anche la filosofia di Habermas, riducendo in pillole la quale (e rivoltandola in un modo un po’ malthusiano) si può osservare come la “ragione comunicativa” – che tanto veniva esercitata nella letteratura ottocentesca – faccia oggi registrare uno sviluppo decisamente inadeguato ai progressi della “ragione strumentale”, perché mentre quest’ultima sembra accrescere le sue risorse con esponenzialità geometrica, la prima sopravvive grazie al residuo incremento aritmetico che gli è garantito da vecchi cultori della materia o da giovani presto risucchiati in qualche setta ideologica alla moda.
Quindi, l’ipotesi di poter individuare nelle mutazioni antropologico-culturali sopra citate l’origine del problema risulta corroborata a sufficienza e l’ipotesi dell’esistenza di una soglia quasi invalicabile, oltre la quale nessun pensiero meditante può essere digerito da alcun personaggio o narratore, ci pare complessivamente accertata. Inoltre, il fatto che anche in alcuni tra i più notevoli romanzi contemporanei – come, per esempio, quelli di Yehoshua – certe problematiche, pur essendo presenti, non balzino mai in primo piano – come invece accadeva ne L’uomo senza qualità o ne La montagna incantata, e prima ancora nei romanzi degli scrittori russi dell’Ottocento – di tale invalicabile soglia pare costituire una conferma.
Considerando a questo punto le inesorabili e pessimistiche conclusioni a cui questa breve disamina ha condotto, viene spontaneo chiedersi cosa ci resti da sperare per il futuro. Forse l’avvento di un nuovo Don Chisciotte, che sproloqui ragionevolmente, da solo o in compagnia di qualche buon Sancho Panza, e che si carichi sul collo pensieri e interrogativi anche alti, con la temerarietà e il candore di un vecchio filosofo testardo e assetato d’autentica avventura?
Già! L’avventura. Quella in qualche modo la cerchiamo sempre. La cercava Borges nelle storie di London e di Kipling, dove le biblioteche si trasformavano in foreste, e la cerchiamo noi oggi nella giungla della fantascienza cinematografica. Ma quella vera è anche del pensiero e può venirci solo dall’incontro con “l’altra tigre”: quella meno letteraria, dall’imbattersi in qualche nemico ideale, o in sua mancanza in dei mulini a vento, perché quando tutti si travestono da osti ogni mulino deve essere guardato con sospetto.
Oppure è solo la nostra immaginazione. Un problema fasullo e l’universale, con le sue alternative e le sue scelte obbligatorie, continua a pulsare nei particolari delle diverse narrazioni con le stesse cadenze di sempre.
Aggiornato il 21 ottobre 2019 alle ore 18:16


