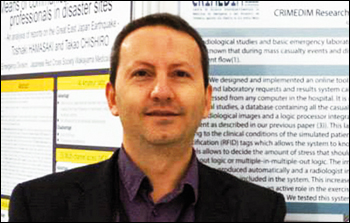
C’è chi l’ha definita una colossale ingiustizia, chi un gravissimo attentato contro la libertà della ricerca scientifica, chi una violazione oltraggiosa dei diritti umani universali: chiunque sia venuto a conoscenza del caso di Ahmadreza Djalali non può non dirsi amareggiato da un episodio così drammatico che racchiude in sé ognuna di quelle definizioni.
Ahmadreza Djalali è un brillante medico ricercatore iraniano di 45 anni, specializzato in medicina dei disastri, che per anni ha lavorato in Europa: in particolare in Svezia, dove risedeva con la famiglia, in Belgio e in Italia. La sua attività scientifica gode di molti meriti e riconoscimenti nella comunità scientifica internazionale, motivo per cui era chiamato a tenere dei seminari in vari Paesi. Spesso il suo lavoro lo portava a spostarsi anche nel suo Paese d’origine, con cui non ha mai tagliato i ponti; e proprio per lavoro si era recato in Iran, su invito dell’Università di Teheran, nell’aprile 2016. Durante quest’ultimo viaggio, però, Ahmad viene arrestato a Teheran con l’accusa di “collaborazione con governi nemici”, reato che in Iran è punito con l’impiccagione. Ahmad trascorre tre mesi nel centro di detenzione dell’agenzia di intelligence iraniana, poi viene trasferito nel carcere di alta sicurezza di Evin, vicino Teheran. In questi mesi, durante i quali è stato sottoposto a duri interrogatori e a forti pressioni psicologiche, ha condotto tre scioperi della fame per affermare la propria innocenza. Le preoccupazioni non riguardano solo le sue condizioni di detenzione e il suo stato fisico e mentale; c’è anche quella che riguarda l’assenza di tutela giudiziaria. Il giudice del “Tribunale della Rivoluzione”, Abolghasem Salavati, dopo aver annunciato, il 31 gennaio scorso, che sarà emessa per lui la condanna a morte, non sembra volergli concedere neanche l’assistenza del suo avvocato di fiducia in udienza. Di fronte all’ennesimo rifiuto da parte del giudice, Ahmad ha ripreso lo sciopero della fame e ha annunciato di voler iniziare anche quello della sete.
Sono dunque giorni di forte preoccupazione per la sua sorte, giorni in cui si dovrà fare il possibile affinché non cali il silenzio sulla sua storia, perché la mobilitazione, anche politica, è l’unica arma che abbiamo per far tornare Ahmad a casa e per difendere la neutralità del progresso, libero da ogni ideologia, consentito appunto dalla ricerca. Intanto cresce il numero delle firme per chiedere la sua immediata scarcerazione, mentre si susseguono gli appelli delle associazioni umanitarie, tra cui quello rivolto dalla Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (Lidu Onlus) e da “Iran Human Rights” ai governi italiano, svedese e belga e all’Alto Rappresentante dell’Unione europea Federica Mogherini e quello di “Nessuno tocchi Caino” al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri italiani. Al momento del suo arresto, Ahmad collaborava ancora con il Crimedim (Centro di ricerca interdipartimentale in medicina d’emergenza e dei disastri) di Novara. Abbiamo quindi voluto approfondire il suo ruolo presso quel prestigioso centro di ricerca parlandone con il suo direttore, professor Francesco Della Corte.
Il contributo che il dottor Djalali ha offerto alla comunità scientifica ha riscosso un elevato interesse a livello internazionale. Tra il 2012 e il 2015 ha lavorato presso il Crimedim di Novara. In cosa consisteva nello specifico la sua attività di ricerca?
In realtà il dottor Ahmad ha cominciato a lavorare con noi nel 2011 come studente dello “European Master in Disaster Medicine” (Emdm), organizzato dal nostro Ateneo. Sulla base della sua brillantezza nel completare questo corso, dal 2012 fino al 2015 ha avuto una posizione come assegnista di ricerca post-dottorato e anche quando è ritornato in Svezia ha continuato a lavorare con noi come docente del master e responsabile del suo controllo qualità. La sua attività di ricerca si è incentrata soprattutto sul ruolo dell’ospedale nelle catastrofi, sulla sicurezza degli ospedali quando esposti a rischi diversi, nonché nella formazione dei professionisti che operano nella risposta ai disastri e nelle crisi umanitarie. Inoltre, Ahmad ha approfondito le tematiche relative alla risposta sanitaria in caso di disastro nucleare e bioterrorismo.
Perché le sue ricerche erano considerate importanti a livello internazionale?
Ahmad aveva studiato il confronto tra diverse realtà internazionali nella pianificazione ospedaliera perché si arrivasse a una sintesi per la loro migliore risposta in caso di esposizione a una condizione di disastro. Anche nella ricerca sulla formazione ha cercato di definire gli aspetti curriculari dei sanitari in diverse realtà internazionali, nel mondo evoluto e nei Paesi maggiormente depressi dal punto di vista economico. La sua capacità di identificare le differenze ha permesso di proporre progetti di studio alla Comunità europea che sono stati finanziati e che hanno garantito quei fondi che ci hanno permesso di svolgere la ricerca all’interno del nostro Centro.
Nell’aprile del 2016, mentre si trovava in Iran in seguito a un invito ricevuto dall’Università di Teheran, Ahmad è stato arrestato con l’accusa di “collaborazione con governi nemici”, accusa per la quale rischia di essere condannato a morte. Quali sono le posizioni del Crimedim nei confronti di questa detenzione?
In primo luogo, al di là della posizione del Crimedim come centro di ricerca, i nostri sentimenti sono rivolti alla persona, un amico sincero, trasparente, un padre e un marito esemplare, di uno stile di vita molto riservato sempre nel rispetto dell’ambiente dove viveva. L’accusa di collaborazione con governi nemici è assolutamente inimmaginabile. Il nostro Centro ha una reale consistenza internazionale. Abbiamo collaboratori che provengono da tutto il mondo, i cosiddetti fellows, nella cui interazione non sono mai avvenuti episodi di contestazione religiosa o politica. Gli studenti del master sono provenuti da più di 70 nazioni diverse, i cui eventuali contrasti mai hanno avuto ragione di esistere nella nostra comunità, dove è sempre privilegiato il rispetto della persona. Nella stessa direzione si pone anche il rapporto con i docenti, che hanno come unica ambizione quella di proporre argomentazioni indipendenti.
Come testimoniato dai suoi colleghi, l’unica “colpa” accertata di Ahmad è quella di aver collaborato con ricercatori provenienti da molti Paesi per migliorare le capacità operative degli ospedali in aree che soffrono la povertà e sono flagellate da guerre e disastri naturali. Se la ricerca scientifica si fonda sui principi di libertà, è giusto porvi delle barriere perché un Paese – in questo caso l’Iran – considera la collaborazione con ricercatori di Paesi “nemici” attività di spionaggio?
Che si possa pensare che confrontarsi su un piano scientifico con colleghi di altre nazioni o di altre realtà politiche o religiose sia un motivo per condannare un ricercatore è abominevole, una visione medioevale della scienza. Se poi il contesto è quello della risposta a situazioni di grandi calamità, di crisi umanitarie, di sofferenza globale, allora questa posizione diventa ancor più insopportabile. Può essere sostenuta come attività di spionaggio quella di confrontarsi con i propri pari per cercare una sintesi mirata alla prevenzione dei danni, alla salute della popolazione, alla resilienza dopo il disastro?
Come si sta mobilitando la comunità scientifica e accademica sul caso di Ahmad?
La risposta è stata impressionante e lo diventerà ancora di più se e quando il caso sarà più conosciuto in ambito internazionale. L’azione è cominciata nella nostra università per poi propagarsi immediatamente in Svezia (dove Ahmad aveva fatto il suo dottorato) e in Belgio (dove la Libera Università di Bruxelles organizza con noi il Master): proclami rettorali, manifestazioni pubbliche, pressione presso le istituzioni politiche nazionali ed europee. Inoltre sono state coinvolte le organizzazioni che tutelano il diritto della persona e che si oppongono alla pena di morte. Sono state raccolte più di 230mila firme per richiedere la sua scarcerazione. Sono state sensibilizzate le fonti di informazione mediatica, che hanno risposto con grande sensibilità, e sono stati raccolti fondi per sostenere e implementare la disseminazione dell’informazione.
Al di là della preoccupazione per lo stato di salute fisico e mentale di Ahmad e per l’esito del processo, la situazione che si è creata potrebbe portare delle conseguenze nella politica di scelta dei collaboratori in seno all’Istituto?
Assolutamente no. La multinazionalità e l’internazionalizzazione del Crimedim sono i suoi punti di forza e non porremo mai barriere di alcun tipo perché studenti da qualunque parte del mondo possano lavorare con noi. Piuttosto potrebbe essere considerata la possibilità di avvertire studenti che provengono dall’Iran che la tutela della loro persona potrebbe essere messa a repentaglio nel momento del loro rientro in patria. Questo potrebbe anche portare a un ripensamento sulle loro richieste, guardando però alla loro sicurezza e non per una posizione discriminatoria.
(*) Responsabile Eventi e progetti della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo
Aggiornato il 08 ottobre 2017 alle ore 19:06


