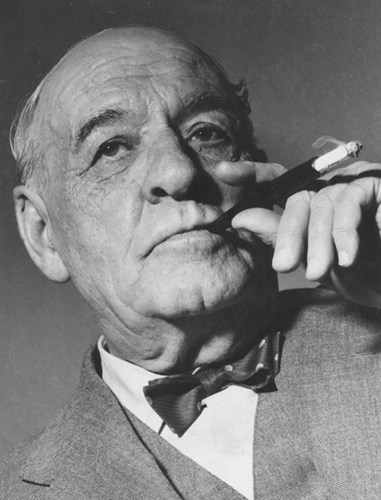
Nel breve saggio Il tempo della malafede, che dà il titolo a un’omonima antologia di scritti (Edizioni dell’asino, 2013), Nicola Chiaromonte prende spunto da Josè Ortega y Gasset per svolgere alcune considerazioni, come suo solito profonde e poco convenzionali, sulla società contemporanea, ovvero su quel tipo di società caratterizzata dalla presenza decisiva delle masse. Il filosofo spagnolo analizza il fenomeno delle masse, protagoniste della storia umana almeno dalla rivoluzione francese in poi, partendo da un’esperienza visiva, e cioè dal “fatto dell’agglomerazione, del pieno”, che descrive così: “le città sono piene di abitanti, le case piene d’inquilini, gli alberghi pieni di ospiti, i caffè pieni di clienti, i parchi pieni di gente che passeggia, i gabinetti dei medici famosi pieni di malati, i teatri pieni di spettatori e le spiagge piene di bagnanti. Trovar posto, che in passato, generalmente, non era un problema, oggi comincia a essere un problema quotidiano”.
Partendo da questa considerazione del filosofo castigliano, Chiaromonte osserva che quest’esperienza del non trovar posto “appare a prima vista un’esperienza angosciosa. Vuol dire subito sentirsi esclusi, o almeno rischiare di esserlo: gli altri sono già lì, occupano tutto, o quasi tutto, lo spazio disponibile. Per trovar posto occorre uno sforzo: bisogna farsi posto, lottare non già per la Vita in genere o contro una difficoltà naturale, ma per uno scopo mirabilmente infimo, che è occupare il poco spazio che ci è necessario”. Inoltre, la vita in comune c’impone, nell’epoca delle masse, di subire tutta una serie d’imposizioni normative e burocratiche e una serie di obblighi impliciti che invadono completamente l’esistenza quotidiana, tanto che si può avvertire come un dovere persino quello di divertirsi.
Ognuno tende a imitare i modelli di svago che solo pochi privilegiati possono soddisfare pienamente, con la conseguenza che si registra un’insoddisfazione generale e diffusa. Persino il riuscire a isolarsi diventa un problema, perché l’uomo solo può essere avvertito come mostruoso. Sperso tra la folla, l’individuo tende così a perdere “ogni sfumatura di pensiero individuale”. In realtà quando l’uomo-massa s’impone nell’era contemporanea non solo l’individuo assume un’importanza minima, non solo la sua esistenza tende a diventare anonima, ma per lui anche gli altri divengono anonimi. Sebbene nessuno realmente lo sia, ci veniamo tutti a trovare in una situazione di anonimità e in questo senso “possiamo dirci tutti eguali, unità indifferenti e permutabili l’una con l’altra”, e ritrovarci a fare quel che facciamo “non perché sia naturale, e neppure perché lo si ritenga positivamente utile, ma piuttosto per evitare le complicazioni e i mali che verrebbero (a sé e agli altri) dall’agire diversamente”.
Siamo tutti più o meno soggetti “a una forza maggiore la quale non deriva né da una norma morale, né dalla somma delle esigenze individuali, bensì semplicemente dal fatto dell’esistenza collettiva. È l’esperienza di un disordine retto da leggi di ferro”. Per questo, la circostanza che caratterizza la società di massa è moralmente estrema ed è sostanzialmente nihilista: si vive reprimendo ogni giorno la questione se “ciò che si fa giorno per giorno abbia un senso”, sapendo che la si reprime, per accorgersi poi che l’esserne consapevoli non ci aiuta a cambiare il corso delle cose. La nostra esistenza non cambia, ma riducendosi a una lunga serie di atti obbligati e indifferenti si rivela “priva di senso, svalutata; e svalutata non tanto rispetto ai ‘valori’ di cultura e di tradizione (i quali si possono sempre in qualche modo coltivare privatamente), ma in se stessa.
Un’esistenza letteralmente ‘incredibile’. E un’esistenza incredibile significa un’esistenza che si protrae in stato di continua malafede”, ovvero in cui ci si trova pressoché sempre in una posizione ambigua rispetto al proprio agire, in cui si fa quel che si fa senza “persuasione e, nel contempo, senza violare alcuna norma intima; ma anche senza osservarne chiaramente nessuna. Si può, a questo punto – conclude Chiaromonte – tornare a ciò che, secondo Ortega y Gasset, distingue la mentalità dell’uomo della massa: il fatto che ‘avere un’idea non significa essere in possesso delle ragioni di averla’ ”. Questo tipo di uomo non si rifiuta di fornire delle ragioni, e vorrebbe anche lui trovare la verità, ma non ha ragioni da dare e della verità non sa prendersi cura. Ha idee sulla sua situazione, ha in genere opinioni prese in prestito da altri, che non sono in genere né false né vere, ma così generiche dal risultare insignificanti.
La cosa forse più inaspettata e preoccupante è però che questa circostanza colpisce anche gli intellettuali. Anche loro si servono del linguaggio corrente, di “concetti belli e fatti, pronti per l’uso”, sedimentati nell’uso di quel linguaggio. Anche gli intellettuali, dal momento che si servono del linguaggio della massa, che “tende ad essere un linguaggio di formule nel quale le parole hanno un valore fisso, puramente indicativo e scarsamente espressivo”, tendono ad articolare pensieri già pensati secondo automatismi linguistici prestabiliti, e cioè a servirsi di quello che Martin Heidegger definiva “pensiero calcolante” (Rechnendes Denken), senza quasi mai accedere a ciò che invece lo stesso Heidegger definiva “pensiero meditante” (Besinliches Denken). In effetti, per Heidegger, come per Chiaromonte, l’assenza di questo tipo di pensiero è un ospite inquietante che si annida dappertutto nel mondo di oggi ed è alla radice della peculiare forma di nihilismo che lo contraddistingue.
Il lavoro culturale, il lavoro dello spirito, non può non risentirne in maniera sorda e non meno inquietante. La cultura, che ha nel corso dei secoli sviluppato e affinato capacità critiche e attitudini dialogiche, invece di essere quel luogo ideale in cui si “disputa intorno alla verità”, assomiglia a quello in cui il pensiero calcolante declina dei paradigmi teorici dogmaticamente assunti. La verità appare invece per Chiaromonte “soltanto nell’esperienza vissuta, nel riuscire a vivere sentendosi in qualche modo d’accordo con la natura delle cose e del mondo”, e non nel saper articolare in modo più o meno abile o brillante formule linguistiche preconfezionate.
Quella in cui ci troviamo è un’epoca di stereotipi collettivi sempre più diffusi e pervasivi, sempre più acriticamente riutilizzati, e secondo Chiaromonte non può mutare in seguito alla scoperta di qualche idea geniale, ma solo esercitandosi a dialogare con “l’ordine del tempo”, o con il suo “disordine retto da leggi di ferro”. Può cambiare cioè soltanto “a forza di soffrire in comune la sorte comune, cercando di comprenderla”, e tuttavia sempre conservando la consapevolezza che “dalla caverna, non si esce in massa, ma solo uno per uno”.
Aggiornato il 24 agosto 2020 alle ore 13:39


