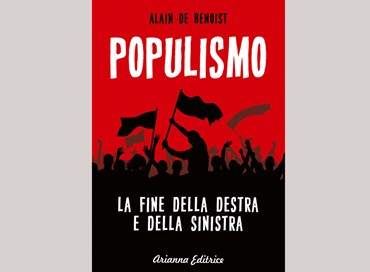
Con il consueto acume, Alain De Benoist nel suo libro “La fine della destra e della sinistra” (Arianna editrice 2017, pp. 297, 14,50 euro), dà una lettura del populismo, termine abusato (e strumentalizzato), cui corrispondono diversi significati. Da chi lo considera sinonimo di demagogia (è il più condiviso dalla stampa vicina alle élite decadenti) a chi lo ritiene soprattutto uno “stile” del rapporto tra capo/i e seguito, ovvero una reazione di classi e individui in discesa sociale. La tesi di De Benoist (della quale è stato anticipatore da oltre vent’anni) è che il populismo sia l’emergere di una nuova opposizione politica, con diversi protagonisti. Onde la vecchia, ossia la destra e la sinistra, borghese e proletario del “secolo breve”, è progressivamente neutralizzata e politicamente de-potenziata.
Diversamente tuttavia da qualche decennio fa, quando l’ipotesi di un emergere di soggetti politici al di là della contrapposizione destra/sinistra era una brillante intuizione, ma da consolidare dai fatti, oggigiorno siamo saturi di conferme. Di fronte alla crescita costante in Europa e negli Usa del fenomeno “si conferma dappertutto l’ampiezza del fossato che separa il popolo dalla classe politica al potere. Ovunque emergono nuove divisioni, che rendono obsoleta la vecchia divisione destra-sinistra”. In pochi decenni i sistemi politici, basati da molti decenni sugli stessi partiti sono stati completamente sconvolti “In Italia la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista sono praticamente spariti. Lo stesso dicasi dei vecchi partiti di governo greci. In Spagna, negli ultimi anni, il Psoe e Alleanza popolare si sono continuamente indeboliti a vantaggio di Podemos e Ciudadanos... In Austria, i due partiti di governo – socialdemocratico e cristiano-sociale – hanno raccolto solo il 22 per cento dei voti all’elezione presidenziale del 2016”. Gli operai e il “popolo minuto” che in maggioranza votava per i partiti di sinistra, concede la maggioranza dei suffragi ai populisti “il comportamento dei partiti, ne trae le conseguenze. A questa apparente “destrutturazione” dell’elettorato corrisponde, al livello degli Stati maggiori politici e delle squadre di governo, un prodigioso spostamento verso il centro, cui per natura spinge il bipartitismo”. Alla ricerca di un consenso decrescente e, talvolta, definitivamente perduto.
Ma il consenso, in democrazia in ispecie non è tutto, “in primo luogo perché la democrazia non è l’estinzione del conflitto, ma il conflitto padroneggiato. Affinché una società politica funzioni normalmente, ci dev’essere evidentemente un consenso sul quadro e sulle modalità del dibattito... Ma se il consenso fa sparire il dibattito stesso, allora allo stesso tempo sparisce la democrazia perché, per definizione, essa implica, se non la pluralità dei partiti, almeno la diversità delle opinioni e delle scelte, insieme con il riconoscimento della legittimità di un conflitto tra queste opinioni e queste scelte... Ciò significa che, contrariamente a quanto credono i fautori di una democrazia “non partigiana” o “di buona governance”, la democrazia non è solubile nel procedurale, perché ha una forma inevitabilmente agonistica... Il prezzo del consenso è “la diserzione civica”. Il rischio che ne consegue è che la democrazia muoia di sbadigli: cioè nell’anomia sociale. “Crescerà allora il rischio di vedere realizzare non una società pacificata dal “consenso”, ma al contrario una società pericolosa e potenzialmente belligena, in cui non ci si dovrà sorprendere di vedere un ritorno vigoroso, in forme talvolta patologiche, di altre modalità di affermazione identitaria (religiosa, etnica, nazionale ecc.), che non deriveranno da chissà quale desiderio di “pericolosa purezza”, ma saranno la conseguenza logica del fatto che ormai non è più possibile affermarsi come cittadini”.
Le conclusioni di ciò, e tenuto conto che il sentimento politico non è solo uno degli elementi del “triedro della guerra” di Clausewitz, ma una generale condizione della politica (e più ancora della democrazia) da Machiavelli a Freund e Duverger, è, in termini politici, la frattura tra classe dirigente e popolo, la secessio plebis risolta da Menenio Agrippa e della quale l’emergere populista ha tutte le caratteristiche. È infatti una crisi squisitamente politica, una crisi di legittimità: “Settori sempre più grandi del popolo si sentono esclusi, incompresi, disprezzati, dimenticati. Hanno l’impressione di essere divenuti inesistenti, di essere superflui, di essere “di troppo”. Non sopportano più le formule rituali e i mantra del “politicamente corretto”, strumento delle leghe neopuritane e dello Stato interventista, igienico e punitivo”. Dall’altra parte come scriveva il compianto Paul Piccone la principale caratteristica dell’oligarchia in declino è di proporsi “detentrice di una conoscenza superiore e universalmente valida, atta a legittimare quella che essa considera come una razionalizzazione altamente necessaria della società”. “Questa frattura sociale”, aggiungeva Piccone “osservabile non soltanto a livello locale ma anche su scala globale, genera un tipo di disuguaglianza molto più profondo di tutto ciò che il vecchio capitale era mai riuscito a creare”. Scrive il pensatore francese, “la caratteristica fondamentale del populismo è questa: è strutturato intorno a un’opposizione non più orizzontale (destra-sinistra), ma verticale: il popolo contro le élite, le persone comuni “in basso” contro i privilegiati “in alto”. Questa opposizione non è riducibile a un riciclaggio del vecchio rancore poujadista dei “piccoli” contro i “grossi”, ma si basa sulla convinzione che una élite tecnocratica e finanziaria, insediata nei mezzi d’informazione come nei corridoi del potere e fondata sulla connivenza incestuosa, quando non sulla corruzione, ha deliberatamente deciso di spossessare gli elettori del loro potere per sottrarre i suoi maneggi ad ogni controllo”.
Quindi non un malessere passeggero ma la conclusione di un ciclo storico-politico con l’esaurimento delle vecchie élite e l’affacciarsi al potere delle nuove, fondate su diverse opposizioni e altro ordine. Ordine il quale prende forma anche dall’opposizione e da quello che Schmitt chiamava il Zentralgebiet. Così l’opposizione cattolici/protestanti tipici delle guerre di religione (XVI-XVII secolo) fu risolta istituzionalizzando il principio di tolleranza, quella tra borghesia e monarchia (ancien regime) con lo Stato rappresentativo del XIX secolo, quella borghese/proletario col compromesso fordista (socialdemocratico). Perché come scrive De Benoist nel passo primo ricordato, i conflitti non si estinguono (specie, ma, non solo, in democrazia) ma si “padroneggiano” con istituzioni, norme, prassi di governo. Ossia si relativizzano rispetto all’esistenza e capacità di decisione ed azione della sintesi politica.
Questo, in breve: ma come in tutti i libri di De Benoist, c’è molto di più di quanto scritto in questa modesta e sintetica recensione.
Aggiornato il 14 settembre 2017 alle ore 12:00


