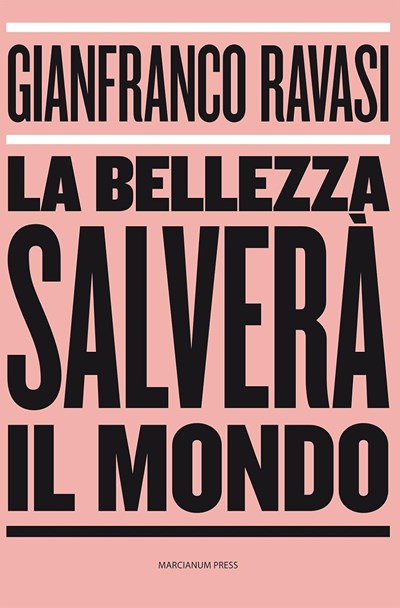
mercoledì 1 ottobre 2025
Il libro del cardinale Gianfranco Ravasi La bellezza salverà il mondo prende spunto dal capitolo quinto della terza parte de L’idiota di Fëdor Dostoevskij, ma attinge a una serie di riflessioni di molti altri grandi scrittori e pensatori appartenenti a secoli e culture diverse. Questo breve saggio, denso di implicazioni etiche, estetiche e religiose, è in linea con il messaggio che il Concilio vaticano II lanciò a tutti gli artisti l’8 dicembre 1965: “Il mondo in cui viviamo ha bisogno di bellezza per non oscurarsi nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette gioia nel cuore degli uomini, è il frutto prezioso che resiste all’usura del tempo, che unisce le generazioni e le congiunge nell’ammirazione”. Già nell’Antico Testamento, nella pagina di apertura della Bibbia, si dichiara che dopo la creazione “Dio vide che era cosa buona (tôb). Questo aggettivo della lingua ebraica – spiega Ravasi – è presente 741 volte nell’Antico Testamento e viene tradotto nell’antica versione greca della Bibbia detta dei Settanta in tre diversi modi”. Il primo termine utilizzato è καλός, cioè “bello”, ma talora possiamo trovare anche il termine αγαθός, cioè “buono”, e in altri casi ancora possiamo trovare il vocabolo χρηςτός, che significa “utile”, “prezioso”, “significativo”. Il creato, dunque, “non è solo buono, ma anche bello e significativo”. Da questi diversi riflessi semantici derivano secondo Ravasi lo stupore che ciascuno è capace di provare di fronte al mondo e l’ammirazione che nasce spontanea in ognuno verso ogni forma di bellezza.
Del resto, le cose non stavano per Platone in modo molto diverso: nel Filebo affermava infatti che “la potenza del bene si è rifugiata nella natura del bello”, e non staranno in modo sostanzialmente diverso nemmeno per Immanuel Kant circa 2000 anni dopo, almeno alla luce di quanto scrive nella Critica del giudizio, dove afferma “che il bello è il simbolo del bene morale”. Sarebbe tutto abbastanza chiaro se ci fosse un accordo su cos’è la bellezza, ma tale accordo, almeno a prima vista, non c’è. Secondo alcuni, come per esempio Ezra Pound, la bellezza è qualcosa d’ineffabile: “Non ci si mette a discutere su un vento d’aprile, quando lo si incontra, ci si sente spontaneamente rianimati, così come quando s’incontra un pensiero folgorante di Platone, oppure si incontra il profilo affascinante di un volto femminile o di una statua”. Se poi ci riferiamo in modo particolare al bello artistico, sembra che anche altri ne abbiano avuto un’idea non meno sfuggente: secondo Jules Laforgue “l’arte è l’ignoto”, mentre secondo Paul Klee essa “non rappresenta mai il visibile”. Ravasi, sembra però piuttosto convergere su una splendida metafora di Antoine de St Exupéry, per il quale la bellezza è il “nodo d’oro” che “coniuga mistero e realtà”, e quindi, anche “il divino e l’umano, il bene e il male, la gioia e il dolore, il sorriso e le lacrime, il mistero della grandezza e della miseria dell’uomo”. Perché quest’unione di opposti apparentemente inconciliabili prenda vita è necessario però che ci sia un’armonia, uno stare insieme mediante legami simbolici, capaci per loro natura di dare forma e corpo a ciò che la presenza diabolica tende invece a tenere diviso e a frantumare, sino a rendere la bellezza irriconoscibile.
L’arte sacra è sempre partita da questa consapevolezza e lo stesso linguaggio figurato usato da Cristo ne costituisce un esempio eloquente. La sua capacità di rapire l’uditorio era legata ad un uso spiccatamente simbolico e al tempo stesso semplice e a tutti accessibile della sua lingua madre, un uso molto diverso da quello di cui si sono serviti poi nelle loro lingue predicatori in ogni parte del globo, tanto da meritarsi il giudizio tagliente di Voltaire, secondo il quale “l’eloquenza sacra delle prediche è come la spada di Carlo Magno, lunga e piatta, perché i predicatori quello che non sanno dare in profondità te lo danno in lunghezza”. Di fronte a questo tipo di ridondanza retorica, la parola del Cristo rimane invece semplice, sonora, evocativa e musicale, e diviene così il suo volto più autentico. In questo senso si può comprendere meglio quanto San Paolo scrive ai Colossesi: “Egli è immagine (εικόν) del Dio invisibile”. Un’immagine che molti grandi artisti, tanto a oriente, nella Chiesa greco-ortodossa, quanto a occidente, nella Chiesa latina hanno saputo raffigurare in modo mirabile.
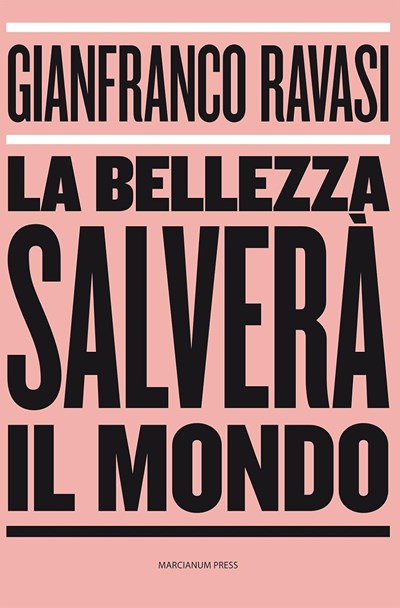
Fu Giovanni Damasceno a battersi per salvare le immagini e la possibilità stessa di raffigurare la parola di Cristo fatta carme, tanto che poi Marc Chagall arrivò a osservare che “i pittori per secoli hanno intinto il loro pennello in quell’alfabeto colorato che era la Bibbia”, dove ciascuno poteva trovare strumenti preziosi per avvicinarsi a ciò che Carl Gustav Jung definiva il proprio Sé. Così, per esempio, la Meditazione sulla passione, dipinto di Vittore Carpaccio diviene per Søren Kierkegaard un segno personale in grado fargli trovare nel libro di Giobbe un prezioso nutrimento per la propria anima, un riferimento in grado di fargli compiere quel decisivo “salto nell’ignoto” che ogni autentica fede cristiana implica. L’arte riesce infatti a “rendere visibili risonanze segrete del testo sacro, a riscriverlo in tutta la sua purezza”, così come riesce a fare, secondo Gaston Bachelard, lo stesso Marc Chagall quando legge la Bibbia con i suoi quadri, dove “subito i passi biblici diventano luce”.
Ma un discorso simile a quello che può farsi per l’arte figurativa può essere fatto anche per la musica. Opere come il Jephte di Giacomo Carissimi, o i Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi, o la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, la Passione secondo Luca di Krzysztof Penderecki o i Chichester Psalms di Leonard Bernstein riescono a far accedere alla dimensione del sacro dalla porta principale e più diretta, e il “Laudate dominum in fa minore dei Vespri solenni di un confessore (K 339) di Wolfgang Amadeus Mozart riesce a ricreare la carica teologica e spirituale, ebraica e cristiana del salmo come non saprebbe mai fare nessuna esegesi testuale diretta”. Eppure, ai nostri giorni purtroppo “assistiamo a un divorzio tra bellezza e fede” senza precedenti, tanto da indurre Padre David Maria Turoldo a sostenere che molte nostre chiese “assomigliano a garage sacrali, dove è parcheggiato Dio, mentre i fedeli sono allineati davanti a lui”. Nelle chiese di oggi, potremmo aggiungere, molto raramente si attinge allo straordinario patrimonio musicale racchiuso nella storia della musica sacra: in genere si preferisce far ricorso a repertori più agevoli, ad opere prive di qualsiasi rilievo estetico e artistico, quando non addirittura a stanche e melense cantilene in cui nemmeno con le migliori disposizioni all’ascolto si può scorgere traccia della voce di Dio.
In questo scenario piuttosto desolante, pare a Ravasi che la Fede abbia “intrapreso un percorso solitario”, mentre a sua volta l’arte sembra essersi rinchiusa “in ricerche stilistiche di elaborazioni del tutto autoreferenziali che hanno cercato la provocazione diretta attraverso forme esoteriche, stravaganti e incomprensibili”. Ma con una simile autoreferenzialità l’arte rischia non solo di separarsi della religione e dall’esperienza di Dio, ma anche dalla sua più profonda vocazione spirituale. Quando Herman Hesse affermava, in Klein e Wagner, che “arte significa dentro ogni cosa mostrare Dio”, o Henry Miller scriveva che “l’arte non insegna niente, tranne che il senso della vita”, alludevano probabilmente entrambi al fatto che della vita l’arte racchiude tutte le contraddizioni senza dissiparne il senso nel reciproco annullamento dei suoi opposti. Come Dostoevskij ci ha insegnato, la bellezza, attraverso l’arte, racchiude gioia e dolore, e se la bellezza potrà salvare il mondo è perché, come spiega ancora Ravasi nelle righe conclusive del suo saggio, “la bellezza affascina il cuore, ma anche lo trafigge, in un abbraccio suadente e mortale dove gli opposti si toccano”, dove si muovono le tenebre e dove risplende la luce.
(*) La bellezza salverà il mondo di Gianfranco Ravasi, Marcianum Press editore 2013, 56 pagine, 5,70 euro
di Gustavo Micheletti