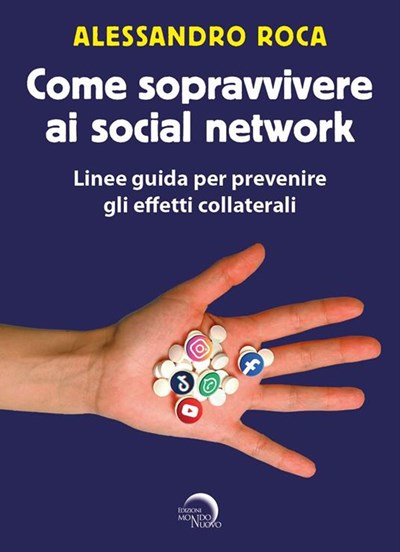
giovedì 11 settembre 2025
Alessandro Roca è un neurologo che si è dedicato a lungo allo studio degli effetti dei social media e che gestisce un blog di approfondimento scientifico e di attualità (DysTO-PICS.it). Uno dei meriti principali del suo saggio, da poco uscito in libreria, Come sopravvivere ai social network. Linee guida per prevenire gli effetti collaterali (edizioni Mondo Nuovo, Pescara 2025), è costituito dal confermare ciò che in molti sospettano, supportandolo però con i dati ricavati da ricerche svolte con rigoroso metodo scientifico. In questo modo Roca risponde a tante domande che in molti, più o meno esplicitamente, si sono poste.
Per esempio, questa: le notizie hanno la stessa velocità di diffusione indipendentemente dal fatto che siano vere o false? No, le fake news presentano una maggiore probabilità (70 per cento) di essere condivise rispetto alle notizie vere e tendono a raggiungere più utenti rispetto alla verità in tutte le categorie d’informazioni. Ad esempio, le catene di notizie false, specialmente quando riguardano la politica, raggiungono molte più persone delle catene di notizie vere, dimostrando che in questo campo le fake news godono di un indubbio vantaggio, che però non è imputabile al mezzo, quanto piuttosto alla pregressa faziosità degli utenti.
A confermarlo, c’è anche un altro dato interessante evidenziato da Roca, costituito dal fatto che “strumenti automatizzati di diffusione delle news (chatbot) ottengono la stessa velocità di diffusione per notizie vere e false, il che implica che le fake news si diffondano così velocemente per colpa degli esseri umani piuttosto che per i bot”.
Alcuni studi hanno poi dimostrato che “i post sui social media che contengono un linguaggio emotivo hanno più probabilità di essere condivisi” e che “l’insulto a soggetti esterni alla propria fazione è un forte predittore del coinvolgimento di altri utenti su piattaforme come X e Facebook.” In questo modo, i social media finiscono col costituire una cassa di risonanza delle proprie opinioni, radicalizzandole.
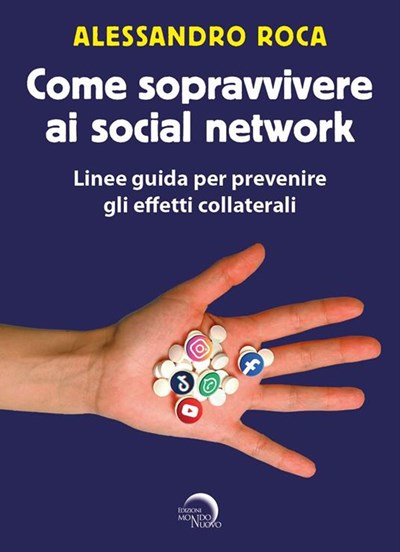
Gli studiosi hanno definito “omofilia” questa tendenza delle persone ad affiliarsi ai propri simili. Sebbene non tutte le piattaforme facciano registrare gli stessi indici di omofilia – per esempio in X se ne possono riscontrare percentuali più elevate che su Facebook – questa tendenza è diffusa su tutti social media e sembra potenziare una tendenza biologica innata negli esseri umani: quella di cercare una qualche forma di riconoscimento da parte dei propri simili.
L’indignazione morale è uno dei modi più efficaci per ottenerla, specialmente in ambito politico, dove la presunta mancanza di moralità degli altri consente a ciascun gruppo di collocarsi su un piano moralmente più elevato. Da una forma estremizzata di quest’atteggiamento nascono gli haters, cioè “quegli utenti che attaccano in modo indiscriminato le persone che esprimono opinioni diverse dalla loro” e che riescono a ottenere in questo modo “un alto tasso di partecipazione polarizzando il social network circostante, in un senso o nell’altro”.
Gli studiosi della Annual Review of Psicology che sono giunti a queste conclusioni ritengono che per mitigare questi fenomeni connessi all’uso dei social network ci vorrebbe una loro maggiore regolamentazione a livello internazionale e anche la promozione di interventi atti ad arginare “fenomeni come la disinformazione o la polarizzazione, ad esempio favorendo la denuncia dei contenuti hateful e delle news”, e “incentivandoli a condividere contenuti accurati, verificati e con emozioni positive, modificando alcune caratteristiche del funzionamento degli algoritmi”.
In linea più generale, sarebbe senz’altro utile informare tutti gli utenti, ma specialmente gli adolescenti, dei rischi connessi a un uso scorretto di strumenti che maneggiano ogni giorno per diverse ore al giorno. Tuttavia, alcuni interventi di questo tipo sono già in via d’attuazione da tempo e purtroppo non pare che fino ad oggi siano stati in grado di produrre i risultati sperati. Questa circostanza, che non consente di nutrire grandi speranze per il futuro, dipende dal fatto che i social network non sono la causa principale dei fenomeni descritti, ma solo gli amplificatori di comportamenti, attitudini e abitudini già largamente presente nella società. I social media, infatti, non creano nulla da nulla, ma si limitano a moltiplicare, forse anche esponenzialmente, quanto è già predisposto ad essere amplificato. Se infatti sono già diffusi nella società dei paradigmi teorici fuorvianti, se sono già attive delle ideologie che tendono con successo a distorcere la realtà e dei riferimenti valoriali che promuovono di fatto una sempre maggiore intolleranza, i social network non possono che amplificarne gli effetti.
Se davvero una comunità politica volesse ridurre tali effetti e indurre un loro uso più corretto, meno atto a radicalizzare e a sviluppare varie forme d’intolleranza e di populismo, come oggi in effetti avviene, bisognerebbe invece per prima cosa che rafforzasse gli anticorpi culturali in ogni suo cittadino, attraverso una formazione critica che lo educhi a comprendere bene gli elementi fondamentali del metodo scientifico, della corretta informazione, del rispetto reciproco e, in definitiva, della stessa democrazia.
Purtroppo non è così, e difficilmente potrà essere così, sia perché i proprietari dei social network non hanno alcun interesse a che sia così, sia perché le maggiori forze politiche hanno tutto l’interesse a incentivare forme di radicalizzazione, dato che è proprio su quella che hanno costruito gran parte del loro successo. Il dare vita alla rivoluzione culturale necessaria nei processi e nei metodi volti alla formazione dei cittadini per metterli in condizione di utilizzare i social in maniera non radicalizzante rischierebbe infatti di risultare impopolare e di comportare svantaggi elettorali insostenibili per qualsiasi forza politica che ambisca a governare il Paese facendo leva su una massa di utenti per lo più già radicalizzata.
Certo, se ogni cittadino leggesse di più, e soprattutto se fosse messo in condizione di saper trovare nella lettura un piacere auto-educativo permanente, se ascoltasse più buona musica, e un po’ meno quella che è intrisa di una violenza latente, se conoscesse i classici del cinema piuttosto che immergersi quotidianamente in film o telefilm attraversati da una violenza non meno evidente, se avesse insomma modo di costruire un proprio robusto profilo culturale in grado di fornirgli gli strumenti critici adeguati anche per conoscere e interpretare in maniera costruttiva la società in cui vive, sarebbe anche più in grado di utilizzare in maniera proficua i social e il web nel suo complesso. Ma così non è, e nulla lascia intravedere la possibilità che la situazione possa migliorare a breve.
In attesa che le misure per evitare i loro più pericolosi effetti collaterali indesiderati sortiscano qualche effetto − cosa di cui, per i motivi che abbiamo detto, è lecito dubitare − bisogna prendere atto che noi oggi trascorriamo mediamente sui social media − secondo i dati riportati da Digital 2025: Global Overview Report − circa 2 ore e mezza al giorno, mentre sono quasi 7 quelle passate complessivamente su internet. Si tratta di ore che sottraggono tempo libero, rendono più ricettivi rispetto alle fake news, peggiorano la qualità del sonno, peggiorano i disturbi dell’umore, peggiorano le funzioni cognitive e provocano un deficit di attenzione che danneggia spesso anche il rendimento scolastico, tendono a sviluppare forme di bullismo e cyberbullismo e sempre più spesso anche disturbi del comportamento alimentare, ma instaurano soprattutto una sostanziale dipendenza che incrementa nel loro complesso tutti questi effetti indesiderati.
Sebbene non siano tutti uguali e non producano in egual misura gli stessi effetti, in forme e misure diverse i social media danno origine a comportamenti disfunzionali specialmente negli adolescenti, ma possono rivelarsi pericolosi per la salute fisica e mentale di qualsiasi loro utente. Sarebbe quindi saggio imparare ad utilizzarli con una certa accortezza e con qualche precauzione, tenendo conto che gli effetti a volte devastanti che possono avere sulla vita dei più giovani costituiscono un campanello d’allarme anche per gli adulti e l’intera società, per quella di oggi e ancor più per quella di domani.
A questo riguardo l’autore racconta un aneddoto significativo: quando, all’alba della rivoluzione industriale, migliaia di minatori scavavano alla ricerca del carbone in precarie condizioni di sicurezza perché mancavano in particolare degli efficienti sistemi di ventilazione ed erano così esposti a intossicazioni spesso fatali, la soluzione a buon mercato adottata dai minatori fu quella di dotarsi di un canarino. Essendo molto sensibile ai livelli di metano e monossido di carbonio nell’aria, se durante gli scavi il canarino mostrava di avvertire qualche sensibile disagio ciò costituiva un segnale di pericolo per i lavoratori, che erano così indotti ad abbandonare in fretta la loro postazione nella miniera.
Sebbene i social media costituiscano virtualmente uno strumento utile sotto molti profili, e sebbene sia poco realistico il pensare di regolarne l’uso avvalendosi di strumenti coercitivi, alla luce di quest’uso ingegnoso dei canarini si può forse comprendere meglio come i danni talora devastanti che i social network possono produrre nella vita dei più giovani “costituiscono la spia di un pericolo che coinvolge l’intera società”, che dovrebbe pertanto avvertire la responsabilità morale e il dovere civico di prendere a riguardo, anche attraverso i suoi rappresentanti politici, contromisure non velleitarie, ma realmente in grado di creare in ogni cittadino gli anticorpi culturali che potrebbero mitigare gli effetti che scaturiscono dal loro quasi fisiologico abuso.
(*) Alessandro Roca, Come sopravvivere ai social network. Linee guida per prevenire gli effetti collaterali, edizioni Mondo Nuovo, Pescara 2025, 194 pagine, 18 euro
di Gustavo Micheletti