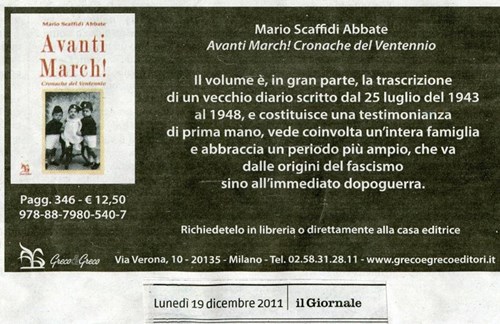
mercoledì 27 aprile 2022
“Il sacrificio della patria nostra
è consumato: tutto è perduto, e la vita,
seppure ne verrà concessa, non ci
resterà che per piangere le nostre
sciagure e la nostra infamia”.
(Ugo Foscolo)
Un sole pallido filtrava sul fondo dello stradone tra la nebbia e il fitto fogliame degli alberi. Non tirava un alito di vento, non un’increspatura in quell’aria sospesa e rarefatta, se non nel punto in cui procedeva il piccolo corteo con tutti quei bambini, protagonisti inconsapevoli di una storia più grande di loro. Mio padre, poiché non era prudente né possibile, con tante persone, servirsi di mezzi di trasporto, che peraltro erano piuttosto rari, s’era procurato una bicicletta sulla quale, a turno, portava i familiari. Seduto sulla sella, le gambe divaricate e i piedi puntati sul terreno, afferrava una delle sue creature e la piazzava in canna, mentre un’altra si accavallava sul parafango posteriore, dopodiché pedalava per due o trecento metri, depositava sul ciglio della strada i passeggeri, che si rimettevano in marcia, e tornava indietro a prelevarne altri due.
Aveva una valigetta con dentro la divisa, la pistola e alcuni documenti, perché, giunti a destinazione, intendeva recarsi in Valtellina, dove i fascisti avevano deciso di organizzare l’estrema resistenza della Repubblica Sociale, trasferendovi governo e forze armate. Quel piccolo esercito procedeva speditamente, per accorciare le distanze e rendere meno onerosa al capofamiglia la già estenuante fatica, mentre mia madre con la più piccola in braccio (che non aveva ancora un anno) camminava al centro dello schieramento tenendo serrate le file. In coda, a mo’ di retroguardia, veniva il terzogenito, pronto a dare l’allarme se mai a tergo sopraggiungesse il nemico.
“E fuggìano, e pareano un corteo nero
che brontolando in fretta in fretta va”.
Sembrava – si parva licet componere magnis – la versione moderna del pio Enea che col padre sulle spalle, il figlioletto allato e la consorte scampava all’eccidio di Troia. Giunti nei pressi di Pontìda ci trovammo davanti uno spettacolo agghiacciante: le strade erano ingombre di morti e di feriti, fischiavano proiettili da tutte le parti, grida di comando, di dolore, d’imprecazione:
“Morte ai fascisti!”.
“Addosso a quei bastardi!”.
E in mezzo a quella strage mia madre come una forsennata, sempre con la più piccola in braccio, correva di qua e di là, chinandosi a destra e a sinistra, se mai tra quei caduti ravvisasse il primogenito, che non era improbabile si trovasse impegnato in quella lotta. Riparammo in una chiesetta, intorno alla quale si ammucchiavano i morti e i feriti. Come arrivammo nei pressi di Cisano Bergamasco, dove si trovavano i nostri parenti (da Castiglione delle Stiviere sono un’ottantina di chilometri) cominciò una sparatoria generale tra i fascisti e i partigiani, finché a un certo punto gli spari cessarono. Sembrava che i partigiani avessero avuto la meglio. Ma come giungemmo davanti alla casa in cui stavano, come ospiti insieme ai padroni i nostri parenti, gli spari ripresero: ora i tedeschi e i repubblichini si ritiravano lungo la strada che passava proprio lì davanti e i partigiani, appostati anche dentro le abitazioni, sparavano contro di loro. A un certo punto, i primi ebbero il sopravvento, e nuovamente la situazione si rovesciò.
Mio zio, terrorizzato all’idea che qualcuno potesse scoprire la nostra identità e prendersela anche con la sua famiglia, impose a mio padre di distruggere ciò che poteva comprometterlo e costare la vita a tutti quanti.
“Presto”, disse: “Innanzitutto la pistola. Hai portato con te la pistola?”.
“Sì”, rispose mio padre.
“Dammela: andrò io stesso a buttarla da qualche parte”.
Fu aperta la valigetta.
“E di questa che ne facciamo?”.
“Bruciare, bruciare!”.
“No, la divisa, no!”.
“Nascondiamola!”.
“Le medaglie? I nastrini?”.
“Date qua, date qua!”, insisteva mio zio.
L’uniforme fu infilata dentro un materasso, la pistola gettata in un pozzo, i nastrini bruciati. E così altre testimonianze di un passato che in un attimo si capovolgeva, diventava infame e disonorevole. Tutto fu bruciato, tutto fu distrutto. Ciò che non si poteva distruggere, che non poteva morire, fu custodito religiosamente nella memoria e nel cuore. Il pianto serrava a tutti la gola. Mio padre era impietrito nel vedere svanire nel nulla i simboli di una fede, i segni di una vita intemerata spesa al servizio della Patria, di un ideale in cui aveva creduto con animo puro e sincero. Erano appena state distrutte quelle sacre memorie, che mio padre si era portato dietro come gli antichi le immagini dei Penati, che cominciarono ad arrivare i primi reparti nemici. Tutti uscivano dalle case, sciamavano sulle strade, esultando, gridando:
“Viva i liberatori!”.
E gettavano fiori su quei soldati stranieri, si accalcavano intorno agli automezzi e stringevano, baciavano, benedicevano quelle mani che avevano seminato morte e distruzione nel Paese, e che ora invece delle bombe lanciavano tavolette di cioccolata e pacchetti di sigarette.
“Come here, come, come!”.
“Viva i liberatori!”.
Nel frattempo Mussolini – che il 18 aprile aveva trasferito la sede del Governo da Salò a Milano – sperava ancora in un miracolo (quello delle ventilate “armi segrete”, a proposito delle quali Hitler aveva detto: “Dio mi perdoni gli ultimi cinque minuti”). Ma i suoi più vicini collaboratori ormai ci credevano poco. L’indomani, a Giulino di Mezzegra, davanti al cancello della Villa Belmonte, Mussolini (questa è la versione ufficiale, ma c’è chi sostiene che vi sia stato portato già morto) veniva sbrigativamente eliminato dall’intraprendenza di un pugno di uomini, i quali – esigua schiera di fronte alla stragrande maggioranza degli italiani che morto non lo voleva, o almeno non in quel modo – vollero così impedire che egli venisse regolarmente processato dagli alleati e tirasse fuori delle prove sulla responsabilità e la complicità che avevano avuto in quel conflitto personaggi italiani e stranieri.
Nella notte del 29 aprile un furgone giallo scaricava sull’impiantito del distributore di benzina di Piazzale Loreto a Milano i corpi del Duce, della Petacci e dei gerarchi giustiziati a Dongo, lasciandoli lì ammassati per terra in una macabra esposizione.
Sul far del mattino cominciò l’assalto. Una folla inferocita si buttò sui cadaveri coprendoli di sputi, di ortaggi, orinandovi sopra, schernendoli e straziandoli nei modi più impensabili e osceni. Il più vilipeso fu il corpo del Duce: chi gli mise una finta corona sulla testa e un finto scettro in una mano, chi gl’infilò nell’altra un gagliardetto nero, chi gli cavò fuori il membro virile e vi sputò. Il gesto più gentile fu quello di una donna che gli afferrò il capo e l’appoggiò sul seno della Petacci. Altri presero a calci le teste dei due “amanti” e una donna esplose contro il cadavere di Mussolini due colpi di pistola.
Alle 11 i corpi dei giustiziati furono issati e appesi per i piedi alla longarina del distributore, “perché la folla voleva veder meglio” (così dichiarò allora all’agenzia Ansa un esponente della Democrazia cristiana). L’indomani sull’Unità si leggeva: “Giustizia è fatta. La carogna del duce dei malfattori, attorniata da un buon numero di accoliti, giace in Piazzale Loreto, esposta alla gogna. Pietà l’è morta! La peste fascista deve essere annientata. Con risolutezza giacobina il coltello deve essere affondato nella piaga, tutto il marcio deve essere tagliato. Non è l’ora, questa, di abbandonarsi a indulgenze, che tradirebbero la causa per cui abbiamo lottato. Pietà l’è morta”.
Ciò che avvenne a Piazzale Loreto fece inorridire persino molti partigiani, che riferendosi agli autori di quegli atti, si domandarono: “È per questa gente che abbiamo combattuto?”. Ferruccio Parri definì quel massacro “roba da macelleria messicana” e un disonore per tutta la Resistenza. Il comandante partigiano (noto per la sua posizione di equilibrio e di moderazione) deplorò il fatto che Valerio, “cresciuto alla dura scuola comunista”, fosse stato “facilmente condotto a procedere in quel modo assolutamente sommario”, aggiungendo che solo Mussolini meritava di essere giustiziato e che “tra i fattori degli avvenimenti vi fu anche la volontà comunista di creare dei fatti compiuti” (come avevano fatto nel Primo dopoguerra, generando loro stessi il fascismo, con le loro stragi e con l’intento di consegnare l’Italia alla Russia (“Farèm come la Russia, farèm come Lenìn”).
Claude Farrère, accademico di Francia, scriverà nei suoi Souvenirs: “Alcuni italiani si sono vendicati di un capo troppo grande per loro, le cui stesse benemerenze apparivano troppo gravose. Dinanzi a quell’uomo erano afflitti da un complesso d’inferiorità insopportabile, com’era accaduto per Napoleone. Duemila anni or sono, per le stesse ragioni, venne ucciso Giulio Cesare”. E Paul Gentizon, nella Defense d’Italie, dirà di Mussolini: “Ha ritemprato la Chiesa nell’ordine dello Stato, ha elargito al duro lavoratore la Carta del suo diritto, ha messo in rispetto lo straniero. Ha tolto alla palude, ovunque, ed alle sabbie, terre da grano. Rifulsero in lui la saggezza di Traiano, l’operosità analitica, volitiva, instancabile di Leonardo, la sottigliezza costruttiva di Machiavelli, la tenace pazienza di Colombo, la possanza dialettica di Oriani. Albergò in lui il sogno europeo di Napoleone. Fu il più grande oratore politico dopo Demostene e lo scrittore più sintetico dopo Tacito”.
Ben diverso sarà su Mussolini il giudizio di molti intellettuali italiani, compresi quelli che lo avevano osannato come una divinità: chi lo definirà “una caricatura grottesca degna soltanto di essere irrisa”, un “buffo del varietà nella parte di un sergente o caporale che mette paura alle reclute con l’esagerata protrusione del mento, la tensione forzosa delle mandibole e il meccanismo dilatatorio delle orbite e delle pupille”, chi “un personaggio da circo equestre”, un uomo che “si sforzava di celare la sua irresolutezza e la sua paura dietro la maschera del condottiero pronto a tutto”, chi un “falsario”, un “fallito”, un “servo”, un uomo “malato di un sentimento vendicativo d’inferiorità”, un “vassalluccio d’intrallazzo”, un “arrivista mediocre”, un “fesso”, un “ladro di pentole e di casseruole a tutte le genti”, un “Maledito Merdonio dictatore impestatissimo”, e così via.
Il più gentile sarà Curzio Malaparte, che nel 1948 scriverà: “Sono felice che Mussolini e tutti i suoi siano morti e sotterrati, che si siano, come si dice e si deve dire, levati dai coglioni. Ora, se non vengono quegli altri porci del comunismo, ho via libera”.
“Lo scempio di Piazzale Loreto – così annotavo quel giorno nel mio diario – non trova riscontro nella storia della più barbara tribù del più barbaro Paese del globo. Mi vergogno di appartenere alla stessa terra di coloro che l’hanno compiuto. Ma nel medesimo tempo mi conforto e mi esalto, poiché più evidente vedo in questa bassezza la grandezza della Storia, la quale spesso ricorre ai vili e ai traditori per innalzare ancora di più la figura della vittima predestinata: loro nel fango e nell’oscurità, Lei nella gloria e nella luce. La Storia è fatta di vittorie e di sconfitte, e nessuno statista, come nessun generale, per quanto grande e lungimirante, può prevedere e dominare gli avvenimenti, perché se da un lato la Storia la fanno gli uomini, gli uomini a loro volta sono fatti dalla Storia, da un insieme di circostanze, di relazioni, di imprevisti, che non possono essere ricondotti ad una sola persona. Questo è ciò che gli storici devono tenere presente, e riflettere se in una trama così complessa e articolata non vi sia la mano di una Provvidenza che muove tutti i fili, e che necessariamente sfugge alla vista corta dei comuni mortali. Non si estrapola un fatto dalla storia di un periodo per denigrare il periodo intero: tutti i fatti sono interconnessi fra loro in una lunga serie di cause e di effetti, i quali a loro volta diventano cause di nuovi effetti e così via”.
Chi soffriva più di tutti era mio padre. Aveva abbracciato con purissima fede quell’ideale, l’aveva servito con una lealtà, un’onestà e persino con una tolleranza nei confronti degli avversari che ben pochi fra i più illustri antifascisti potevano vantare, aveva combattuto tre guerre, era stato insignito delle più alte onorificenze (Sciarpa Littorio, Collare dell’Annunziata, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, Commendatore della Corona d’Italia, Croce di Guerra, Cavaliere della Stella d’Italia), aveva rivestito cariche prestigiose, sempre animato da un tale amore per la Patria che gli faceva trascurare persino la famiglia, e ora doveva vedere non solo crollati ma oltraggiati e derisi quegli ideali di cui per più di vent’anni s’era nutrito!
“In ogni caso”, scriverà mio padre nel suo diario, “è certo che Mussolini ha dato all’Italia più di quanto altri le avessero dato o potessero darle: ha costruito case per il popolo, asili, scuole, ospedali, ha creato opere assistenziali, ha ospitato centinaia di migliaia di bambini nelle colonie estive, ha dato lavoro ai disoccupati, ha fermato l’emigrazione all’estero, ha bonificato la terra, ha sancito i diritti dei lavoratori e risolto la lotta di classe in una collaborazione fra tutte le componenti del lavoro, ha promosso la battaglia del grano e l’autarchia, ha favorito tutti gli accordi internazionali di pace, ha proposto e firmato, a quello scopo, il Patto a Quattro, con Francia, Germania e Gran Bretagna, ha salvato a Monaco la pace. Una guerra perduta non può cancellare tutto questo”.
Uno di quei “giustizieri”, Carlo Simiani, in un libro intitolato I giustiziati fascisti dell’aprile 1945, scriverà: “I partigiani giravano con le sentenze di morte in bianco girate al ciclostile e non facevano altro che scrivervi il nome del condannato. Bastava che qualcuno indicasse un tizio come fascista perché subito questi venisse condannato a morte con procedimento sommario e senza possibilità di produrre prove a difesa. Le condanne venivano eseguite con metodi sbrigativi a raffiche di mitra, molti giustiziati nulla avevano avuto a che vedere con il fascismo, vittime il più delle volte o delle loro ricchezze o di vendette personali. Non c’era paese o località dove non si desse la caccia più spietata al repubblichino anche se si trattava di un povero diavolo che, o per timore o per bisogno, aveva semplicemente aderito al crollato regime senza aver mai fatto nulla di male. In un Cln piovvero 1.640 denunce, che vagliate attentamente ‘da persone di buon senso’ si ridussero a soli quindici casi imputabili”.
Molti furono uccisi non perché fascisti ma semplicemente perché non erano comunisti o non salutavano col pugno chiuso i “compagni” che col fazzoletto rosso al collo sfilavano per le vie. A Moglia, addirittura, furono assassinate dalla “polizia partigiana” venticinque persone solo perché viaggiavano su una corriera della Pontificia Opera di Assistenza. (Si ripetevano, insomma, le violenze del primo dopoguerra, quando i comunisti bastonavano chi non salutava la loro bandiera, o chi non scioperava).
Uno degli eccidi più raccapriccianti fu quello di 126 giovani allievi ufficiali della scuola di Oderzo, trucidati barbaramente sulle rive del fiume Monticano nonostante avessero sottoscritto la resa. Un altro quello di 54 detenuti nelle carceri di Schio, massacrati di notte, nelle loro celle, a colpi di mitra: un fatto così efferato che il comandante americano della zona, il generale Dunlop, disse alle autorità italiane: “Mai prima d’ora il nome d’Italia era caduto tanto in basso. Molti debbono essere a conoscenza di quanto si progettava e di ciò che è stato fatto. È loro dovere verso l’Italia di presentarsi e parlare. Io prometto rapida e severa giustizia verso i delinquenti. Confido che il rimorso di questo turpe delitto li tormenterà in eterno e che in giorni migliori Schio ricorderà con vergogna quella notte spaventosa”.
Un altro orribile massacro fu quello perpetrato da un capo partigiano, Francesco Moranino (detto “Gemisto”), il quale, dopo aver fatto maciullare a colpi di spranghe 61 repubblicani, fra cui ragazzi di 15-16 anni, li fece schiacciare sotto le ruote di un camion o annegare in un canale. Dietro suo ordine furono uccisi anche cinque partigiani e le mogli di due di essi. A Rovetta furono assassinati 43 legionari della Tagliamento, ad Avigliana 33 giovani furono massacrati e gettati in un fosso, a Botticino, in provincia di Brescia, uomini e donne furono seviziati e poi scaraventati in una fossa, a Novara due sorelle, di 15 e 18 anni, prima di essere uccise furono violentate e torturate, a Sondrio alcuni furono segati vivi, altri addirittura crocifissi, chi su un tavolo d’osteria, chi sulla porta di una cascina. Un bambino di 13 anni, dopo essere stato costretto ad assistere alle atroci sevizie e alla morte del padre e del cugino, subì la loro stessa sorte. Nel cosiddetto “triangolo rosso”, o “della morte” (una zona compresa fra Reggio, Modena e Bologna), gli assassinati furono centinaia, né mancarono episodi di stupri collettivi, come quello di una donna violentata da nove uomini.
Un solo nome per tutti: Carlo Borsani, 28 anni, cieco di guerra e Medaglia d’Oro: un idealista, un poeta. Dopo averlo assassinato, i carnefici caricarono su un carro di rifiuti il suo cadavere con un cartello al collo recante la scritta “Fu medaglia d’oro” e lo portarono in giro per le vie di Milano. Di fronte a tutti quei massacri un noto esponente del Partito comunista esclamò con soddisfazione: “Entro tre mesi l’Italia sarà una nuova Repubblica sovietica”. Troveranno un cantore anche i morti innocenti di quei giorni “radiosi”?
Non ho più patria, non ho più famiglia.
Addio speranze e dolci sogni, addio!
Come un infame, un traditore, anch’io
mi appresto al lungo e doloroso esilio.
Dopo cinque giorni di fuga arrivammo a Reggio Calabria, “in più spirabil aere”, per dirla con Manzoni, ma piena di stenti, di miseria e di fame. Cominciava così, in quella terra d’esilio abbandonata dagli uomini e da Dio, il più amaro e disperato capitolo della mia vita, in cui unico conforto mi veniva dai ricordi del passato, che insieme ad altre testimonianze del Ventennio e della mia famiglia paterna andavo registrando in un diario (a completamento di quanto già scritto), come alla ricerca di un tempo e di un mondo ormai perduti per sempre.
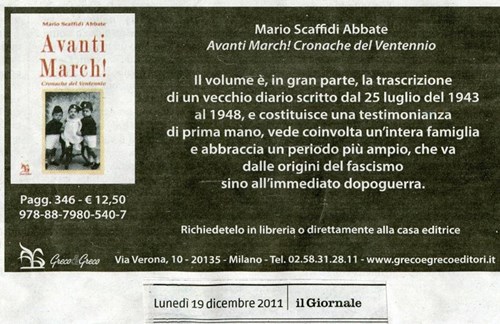
di Mario Scaffidi Abbate