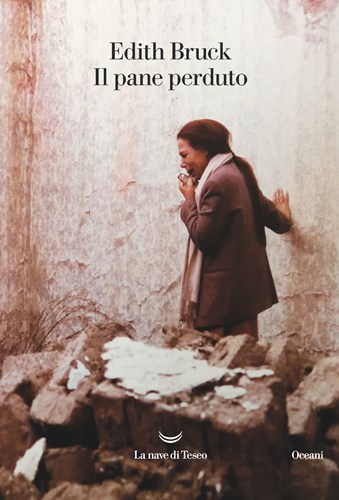
Un romanzo autobiografico? Buono come un pane azzimo appena sfornato quello di Edith Bruck con il suo “Il pane perduto” (Edizione La Nave di Teseo), quando finalmente sei libera per sempre di muoverti, al di fuori della lurida baracca comune del campo di concentramento. Ballerina per caso, scrittrice per volere di quel Dio che soggiace alle sue terribili contraddizioni (buono, vendicativo, assente) nella lettera dell’ultimo capitolo, sempre irraggiungibile, incomprensibile e sinceramente, per molti versi, nemico dell’umanità.
Con Ditke/Edith e le sorelle sopravvissute che incontrano nella nuova terra di Israele le kapò ebree, rifugiate come loro nella terra promessa, e non le denunciano, perché odio chiama odio e la vendetta è una catena senza fine. Come in tutte le storie di giovanissimi internati, la vita li costringe a diventare rapidamente adulti lasciando le madri e i fratellini a sinistra (destinati ai forni crematori) e loro a destra, nuove schiave senza valore alla mercé di un potere smisurato che li considera “pezzi” senz’anima. Per tutti costoro, il “dopo”, la liberazione dal campo è una sorta di auto-decapitazione, in cui la mente rimane per sempre prigioniera del suo passato. Anche qui, come si farebbe tenendo in mano una boule de neige, occorre mettere il globo sottosopra per vedere scendere la neve artificiale su di un paesaggio di rovine, in modo da rendere quello scenario desolato meno mostruoso e inquietante. Come dimenticare quei tre pani appena infornati lasciati a marcire, mentre tutta la famiglia iniziava il suo viaggio infinito verso il Nulla della Soluzione finale?
Edith Bruck è una guida potente, una scrittrice perfettamente illuminata, che scrive libri brevi come piccoli campi arati, fecondandoli con una tale inseminazione di caratteri umani, di storie e di situazioni che mette in risonanza le grandi privazioni affettive e materiali degli ebrei ungheresi perseguitati. Il tempo di lettura proposto rimane perennemente sospeso in attesa di un prossimo evento, che alla fine non verrà perché tutte le storie debbono pur avere un termine.
Leggera e ubriaca come una farfalla senza più porporina, Ditke attraversa con la sorella Judit l’inferno in terra salvandosi più volte dalla morte per denutrizione e dalla selezione. Ma la cosa più straordinaria, quando non sei altro che un numero di serie, è sentirsi chiedere da uno sconosciuto “come ti chiami?”. Il romanzo ricostruisce perfettamente quel diabolico meccanismo di svuotamento derivante dalla perdita di ogni dignità umana, che va dall’abbandono precipitoso della propria casa, al distanziamento progressivo da parte dei compagni di scuola e degli insegnanti che, assieme alla gente comune, mette all’indice degli assoluti innocenti. Il completamento dell’opera di annichilamento avviene poi nei ghetti ebraici, in cui l’insieme delle persone diviene semplice ammasso di materia, senza più intimità, senza altro pudore che non sia quello della ricerca disperata di una sopravvivenza qualunque. Subito dopo, i treni blindati verso la Germania, in cui si arriva a invidiare coloro ai quali viene comandato di svuotare all’esterno i buglioli dei bisogni comuni, cercando di capire dai loro sguardi che cosa hanno visto e capito, rispetto a quella che sarà la destinazione finale di tanta merce dolente.
Poi, il miracolo della gavetta datale bruscamente da lavare dal soldato tedesco in cui era rimasto un fondo di marmellata salvavita, come le bucce di patata e le foglie di cavolo raccolte dagli avanzi della tavola dei dominatori, o direttamente dalla spazzatura, quando il gruppo delle prigioniere più sane viene condotto di fattoria in fattoria, prima della ritirata finale. In quel viaggio del non senso chi si ferma con i piedi e gli arti semi congelati è perduto: un colpo di pistola alla nuca e per lei non ci sarà mai più un ritorno.
Nei campi di sterminio si muore e si prega; ci si ruba il pane tra sorelle, figlie e madri; si lotta disperatamente per qualche goccia in più di una brodaglia disgustosa, alla quale le kapò inservienti hanno sottratto le rare patate e rape lasciate sul fondo. Poi, la liberazione. Gli innumerevoli viaggi; l’arrivo in Israele; l’accoglienza gelida delle sorelle che, come molti, non volevano sentir parlare del dramma epocale dei sopravvissuti e delle loro testimonianze inquietanti, perché ora c’era da realizzare il grande sogno di uno Stato ebraico. I due matrimoni per avere una stanza da soli ed evitare il servizio militare, perché per chi è sopravvissuto ai lager non esiste una buona causa per impugnare le armi! Fare i mestieri più umili; studiare da cameriera per poi servire ai tavoli sotto un padrone dispotico e volgare; investire i propri guadagni per studiare l’inglese per potere andare via.
La fuga da Israele; l’arruolamento in una compagnia di ballo improvvisata che la conduce in tournée ad Atene e Istanbul, per poi transitare per Zurigo. Da lì, il passaggio a una compagnia più strutturata e il salto definitivo: l’Italia, con Napoli e poi Roma dove accetta un lavoro ben pagato in un salone di bellezza in cui, sotto la direzione dell’ennesima megera-kapò, passano molte celebrità dell’epoca compresi attori particolarmente famosi, come Anna Magnani e Ugo Tognazzi.
Ma, finalmente nel frattempo, la sua gestazione di un ventre gonfio di parole e di versi si materializza nel primo libro, a cui ne seguiranno molti altri, consacrando il suo ruolo di scrittrice e avverando così il suo sogno di sempre. Perché, è vero: “Scrivere è vivere”. Solo le cose raccontate hanno una vita eterna, estranea a quella dei loro Autori, ai quali è sempre il romanzo a dire quando il racconto è terminato!
(*) Edith Bruck, “Il pane perduto”, La Nave di Teseo, 128 pagine
Aggiornato il 30 giugno 2021 alle ore 11:23


