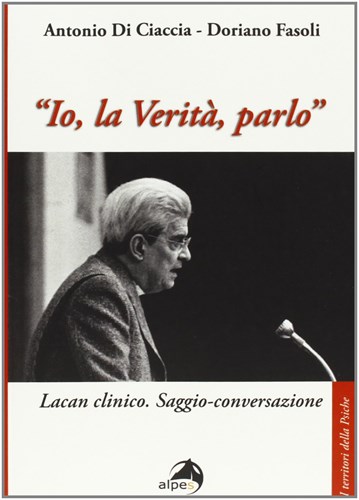
L’incontro tra Antonio Di Ciaccia e Jacques Lacan fu di tipo iniziatico. Una frase intelligente di un giovane studente dell’Università di Lovanio durante una conferenza poi il sentirsi chiamare per nome una sera, durante un ricevimento dell’École freudienne, dallo psicoanalista di cui si parlava allora di più in Francia, in Belgio e in mezza Europa. Questi, “lentamente di scatto”, si voltò verso quel giovane per chiedergli: “mi dica, mio caro, da dove viene, che cosa fa?”.
Nel libro conversazione che ha come titolo una famosa sentenza di Lacan, Io, la verità, parlo, quest’incontro lo si racconta evidenziando gli aspetti e le circostanze più sorprendenti del libero gioco che il caso ama sovente ordire con la necessità. Nello stesso libro si riporta però anche la trascrizione di un’altra conversazione, avvenuta in treno da Parigi a Bruxelles, forse ancor più capace di testimoniare il percorso umano e teorico-clinico di Antonio Di Ciaccia: L’uomo che voleva essere papa.
Che uno psicoanalista possa aver nutrito da bambino questo desiderio, o che qualcuno possa averglielo attribuito, non deve sorprendere: ci sono molte cose che alcuni santi o teologi sanno sulla vita dell’anima cui nessun psicoanalista potrebbe mai accedere se non ne condividesse almeno in parte la vocazione. Forse è per questa segreta affinità che in molti gli pronosticarono un futuro da Papa e che lui stesso poté forse vagheggiare per qualche istante questa possibilità.
Membro dell’École freudienne de Paris e fondatore di Antenne 110 a Bruxelles, l’istituto dove si prendeva cura di bambini autistici e psicotici, Antonio di Ciaccia riesce una volta di più, durante queste conversazioni con Doriano Fasoli, a fornire un quadro chiaro ed esauriente di alcuni concetti chiave della teoria e della clinica lacaniane. “Una volta di più” perché una sua utilissima monografia sullo psicoanalista francese, scritta a quattro mani con Massimo Recalcati, era già uscita in Italia nel 2000, e anche in quel testo alcuni passaggi cruciali del pensiero lacaniano erano stati fatti emergere con esemplare chiarezza.
In questo libro c’è tuttavia qualcosa di più raro e prezioso: c’è il sapore di una vicenda umana prima ancora che professionale, c’è il piacere di condividere la genesi di tale vicenda con il lettore e di renderlo partecipe di motivazioni ed esitazioni che ne hanno segnato il percorso. In esso si traccia non solo un riepilogo significativo di un momento storicamente rilevante della storia della psicoanalisi, ma se ne ridefiniscono le relazioni con altri ambiti dell’esperienza spirituale.
L’arte, la religione e la scienza hanno tutte a che fare con lo stesso buco, con lo stesso vuoto che l’ordine simbolico non riesce a coprire: “la religione lo evita o gli dà un posto – dice Di Ciaccia – sia pure nei tempi dell’escatologia. La scienza non crede che ci sia un vuoto o un buco che non sia suscettibile di essere compiutamente capito e risolto. L’arte invece è una modalità di celebrare questo buco, pur girandovi attorno. In questo l’arte si apparenta alla psicoanalisi” (pp. 73-74).
La parte forse più interessante del libro di Fasoli-Di Ciaccia ci pare tuttavia quella in cui quest’ultimo si sofferma sull’intreccio tra vocazione teologica e vocazione psicoanalitica. In entrambi i casi, e cioè di fronte a Dio o a un “soggetto supposto sapere”, qual è uno psicoanalista per Lacan, non ha senso mentire. Tuttavia, se non ha senso mentire, ciò risulta d’altra parte inevitabile, tanto di fronte all’uno che all’altro, perché ogni dire è in realtà un semi dire e anche la verità enuncia sempre la metà di quel che dice. Il paradosso che finisce con l’attraversare entrambe le posizioni è dunque lo stesso, così come il debito simbolico di cui un tale paradosso scatena gli effetti.
L’ultima occasione in cui Di Ciaccia vide Lacan fu nell’80, dopo il ritorno di quest’ultimo da Caracas. Lo trovò affaticato e ne ricevette un’impressione dolorosa. Nonostante sembrasse spossato nel corpo, era tuttavia ancora presente e lucido. Nell’81, avrebbe dovuto rivederlo il 3 settembre, dopo le vacanze estive, ma ricevette una telefonata in cui gli veniva comunicato che avrebbe potuto incontrarlo solo il 15. Il 9 settembre Lacan morì, lasciando la sua controversa eredità ad allievi sparsi in Europa e in America, specialmente in quella latina.
La sua improvvisa assenza non poteva che evocarne un’altra, assolutamente cruciale nella relazione psicoanalitica: “di solito – dice Di Ciaccia – si vede nell’analisi il versante che viene chiamato transferale, il versante positivo, il versante dell’Altro pieno, dell’Altro a cui non si può fare a meno di fare riferimento. Ebbene, paradossalmente, questo versante è soltanto preliminare all’altro aspetto: il punto fondamentale è quando l’Altro sparisce, quando non c’è più, quando ci si rende conto che l’Altro non esiste” (ivi, p. 19).
Senza questa sparizione dell’Altro, senza il dissolvimento della necessità della sua testimonianza, non v’è accesso a nessun Satori, a nessun disvelamento, a nessuna conclusione di un processo che conduca verso una qualche forma efficace di consapevolezza. Senza l’accettazione della solitudine piena che tale rinuncia comporta non può che continuare ad agitarsi il sospetto che qualsiasi efficacia terapeutica della relazione analitica sia in realtà determinata solo dall’alone magico di un riconoscimento intersoggettivo particolarmente autorevole, mentre in realtà questo potrà risultare pienamente efficace solo se saprà risuonare ad ogni seduta come un paterno, silenzioso e iniziatico abbraccio di congedo.
Antonio Di Ciaccia – Doriano Fasoli, “Io, la verità, parlo”. Lacan clinico. Saggio conversazione, Alpes edizioni, Roma, 2013, pp. 92.
Aggiornato il 04 febbraio 2020 alle ore 12:03


