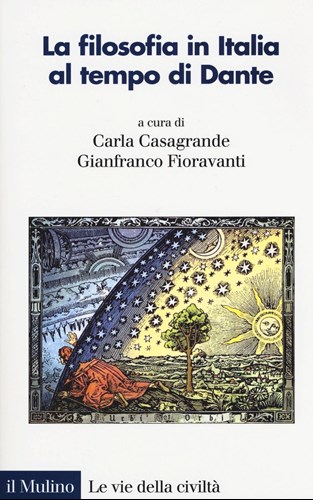
Il Medioevo registrò un radicale cambiamento nel modo di fare filosofia. Severino Boezio, che fu protagonista anche politico nel regno romano-goto di Teodorico, fu l’ultimo di una stirpe di pensatori che, nella storia occidentale, ebbe il suo fondatore in Talete di Mileto. Con l’autore della Consolatio tramontò la figura del pensatore di impianto aristotelico che vedeva nell’otium, nella privilegiata condizione di occuparsi di se stessi e di ciò che più interessa, il pre-requisito della speculazione filosofica.
Naturalmente, nel Medioevo non si smise di pensare; si cambiò il modo di farlo. Al filosofo subentrò il monaco, o il vescovo, o il priore. Nei lunghi secoli bui, il pensiero si rifugiò nelle fredde ma sicure mura dei conventi, proprio come l’abazia benedettina, entrata ormai nell’immaginario comune, dove si svolsero i fatti de “Il nome della rosa”. In quegli ambienti monastici non solo fu preservata la conoscenza frutto di un’altra era del mondo, ma fu garantita anche la possibilità di esercitare la ragione, seppure nell’ambito della scolastica e del suo altissimo campo: la conoscenza di dio e della verità rivelata. Quella della filosofia medievale è la storia della complessa equazione tra scienza e fede, che definì quell’epoca come l’equazione virtù-conoscenza caratterizzò quella antica. Eppure nessuno di quei pensatori-monaci-teologi si definì filosofo, nemmeno il più grande di essi, Tommaso d’Aquino, che sostenne l’unione somma di filosofia e teologia. Per lunghi secoli, pensiero e filosofia rimasero estranei, basti pensare ai commenti sprezzanti di Lanfranco di Pavia in quel di Bec (Normandia), che invitava a cercare la salvezza nell’autorità delle Scritture e nel solo esercizio della fede.
Questo atteggiamento, l’oblio del filosofo, cambia nel XIII secolo. Di questo si parla ne “La filosofia in Italia al tempo di Dante” (Il Mulino, 2016), un’originale libro di Carlo Casagrande e Gianfranco Fioravanti che fa luce su alcuni aspetti poco conosciuti di quell’epoca. Fu quello un secolo di “grande trasformazione” - parafrasando Polanyi - di risveglio delle città e delle attività economiche, guidate dal commercio e da una migliore qualità della vita. All’interno dell’università di Parigi, vi fu il coagularsi di un gruppo di magistri ”che si fregiavano orgogliosamente del nome di filosofi”. In questo contesto, Boezio di Dacia definì gli antichi filosofi “degni di onore” e “al cui impegno rifarsi”, auspicando un generale utilizzo della ragione in tutti i campi del sapere. E così i filosofi riapparvero a Parigi nelle vesti di professori di filosofia.
E in Italia? Gli autori parlano del ritorno della filosofia nel Bel paese documentando l’originale simbiosi tra medicina e filosofia che permise a quest’ultima di formalizzarsi in una dottrina di stampo universitario. Nell’anno domini 1295, un ex magister di Parigi, Gentile da Cingoli, sottoscrisse con uno dei più importanti medici del tempo, Taddeo Alderotti, un accordo che prevedeva di impartire per tre anni lezioni di filosofia nell’università di Bologna, dove si erano sviluppate nel corso di quel secolo due importanti facoltà, una di diritto, l’altra appunto di medicina. Certo, le lezioni sarebbero state extraordinarie, ovvero soltanto complementari e propedeutiche alla ricezione del sapere medico: gli studenti sarebbero stati iscritti a medicina. Ma quell’atto sancì di fatto il ritorno della filosofia in Italia.
Il legame tra filosofia e medicina non fu qualcosa di nuovo, basti penare agli Analitici secondi in cui Aristotele definì la dottrina degli umori che determinava quattro tipi umani. Sui malinconici, i tipi dominati dalla bile nera e che secondo lo Stagirita erano gli uomini di scienza, o di stato, si scriveranno fiumi d’inchiostro; famosi diventeranno i dipinti di Albrecht Durer sulla Malinconia. A Bologna si consolidò il legame tra medicina e filosofia, con quest’ultima messa al servizio di un dibattito che cercava di definire la medicina come scienza. Il già citato Taddeo Alderotti, autore tra l’altro di un’originale traduzione dell’Etica Nicomachea – cosa che mostra la permeabilità a entrambi i campi del sapere, filosofico e medico, degli uomini di scienza del tempo - con un’operazione di sapore boeziano, agganciò in alto la medicina alla scienza naturale, ricevendone i precetti teorici, dall’altra a un’azione empirica più vicina alla sensibilità de medico che entrava in contatto con il paziente da curare. In questa direzione si muoveranno altri importanti contributi come il Conciliator del medico-filosofo-astrologo Pietro d’Albano, o la concezione di Bartolomeo da Varignana secondo cui la medicina era “la più teorica delle arti e la più pratica delle scienze”.
Se prima di quel periodo il confine tra arte e scienza era qualcosa di labile, come del resto era labile la definizione di tecnè presso gli antichi che oscillava appunto tra arte pratica e attività più metodica, con l’esperienza di Bologna vi fu l’instaurarsi di un principio che vale tuttora: il medico diventa tale dopo aver compiuto un percorso istituzionale nell’ambito universitario, che prevede il raggiungimento della qualifica di dottore.
La riflessione filosofica ritornata in auge, sganciata dai problemi scolastici, riguardò ulteriori campi del sapere, come il diritto e soprattutto la politica, attraverso uno stretto legame, come osservò Jürgen Miethke, tra pensiero politico ed epistemologico. Protagonista di questo rinato interesse, neanche a dirlo, fu sempre lui, il filosofo per antonomasia del XIII secolo, Aristotele, i cui scritti furono messi al centro della riflessione non solo in ambito universitario, ma anche da alcuni circoli di Frati Minori. Lo stesso Dante frequentò questi ambienti, a partire dalla morte della sua amata Beatrice, in particolare le scuole domenicane di Santa Maria Novella e quella francescana di Santa Croce, al fine di migliorare la sua conoscenza.
Molto attuale sembra la posizione del fiorentino e domenicano Remigio de’ Girolami (“si no cives, no homo”), secondo il quale la decadenza di quel tempo era da imputare in uno scarso senso del bene comune soverchiato dall’interesse particolare. Forzando la posizione aristotelica, Remigio conclude che il sommo bene della comunità, il bene capace di mettere tutti sulla buona strada della felicità, sia la pace. Concetto presente anche nel de Monarchia di Dante: la pace non si identifica con la felicità, ma ne è il miglior requisito. Avanzata è la posizione di Tolomeo da Lucca che, rifacendosi all’esempio della Roma repubblicana, auspica una limitazione dell’autorità dei governanti: le decisioni politiche, per Tolomeo, sono “il frutto dell’incontro di diverse volontà” che si armonizzano con lo strumento delle leggi o delle elezioni generali. Su questo filone si misura anche la speculazione del Defensor pacis di Marsilio da Padova.
Lo stesso Convivio di Dante si fonda su una posizione pedagogico-politica che mette al centro l’importanza dell’accrescimento morale degli uomini, i quali devono nutrirsi di “cibo spirituale – concetto che riprenderà molto tempo più tardi Simone Weil. Per il Sommo Poeta vi è uno stretto legame tra comunità politica e felicità: e così gli uomini hanno bisogno gli uni degli altri per vincere i gravami della necessità e vivere in armonia. Per realizzare questi fini è importante la nobiltà d’animo, che non è una qualità materiale che deriva dagli antenati, ma una condizione dello spirito volta al perseguimento della giustizia e alla ricerca dei valori più alti, che possono così fondare una coesistenza armonica e pacifica.
Una filosofia, dunque, messa al servizio dell’uomo e della sua esistenza pratica, volta al perseguimento della felicità, secondo quello schema antico che vedeva la coincidenza della virtù, con la sapienza e dunque con la felicità. Quella di Gianfranco Fioravanti e Carla Casagrande è un’opera da assaporare, che fa luce su un tempo di grande fascino, disvelandone alcuni aspetti di grande attualità: un’opera da leggere, da interiorizzare e da utilizzare come buon farmaco per tanti mali del mondo attuale.
Aggiornato il 16 febbraio 2018 alle ore 12:42


